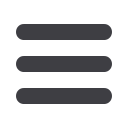
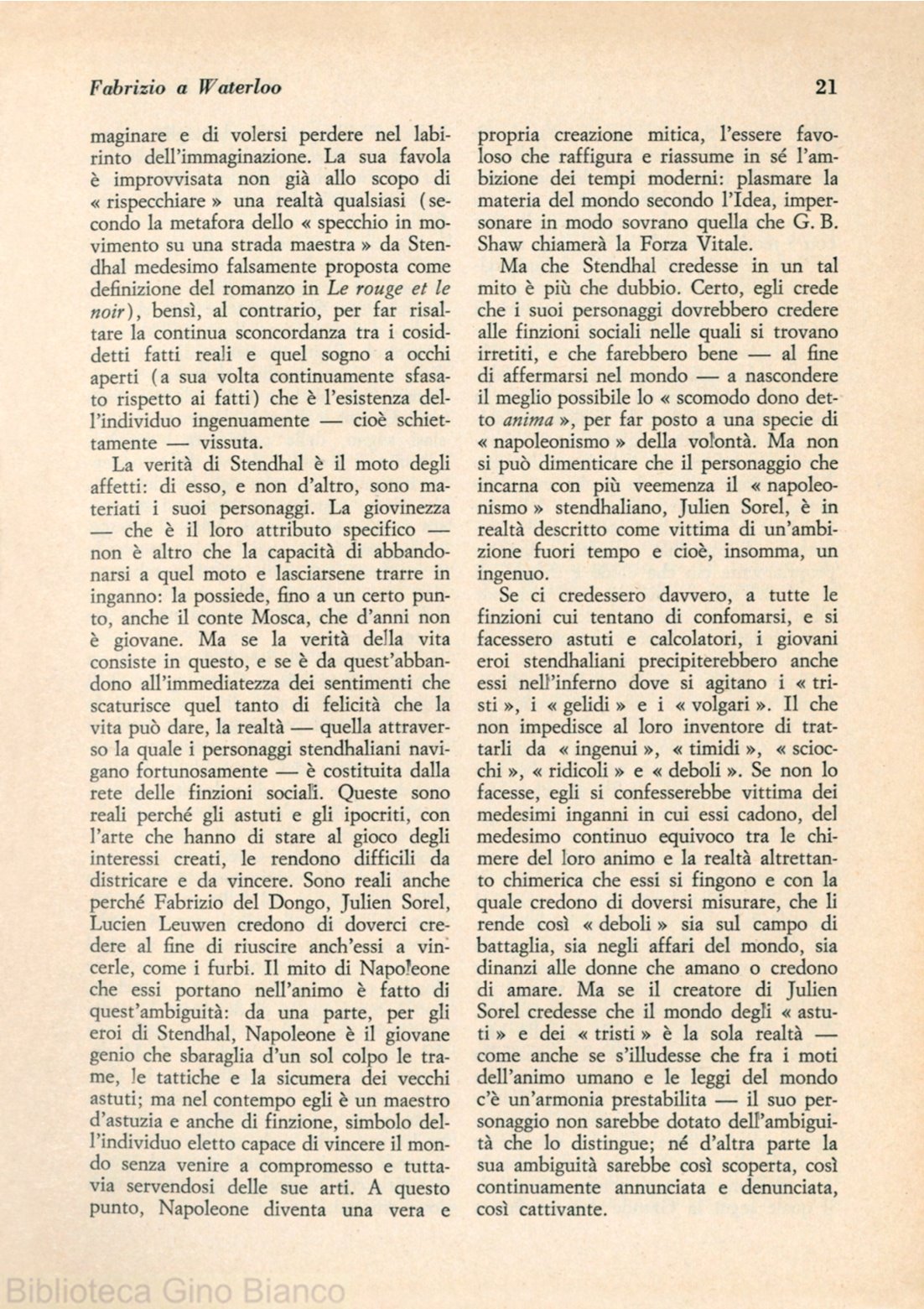
Fabrizio a Waterloo
maginare e di volersi perdere nel labi–
rinto dell'immaginazione. La sua favola
è improvvisata non già allo scopo di
« rispecchiare » una realtà qualsiasi (se–
condo la metafora dello « specchio in mo–
vimento su una strada maestra » da Sten–
dhal medesimo falsamente proposta come
definizione del romanzo in
Le rouge et le
noir),
bensì, al contrario, per far risal–
tare la continua sconcordanza tra i cosid–
detti fatti reali e quel sogno a occhi
aperti (a sua volta continuamente sfasa–
to rispetto ai fatti) che è l'esistenza del–
l'individuo ingenuamente - cioè schiet–
tamente - vissuta.
La verità di Stendhal è il moto degli
affetti: di esso, e non d'altro, sono ma–
teriati i suoi personaggi. La giovinezza
- che è il loro attributo specifico -
non è altro che la capacità di abbando–
narsi a quel moto e lasciarsene trarre in
inganno: la possiede, fino a un certo pun–
to, anche il conte Mosca, che d'anni non
è giovane. Ma se la verità della vita
consiste in questo, e se è da quest'abban–
dono all'immediatezza dei sentimenti che
scaturisce quel tanto di felicità che la
vita può dare, la realtà - quella attraver–
so la quale i personaggi stendhaliani navi–
gano fortunosamente - è costituita dalla
rete delle finzioni sociali. Queste sono
reali perché gli astuti e gli ipocriti, con
l'arte che hanno di stare al gioco degli
interessi creati, le rendono difficili da
districare e da vincere. Sono reali anche
perché Fabrizio del Dongo, Julien Sorel,
Lucien Leuwen credono di doverci cre–
dere al fine di riuscire anch'essi a vin'.
cerle, come i furbi. Il mito di Napoleone
che essi portano nell'animo è fatto di
quest'ambiguità : da una parte , per gli
eroi di Stendhal, Napoleone è
il
giovane
genio che sbaraglia d'un sol colpo le tra–
me, le tattiche e la sicumera dei vecchi
astuti; ma nel contempo egli è un maestro
d'astuzia e anche di finzione, simbolo del–
l'individuo eletto capace di vincere
il
mon–
do senza venire a compromesso e tutta–
via servendosi delle sue arti. A questo
punto, Napoleone diventa una vera e
21
propria creazione mitica, l'essere favo–
loso che raffigura e riassume in sé l'am–
bizione dei tempi moderni: plasmare la
materia del mondo secondo l'Idea, imper–
sonare in modo sovrano quella che G. B.
Shaw chiamerà la Forza Vitale.
Ma che Stendhal credesse in un tal
mito è più che dubbio. Certo, egli crede
che i suoi personaggi dovrebbero credere
alle finzioni sociali nelle quali si trovano
irretiti, e che farebbero bene - al fine
di affermarsi nel mondo - a nascondere
il
meglio possibile lo « scomodo dono det–
to
anima
», per far posto a una specie di
« napoleonismo » della volontà . Ma non
si può dimenticare che il personaggio che
incarna con più veemenza il « napoleo–
nismo
»
stendhaliano, Julien Sorel, è in
realtà descritto come vittima di un'ambi–
zione fuori tempo e cioè, insomma, un
ingenuo.
Se ci credessero davvero, a tutte le
finzioni cui tentano di confomarsi, e si
facessero astuti e calcolatori, i giovani
eroi stendhaliani precipiterebbero anche
essi nell'inferno dove si agitano i « tri–
sti», i «gelidi» e i «vo lgari». Il che
non impedisce al loro inventore di trat–
tarli da « ingenui », « timidi »,
«
scioc–
chi », « ridicoli » e
«
deboli ». Se non lo
facesse, egli si confesserebbe vittima dei
medesimi inganni in cui essi cadono, del
medesimo continuo equivoco tra le chi–
mere del loro animo e la realtà altrettan–
to chimerica che essi si fingono e con la
quale credono di doversi misurare, che li
rende cosi « deboli » sia sul campo di
battaglia, sia negli affari del mondo, sia
dinanzi alle donne che amano o credono
di amare.
Ma
se
il
creatore di Julien
Sorel credesse che il mondo degli
«
astu–
ti » e dei « tristi »
è
la sola realtà -
come anche se s'illudesse che fra i moti
dell'animo umano e le leggi del mondo
c'è un'armonia prestabilita - il suo per–
sonaggio non sarebbe dotato dell'ambigui–
tà che lo distingue; né d'altra parte la
sua ambiguità sarebbe cosi scoperta, cosi
continuamente annunciata e denunciata,
così cattivante.
















