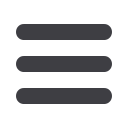
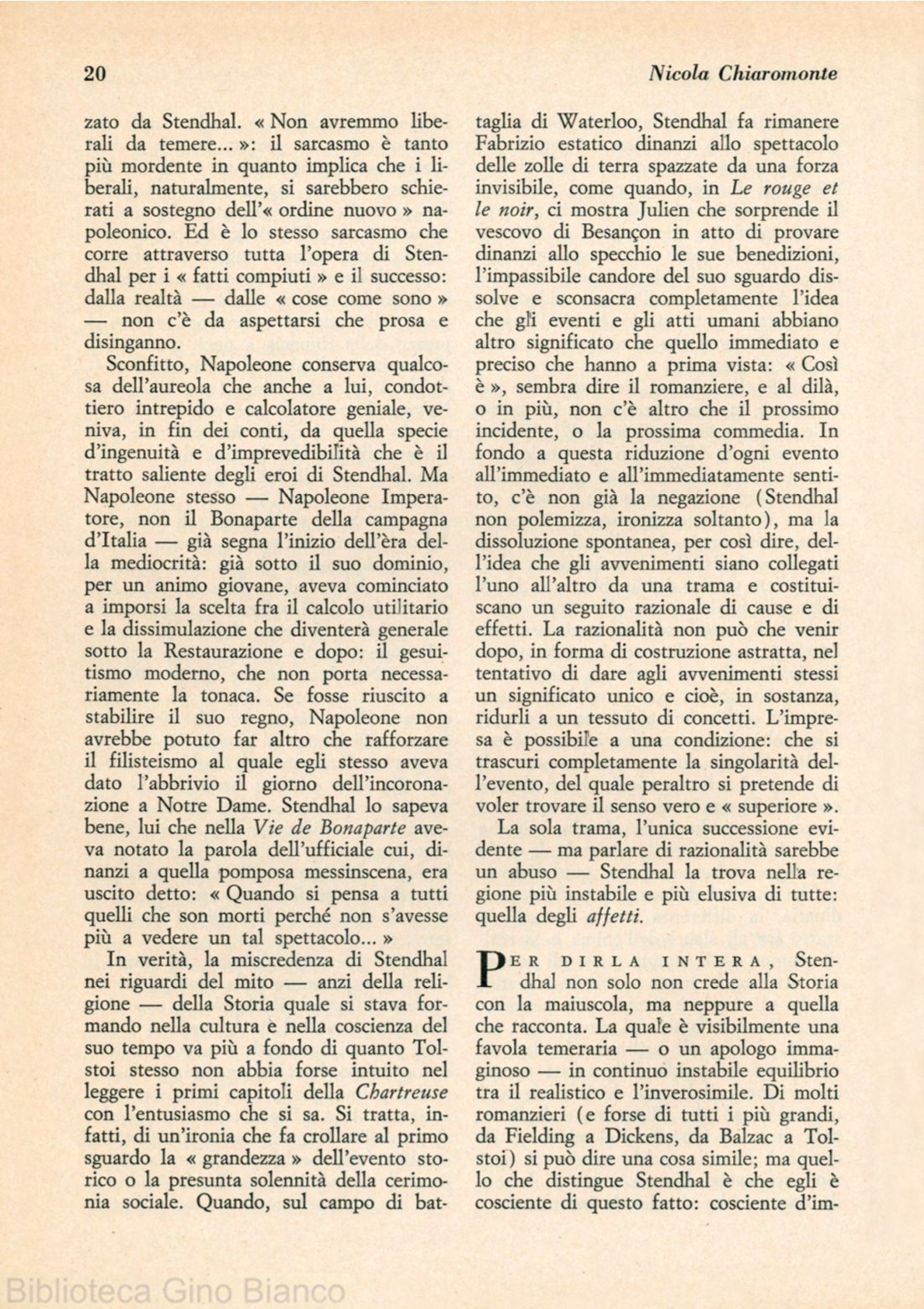
20
zato da Stendhal. « Non avremmo libe–
rali da temere... »: il sarcasmo è tanto
più mordente in quanto implica che i li–
berali, naturalmente, si sarebbero schie–
rati a sostegno dell'« ordine nuovo » na–
poleonico. Ed è lo stesso sarcasmo che
corre attraverso tutta l'opera di Sten–
dhal per i
«
fatti compiuti » e il successo:
dalla realtà - dalle « cose come sono
»
- non c'è da aspettarsi che prosa e
disinganno.
Sconfitto, Napoleone conserva qualco–
sa dell'aureola che anche a lui, condot–
tiero intrepido e calcolatore geniale, ve–
niva, in fin dei conti, da quella specie
d'ingenuità e d'imprevedibilità che è il
tratto saliente degli eroi di Stendhal. Ma
Napoleone stesso - Napoleone Impera–
tore, non il Bonaparte della campagna
d'Italia - già segna l'inizio dell'èra del–
la mediocrità: già sotto il suo dominio,
per un animo giovane, aveva cominciato
a imporsi la scelta fra
il
calcolo utilitario
e la dissimulazione che diventerà generale
sotto la Restaurazione e dopo : il gesui–
tismo moderno, che non porta necessa–
riamente la tonaca. Se fosse riuscito a
stabilire
il
suo regno, Napoleone non
avrebbe potuto far altro che rafforzare
il filisteismo al quale egli stesso aveva
dato l'abbrivio
il
giorno dell'incorona–
zione a Notre Dame. Stendhal lo sapeva
bene, lui che nella
Vie de Bonaparte
ave–
va notato la parola dell'ufficiale cui, di–
nanzi a quella pomposa messinscena, era
uscito detto : « Quando si pensa a tutti
quelli che son morti perché non s'avesse
più a vedere un tal spettacolo... »
In
verità, la miscredenza di Stendhal
nei riguardi del mito - anzi della reli–
gione - della Storia quale si stava for–
mando nella cultura e nella coscienza del
suo tempo va più a fondo di quanto Tol–
stoi stesso non abbia forse intuito nel
leggere i primi capitoli della
Chartreuse
con l'entusiasmo che si sa. Si tratta, in–
fatti , di un'ironia che fa crollare al primo
sguardo la
«
grandezza » dell'evento sto–
rico o la presunta solennità della cerimo–
nia sociale. Quando, sul campo di bat-
Nicola Chwromonte
taglia di Waterloo, Stendhal fa rimanere
Fabrizio estatico dinanzi allo spettacolo
delle zolle di terra spazzate da una forza
invisibile, come quando, in
Le rouge et
le noir,
ci mostra Julien che sorprende il
vescovo di Besançon in atto di provare
dinanzi allo specchio le sue benedizioni,
l'impassibile candore del suo sguardo dis–
solve e sconsacra completamente l'idea
che gli eventi e gli atti umani abbiano
altro significato che quello immediato e
preciso che hanno a prima vista:
«
Cosl
è», sembra dire il romanziere, e al dilà,
o in più, non c'è altro che il prossimo
incidente, o la prossima commedia.
In
fondo a questa riduzione d'ogni evento
all'immediato e all'immediatamente senti–
to, c'è non già la negazione (Stendhal
non polemizza, ironizza soltanto), ma la
dissoluzione spontanea, per cosl dire, del–
l'idea che gli avvenimenti siano collegati
l'uno all'altro da una trama e costitui–
scano un seguito razionale di cause e di
effetti. La razionalità non può che venir
dopo, in forma di costruzione astratta, nel
tentativo di dare agli avvenimenti stessi
un significato unico e cioè, in sostanza,
ridurli a un tessuto di concetti. L'impre–
sa è possibile a una condizione: che si
trascuri completamente la singolarità del–
l'evento, del quale peraltro si pretende di
voler trovare il senso vero e« superiore».
La sola trama, l'unica successione evi–
dente - ma parlare di razionalità sarebbe
un abuso - Stendhal la trova nella re–
gione più instabile e più elusiva di tutte:
quella degli
affetti.
P
E R
o
I R L A I N T E R A ,
Sten–
dhal non solo non crede alla Storia
con la maiuscola, ma neppure a quella
che racconta. La quale è visibilmente una
favola temeraria - o un apologo imma–
ginoso - in continuo instabile equilibrio
tra il realistico e l'inverosimile. Di molti
romanzieri (e forse di tutti i più grandi,
da Fielding a Dickens, da Balzac a Tol–
stoj") si può dire una cosa simile; ma quel–
lo che distingue Stendhal è che egli
è
cosciente di questo fatto: cosciente d'im-
















