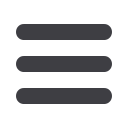
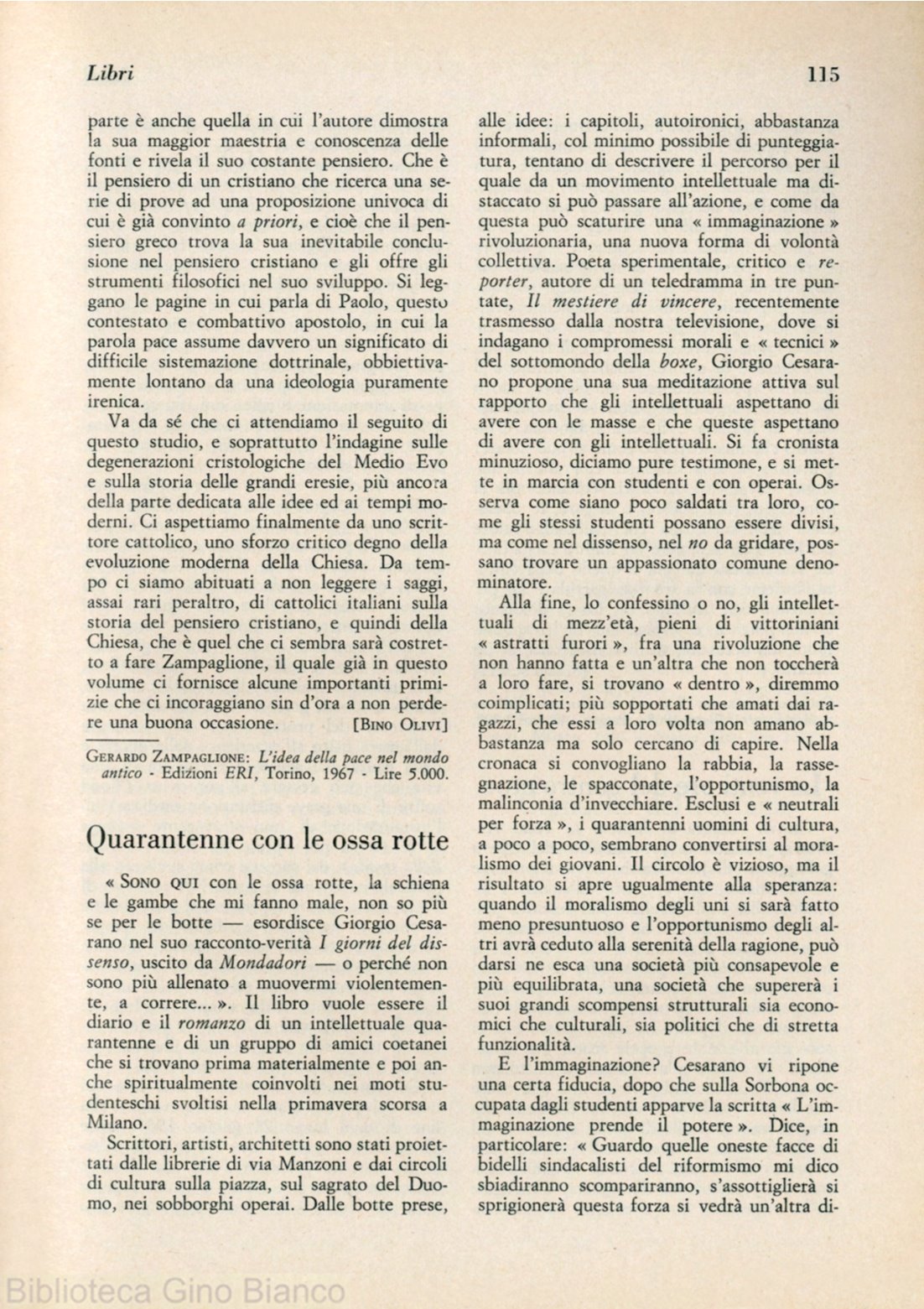
Libri
parte
è
anche quella in clii l'autore dimostra
la sua maggior maestr ia e conoscenza delle
fonti e rivela
il
suo costante pensiero. Che
è
il pensiero di un cristiano che ricerca una se–
rie
di
prove ad una proposi zione univoca di
cui
è
già convinto
a priori,
e
cioè
che
il
pen–
siero greco trova la sua inevitabile conclu–
sione nel pensiero cristiano e gli offre gli
strumenti filosofici nel suo sviluppo. Si leg–
gano le pagine in cui parla di Paolo, questv
contestato e combatt ivo apostolo , in cui la
paro la pace assume davvero un significato di
difficile sistemazio ne dottrinale, obbiettiva–
~en_re lontano da una ideologia puramente
irenica.
Va da sé che ci attendiamo il seguito di
questo studio, e soprattu tto l'indagine sulle
degenerazioni cristo logiche del Medio Evo
e sulla storia delle grandi eresie , più ancora
della parte dedicata alle idee ed ai tempi mo–
derni. Ci aspett iamo finalmente da uno scrit –
tore cattolico , uno sforzo critico degno del1a
evoluzione moderna della Chiesa . Da tem–
po ci siamo abituati a non leggere i saggi,
assai rari peraltro, di catto lici italiani sulla
stor ia del pensiero cristiano, e qu indi de1la
Chiesa , che
è
quel che ci sembra sarà costret –
to a fare Zampaglione , il quale già in questo
volume ci fornisce alcune importanti primi–
zie che ci incoraggiano sin d'ora a non perde–
re una buona occasione.
(BINO
OL1v1]
GE RARDO ZAMPAGLIONE :
L'idea della pace nel mondo
antico
• Edizioni
ERI ,
Torino , 1967 · Lire 5.000.
Quarantenne con le ossa rotte
«
SONO
QUI
con le ossa rotte, la schiena
e le gambe che mi fanno male, non so più
se per le botte - esordisce Giorg io Cesa–
rano nel suo racconto-verità
I
giorni del dis–
senso,
uscito da
Mondadori
-
o perché non
sono più alienato a muovermi violentemen–
te, a correte...
».
Il libro vuole essere il
diar io e
il
romanzo
di un intellettuale qua–
rantenne e di un gruppo di amici coetane i
che si trovan o prima materialmente e poi an–
che spiritualmente coinvolti nei moti stu–
denteschi svolt isi nella primaver a scorsa a
Milano.
Scrittori, artist i, archi tetti sono stati proiet–
tati dalle librerie di via Manzoni e dai circoli
di cultura sulla piazza, sul sagrato del Du o–
mo, nei sobborghi operai. Dalle botte prese,
ll 5
alle idee: i capitoli , autoironici, abbastanza
informali , col minimo possibile
di
punteggi a–
tura, tentano di descrivere
il
percorso per
il
quale da un movimento intellettuale ma di–
staccato si può passare all'azione, e come da
questa può scaturire una « immaginazione
»
rivolu zionaria , una nuova forma di volontà
collettiva. Poeta sperime ntale, critico e
re–
porter ,
autore di un teledra mma in tre pun–
tate ,
Il mestiere di vincere,
recentemente
trasmesso dalla nostra televi sione, dove si
indagano
i
compromessi morali e
«
tecnici
»
del sottomo ndo della
boxe,
Giorgio Cesara–
no propone una sua meditazione attiva sul
rapporto che gli intellettuali aspetta no di
avere con le masse
e
che queste aspettano
di avere con gli intellettua li. Si fa cronista
minuzioso, diciamo pure testimone, e si met–
te in marcia con stud enti e con ope rai. Os–
serva come siano poco saldati tra loro, co–
me gli stessi studenti possano essere divisi,
ma come nel dissenso, nel
no
da gridare
1
pos–
sano trovare un appass ionato comune deno–
minatore.
Alla fine, lo confessino o no, gli intellet–
tuali di mezz'età , pieni di vitto riniani
«
astra tti furori», fra una rivoluzione che
non hanno fatta e un 'altra che non toccherà
a loro fare, si trovano «dentro», diremmo
coimplicati; più sopportati che amati dai ra–
gazzi, che essi a loro volta non amano ab–
bastanza ma solo cercano di capire. Nella
cronaca si convogliano la rabbia , la rasse–
gnazione , le spacconate , l'opportunismo, la
malinconia d'invecchiare. Esclusi e « neutrali
per forza
»,
i
quarantenni uomini di cultura ,
a poco a poco, sembrano convertirs i al mora–
lismo dei giovani. Il circolo
è
vizioso, ma il
risultato si apre ugualmente alla speranza:
quando il moralismo degli uni si sarà fatto
meno presuntuoso e l'opportuni smo degli al–
tri avrà ceduto alla serenità della ragione, può
darsi ne esca una società più consapevo le e
più equ ilibrata, una società che supererà i
suoi grandi scompen si str uttu rali sia econo–
mici che culturali , sia politici che di stretta
funzionalità .
E l'immaginazione? Cesarano vi ripone
una certa fiducia, dopo che sulla Sorbona oc–
cupata dagli stude nti apparve la scritta
«
L'im–
maginazione pren de
il
potere».
Dice , in
par ticolare:
«
Guardo quelle ones te facce di
bidelli sindacalisti del riformismo mi dico
sbiadiranno scompariran no , s'assottiglierà si
sprigio nerà questa forza si vedrà un'altra di-
















