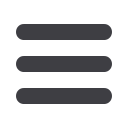
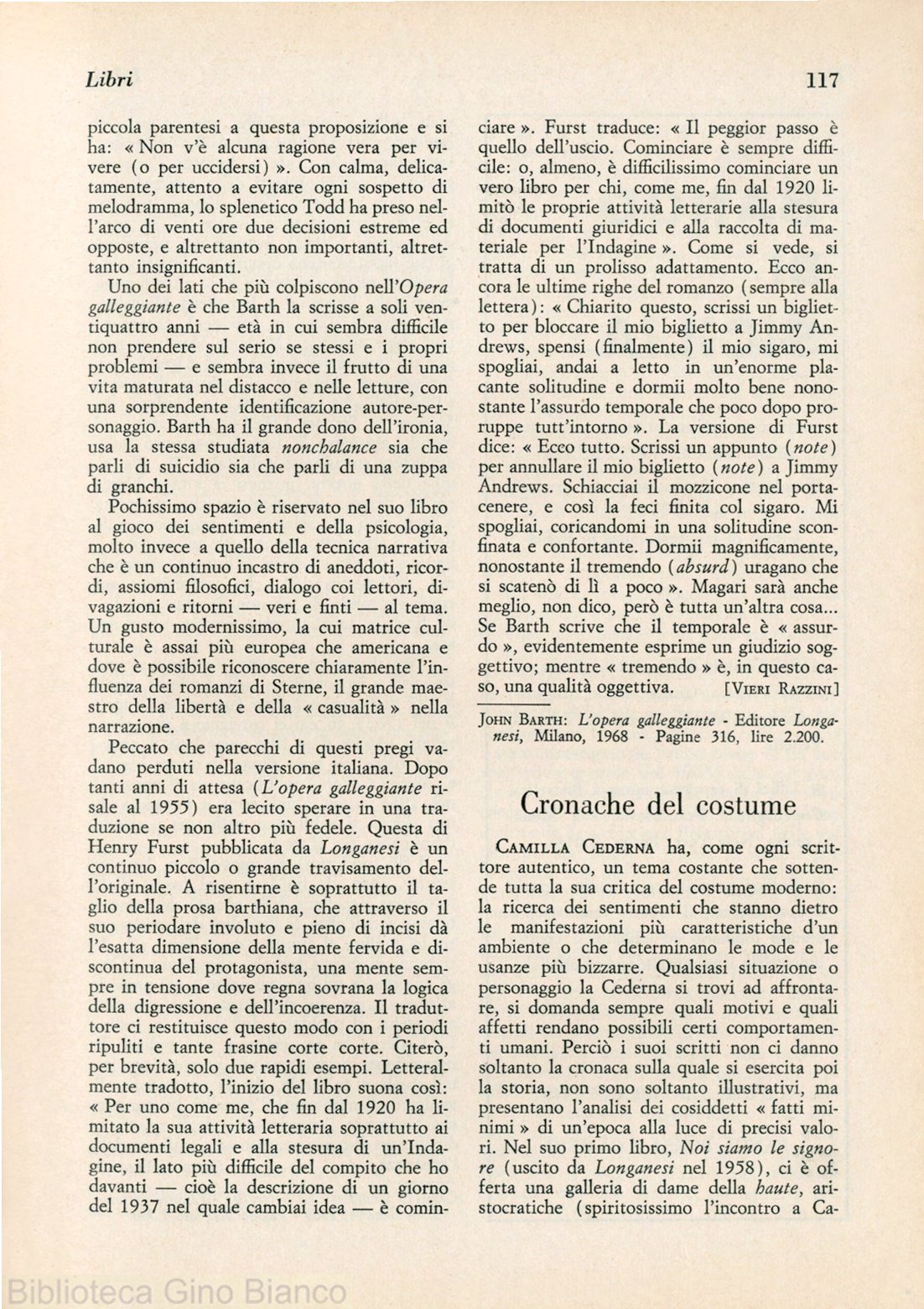
Libri
piccola parentesi a questa proposizione e si
ha:
«
Non v'è alcuna ragione vera per vi–
vere (o per uccidersi)
».
Con calma, delica–
tamente, attento a evitare ogni sospetto
di
melodramma, lo splenetico Todd ha preso nel–
l'arco di venti ore due decisioni estreme ed
opposte, e altrettanto non importanti, altret–
tanto i.nsigni..6canti.
Uno dei lati che più colpiscono
nell'Opera
galleggiante
è
che Barth la scrisse a soli ven–
tiquattro anni - età
in
cui sembra difficile
non prendere sul serio se stessi e i propri
problemi - e sembra invece
il
frutto di una
vita maturata nel distacco e nelle letture, con
una sorprendente identificazione autore-per–
sonaggio. Barth ha
il
grande dono dell'ironia,
usa la stessa studiata
nonchalance
sia che
parli di suicidio sia che parli di una zuppa
di granchi.
Pochissimo spazio
è
riservato nel suo libro
al gioco dei sentimenti e della psicologia,
molto invece a quello della tecnica narrativa
che è un continuo incastro di aneddoti, ricor–
di, assiomi filosofici, dialogo coi lettori, di–
vagazioni e ritorni - veri e
finti -
al tema.
Un gusto modernissimo, la cui matrice cul–
turale
è
assai più europea che americana e
dove è possibile riconoscere chiaramente
l'in–
fluenza dei romanzi di Sterne,
il
grande mae–
stro della libertà e della
«
casualità
»
nella
narrazione.
Peccato che parecchi di questi pregi va–
dano perduti nella versione italiana. Dopo
tanti anni di attesa
(L'opera galleggiante
ri–
sale al 1955) era lecito sperare in una tra–
duzione se non altro più fedele. Questa di
Henry Furst pubblicata da
Longonesi
è
un
continuo piccolo o grande travisamento del–
l'originale. A risentirne
è
soprattutto il ta–
glio della prosa barthiana, che attraverso
il
suo periodare involuto e pieno di incisi dà
l'esatta dimensione della mente fervida e di–
scontinua del protagonista, una mente sem–
pre in tensione dove regna sovrana la logica
della digressione e dell'incoerenza. Il tradut–
tore ci restituisce questo modo con
i
periodi
ripuHti e tante frasine corte corte. Citerò,
per brevità, solo due rapidi esempi. Letteral–
mente tradotto , l'inizio del libro suona cosl:
«
Per uno come me, che fin dal 1920 ha li–
mitato la sua attività letteraria soprattutto ai
documenti legali e alla stesura di un'Inda–
gine,
il
lato più difficile del compito che ho
davanti -
cioè
la descrizione
di
un giorno
del 1937 nel quale cambiai idea -
è
comin-
117
dare
».
Furst traduce:
«
Il peggior passo
è
quello dell'uscio. Cominciare
è
sempre diffi–
cile: o, almeno, è difficilissimo cominciare un
vero libro per chi, come me, fin dal 1920 li–
mitò le proprie attività letterarie alla stesura
di documenti giuridici e alla raccolta di ma–
teriale per l'Indagine
».
Come si vede, si
tratta di un prolisso adattamento. Ecco an–
cora le ultime righe del romanzo (sempre alla
lettera):
«
Chiarito questo, scrissi un bigliet–
to per bloccare
il
mio biglietto a Jimmy An–
drews, spensi (finalmente)
il
mio sigaro, mi
spogliai, andai a letto in un'enorme pla–
cante solitudine e dormii molto bene nono–
stante l'assurdo temporale che poco dopo pro–
ruppe tutt'intorno
».
La versione di Furst
dice:
«
Ecco tutto. Scrissi un appunto
(note)
per annullare il mio biglietto
(note)
a Jimmy
Andrews . Schiacciai
il
mozzicone nel porta–
cenere, e così la
feci
finita col sigaro. Mi
spogliai, coricandomi in una solitudine scon–
finata e confortante. Dormii magnificamente,
nonostante
il
tremendo
(absurd)
uragano che
si scatenò
di
ll a poco
».
Magari sarà anche
meglio, non dico, però
è
tutta un'altra cosa...
Se Barth scrive che
il
temporale
è
«
assur–
do
»,
evidentemente esprime un giudizio sog–
gettivo; mentre
«
tremendo
»
è,
in
questo ca–
so, una qualità oggettiva.
[VIERI
RAzztNr]
]OHN BARTH:
L'opera galleggiante
-
Editore
Longa-
nesi,
Milano, 1968 - Pagine 316, lire 2.200.
Cronache del costume
CAMILLACEDERNA ha, come ogni scrit–
tore autentico, un tema costante che sotten–
de tutta la sua critica del costume moderno :
la ricerca dei sentimenti che stanno dietro
le manifestazioni più caratteristiche d'un
ambiente o che determinano le mode e le
usanze più bizzarre. Qualsiasi situazione o
personaggio la Cederna si trovi ad affronta•
re, si domanda sempre quali motivi e quali
affetti rendano possibili certi comportamen–
ti umani. Perciò
i
suoi scritti non ci danno
soltanto la cronaca sulla quale si esercita poi
la storia, non sono soltanto illustrativi, ma
presentano l'analisi dei cosiddetti
«
fatti mi–
nimi
»
di un'epoca alla luce di precisi valo–
ri. Nel suo primo libro,
Noi siamo le signo–
re
(
uscito da
Longonesi
nel 1958), ci
è
of–
ferta una galleria di dame della
baule,
ari–
stocratiche (spiritosissimo l'incontro a Ca-
















