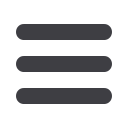
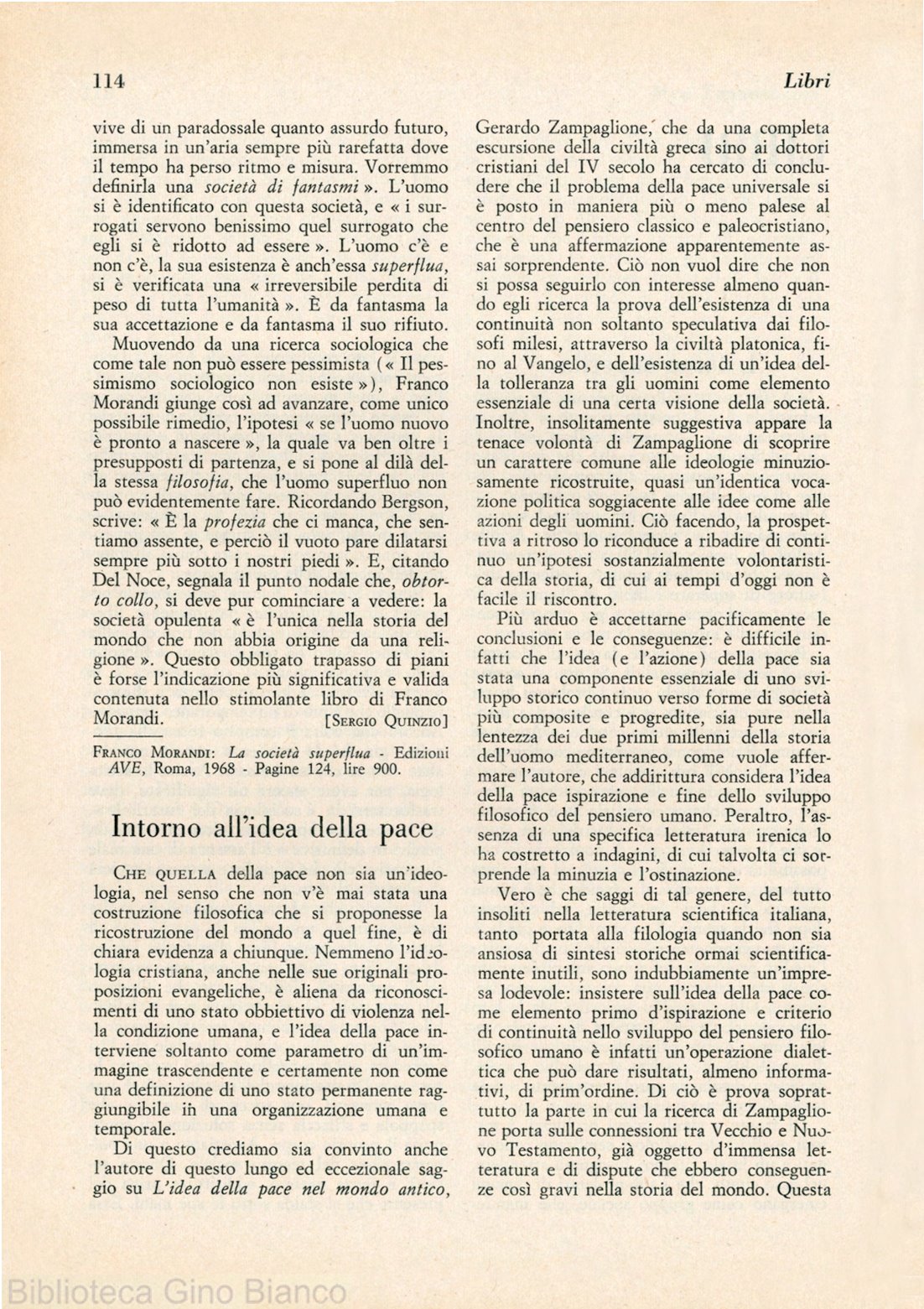
114
vive
di
un paradossale quanto assurdo futuro ,
immersa in un'aria sempre più rarefatta dove
il tempo ha perso ritmo e misura. Vorremmo
definirla una
società
di
fantasmi».
L'uomo
si
è
identificato con questa società, e
«
i sur–
rogati servono benissimo quel surrogato che
egli si
è
ridotto ad essere». L'uomo c'è e
non c'è, la sua esisten za
è
anch'essa
superflu a,
si
è
verificata una
«
irreversibile perdita di
peso di
tutta
l'umanità».
È
da fantasma la
sua accettazione e da fantasma
il
suo rifiuto.
Muovendo da una ricerca sociologica che
come tale non può essere pessimista (
«
Il pes–
simismo sociologico non esiste
»),
Franco
Morandi giunge cosl ad avanzare , come unico
possibile rimedio
1
l'ipotesi
«
se l'uomo nuovo
è
pronto a nascere
»,
la quale va ben oltre i
presupposti di partenza , e si pone al dilà del–
la stessa
filosofia,
che l'uomo superfluo non
può evidentemente fare. Ricordando Bergson,
scrive:
«
:È
la
profezia
che ci manca, che sen–
tiamo assente, e perciò il vuoto pare dilatarsi
sempre più sotto i nostri piedi
».
E, citando
Del Noce, segnala il punto nodale che,
obtor–
to collo,
si deve pur cominciare a vedere: la
società opulenta
«
è
l'unica nella stor ia de]
mondo che non abbia origine da una reli~
gione
».
Questo obbligato trapasso di piani
è
forse l'indicazione più significat iva e valida
contenuta nello stimo lante libro di Franco
Morandi.
(SERGIO
Qu1Nz10)
FRANCO MoRANDI:
ÙJ
società superflua
.
Edizioni
AVE,
Roma, 1968 - Pagine 124, lire 900.
Int orno all'idea della pace
CHE QUELLA
della pace non sia un 'ideo–
logia, nel senso che non v'è mai stata una
costruzione filosofica che si proponesse la
ricostruzione del mondo a quel fine,
è
di
chiara evidenza a chiunque. Nemmeno l'id.:o–
logia cristiana, anche nelle sue originali pro–
posizioni evangeliche,
è
aliena da riconosci–
menti
cli
uno stato obbiett ivo di violenza nel–
la condizione umana, e l'idea della pace in–
terviene soltanro come parametro di un'i m–
magine trascendente e certamente non come
una definizione di uno stato permanente rag–
giungibi le iil una organizzazione umana e
temporale.
Di questo crediamo sia convinto anche
l'autore di questo lungo ed eccezionale sag–
gio su
L'idea della pace nel mondo antico ,
Libri
Gerardo Zampaglione ; che da una completa
escursione della civiltà greca sino ai dottori
cristiani del IV secolo ha cercato
cli
conclu–
dere che il problema della pace universale si
è
posto in maniera più o meno palese al
centro del pensiero classico e paleocristian o,
che
è
una affermazione apparentement e as–
sai sorpr endente. Ciò non vuol dire che non
si possa seguirlo con interesse almeno quan–
do egli ricerca la prova dell'esistenza di una
conti nuità non soltanto speculativa dai filo–
sofi milesi, atrraverso la civiltà platonica, fi–
no al Vangelo, e dell'esistenza di un'idea del–
la tolleranza tra gli uomini come elemento
essenziale di una certa visione della società.
Inoltre , insolitamente suggestiva appare la
tenace volontà di Zampaglione di scoprire
un carattere comune alle ideologie minuzio–
samente ricostruite, quasi un'identica voca–
zione politica soggiacente alle idee come alle
azioni degli uomini.
Ciò
facendo , la prospet –
tiva a ritroso lo riconduce a ribadire di conti–
nuo un'ipotesi sostanzialmente volontaris ti–
ca della storia , di cui ai tempi d'oggi non
è
facile il riscontro.
Più arduo è accettarne pacificamente le
conclusioni e le conseguenze :
è
difficile in–
farti che l'idea (e l'azione) della pace sia
starn una componente essenziale di uno svi–
luppo stor ico continuo verso forme di società
più composite e progredite, sia pure nella
lentezza dei due primi millenni della storia
dell'uomo mediterraneo , come vuole affer–
mare l'autore , che addirittura considera l'idea
della pace ispirazione e fine dello sviluppo
filosofico del pensiero umano. Peraltro , l'as–
senza di una specifica letteratura irenica lo
ha costretto a indagini , di cui talvolta ci sor–
prende la minuzia e l'ostinazione .
Vero
è
che saggi di tal genere , del tutto
insoliti nella letteratura scientifica italiana ,
tanto portata alla filologia quando non sia
ansiosa di sintesi storiche ormai scientifi ca–
mente inutili, sono indubb iamente un'impre–
sa lodevole: insistere sull' idea della pace co–
me elemento primo d'ispirazione e criterio
di continu ità nello sviluppo del pensiero filo–
sofico umano
è
infat ti un'operazione dialet–
tica che può dare risultati, almeno informa–
tivi, di prim'ordine. Di ciò
è
prova soprat–
tutto la parte in cui la ricerca di Zampaglio–
ne porta sulle connessioni tra Vecchio e NuJ–
vo Testamento , già oggetto d'immensa let–
teratura e di dispute che ebbero conseguen–
ze così gravi nella storia del mondo. Questa
















