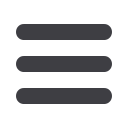
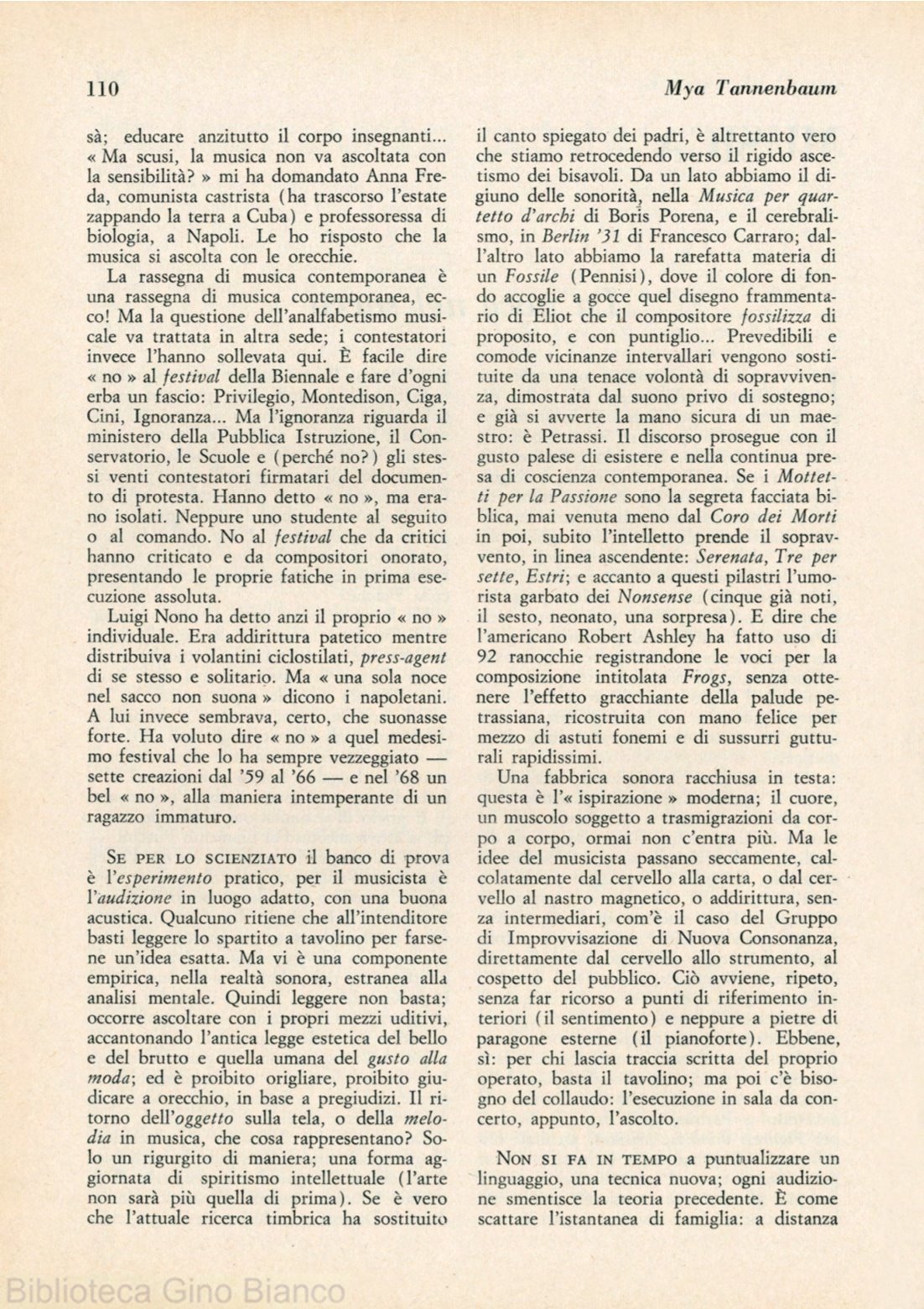
llO
sà;
educare anzitutto
il
corpo insegnanti...
«
Ma scusi, la musica non va ascoltata con
la sensibilità?
»
mi ha domandato Anna Fre–
da, comunista castrista (ha trascorso l'estate
zappando la terra a Cuba) e professoressa di
biologia, a Napoli. Le ho risposto che la
musica si ascolta con Je orecchie .
La rassegna di musica contemporanea è
una rassegna
di
musica contemporanea, ec–
co! Ma la questione dell'analfabetismo musi–
cale va trattata
in
altra sede;
i
contestatori
invece l'hanno sollevata qui.
È
facile dire
«
no
»
al
festival
della Biennale e fare d'ogni
erba un fascio: Privilegio, Montedison, Ciga,
Cini, Ignoranza ... Ma l'ignoranza riguarda il
ministero della Pubblica Istruzione, il Con–
servatorio, le Scuole e (perché no?) gli stes–
si venti contestatori firmatari
del
documen–
to
di
protesta. Hanno detto
«
no
»,
ma era–
no isolati. Neppure uno studente al seguito
o al comando. No al
festival
che da critici
hanno criticato e da compositori onorato,
presentando le proprie fatiche in prima ese–
cuzione assoluta.
Luigi Nono ha detto anzi
il
proprio
«
no
»
individuale. Era addirittura patetico mentre
distribuiva
i
volantini
ciclostilati,
press-agent
di se stesso e solitario. Ma
«
una sola noce
nel sacco non suona
»
dicono
i
napoletani.
A lui invece sembrava, certo, che suonasse
forte. Ha voluto dire
«
no » a quel medesi–
mo festival che lo ha sempre vezzeggiato -
sette creazioni dal '59 al '66 - e nel '68 un
bel
«
no
»,
alla maniera intemperante di un
ragazzo immaturo.
SE PER LO SCIENZIATO il banco
di
prova
è
l'esperimento
pratico, per
il
musicista è
l'audizione
in luogo adatto, con una buona
acustica. Qualcuno ritiene che all'intenditore
basti leggere lo spartito a tavolino per farse–
ne un'idea esatta. Ma vi è una componente
empirica, nella realtà sonora, estranea
alld
analisi mentale. Quindi leggere non basta;
occorre ascoltare con i propri mezzi uditivi,
accantonando l'antica legge estetica del bello
e del brutto e quella umana del
gusto alla
moda;
ed è proibito origliare, proibito giu–
dicare a orecchio, in base a pregiudizi. Il ri–
torno
dell'oggetto
sulla tela, o della
melo–
dia
in musica, che cosa rappresentano? So–
lo un rigurgito di maniera; una forma ag–
giornata di spiritismo intellettuale (l'arte
non sarà più quella di prima). Se è vero
che l'attuale ricerca timbrica ha sostituito
Mya Tannenbawn
il canto spiegato dei padri, è altrettanto vero
che stiamo retrocedendo verso
il
rigido asce–
tismo dei bisavoli. Da un lato abbiamo il di–
giuno delle sonorità , nella
Musica per quar–
tetto d'archi
di Borìs Porena, e
il
cerebrali–
smo, in
Berlin '31
di Francesco Carraro; dal–
l'altro lato abbiamo la rarefatta materia di
un
Fossile
(
Pennisi), dove
il
colore di fon–
do accoglie a gocce quel disegno frammenta–
rio di Eliot che il compositore
fossilizza
di
proposito, e con puntiglio ... Prevedibili e
comode vicinanze intervallari vengono sosti–
tuite da una tenace volontà di sopravviven –
za, dimostrata dal suono privo di sostegno;
e già si avverte la mano sicura di un mae–
stro: è Petrassi. Il discorso prosegue con
il
gusto palese
di
esistere e nella contin ua pre–
sa di coscienza contemporanea. Se i
Mottet–
ti per la Passione
sono la segreta facciata bi–
blica, mai venuta meno dal
Coro dei Morti
in poi, subito l'intelletto prende
il
soprav–
vento, in linea ascendente:
Serenata, Tre per
sette, Estri;
e accanto a questi pilastri l'umo–
rista garbato dei
Nonsense
(cinque già noti,
il
sesto, neonato , una sorpresa).
E
dire che
l'americano Robert Ashley ha fatto uso di
92 ranocchie registrandone le voci per la
composizione intitolata
Frogs,
senza otte–
nere l'effetto gracchiante della palude pe–
trassiana, ricostruita con mano felice per
mezzo di astuti fonemi e di sussurri guttu–
rali rapidissimi.
Una fabbrica sonora racchiusa in testa :
questa è
l'«
ispirazione» moderna;
il
cuore,
un muscolo soggetto a trasmigrazioni da cor–
po a corpo, ormai non c'entra più. Ma le
idee del musicista passano seccamente , cal–
colatamente dal cervello alla carta, o dal cer–
veUo al nastro magnetico, o addirittura, sen–
za intermediari, com'è
il
caso del Gruppo
di Improvvisazione di Nuova Consonanza,
direttamente dal cervello allo strumento, al
cospetto del pubblico. Ciò avviene, ripeto,
senza far ricorso a punti di riferimento in–
teriori (il sentime nto) e neppure a pietre di
paragone esterne (
il
pianoforte). Ebbene,
sì: per chi lascia traccia scritta del proprio
operato , basta
il
tavolino; ma poi c'è biso–
gno del collaudo: l'esecuzione in sala da con–
certo, appunto, l'ascolto.
NoN SI FA IN TEMPOa puntJualizzare un
linguagg io, una tecnica nuova; ogni audizio–
ne smentisce la teoria precedente.
È
come
scattare l'istantanea di famiglia: a distanza
















