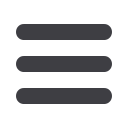
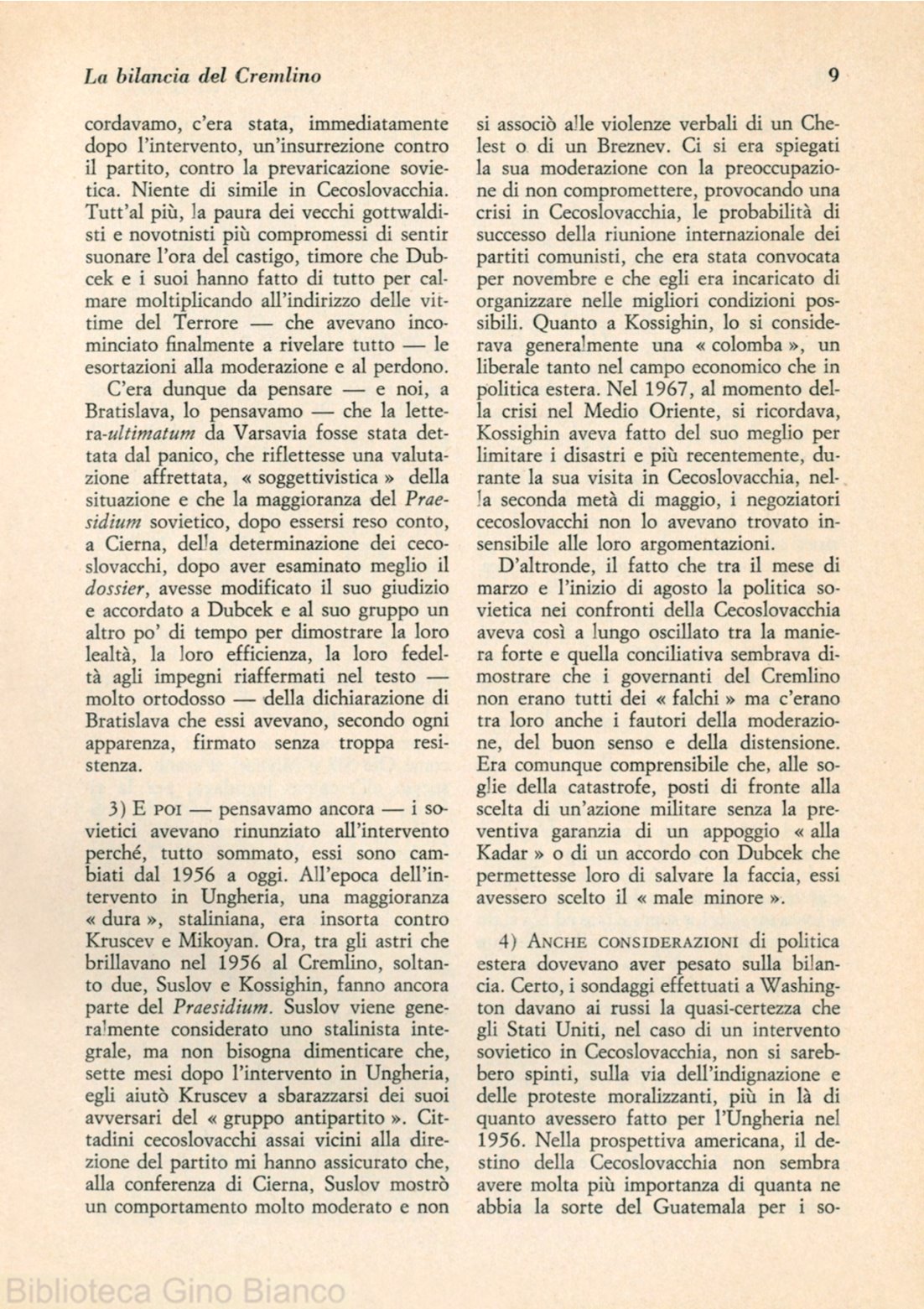
La bilancia del Cremlino
cordavamo, c'era stata, immediatamente
dopo l'intervento, un'insurrezione contro
il partito , contro la prevaricazione sovie–
tica. Niente di simile in Cecoslovacchia.
Tutt'al più, la paura dei vecchi gottwaldi–
sti e novotnisti più compromessi
di
sentir
suonare l'ora del castigo, timore che Dub–
cek e i suoi hanno fatto di tutto per cal–
mare moltiplicando all'indirizzo delle vit–
time del Terrore - che avevano inco–
minciato finalmente a rivelare tutto - le
esortazioni alla moderazione e al perdono.
C'era dunque da pensare - e noi, a
Bratislava, lo pensavamo - che la lette–
ra-ultimatum
da Varsavia fosse stata det–
tata dal panico, che riflettesse una valuta–
zione affrettata,
«
soggettivistica
»
della
situazione e che la maggioranza del
Prae–
sidium
sovietico, dopo essersi reso conto,
a Cierna, della determinazione dei ceco–
slovacchi, dopo aver esaminato meglio
il
dossier,
avesse modificato il suo giudizio
e accordato a Dubcek e al suo gruppo un
altro po' di tempo per dimostrare la loro
lealtà, la loro efficienza, la loro fedel–
tà agli impegni riaffermati nel testo -
molto ortodosso - della dichiarazione di
Bratislava che essi avevano, secondo ogni
apparenza, firmato senza troppa resi–
stenza.
3) E
POI -
pensavamo ancora - i so–
vietici avevano rinunziato all'intervento
perché, tutto sommato, essi sono cam–
biati dal 1956 a oggi. All'epoca dell'in–
tervento in Ungheria, una maggioranza
«dura», staliniana, era insorta contro
Kruscev e Mikoyan. Ora, tra gli astri che
brillavano nel 1956 al Cremlino, soltan–
to due, Suslov e Kossighin, fanno ancora
parte del
Praesidium.
Suslov viene gene–
ralmente considerato uno stalinista inte–
grale, ma non bisogna dimenticare che,
sette mesi dopo l'intervento in Ungheria,
egli aiutò Kruscev a sbarazzarsi dei suoi
avversari del
«
gruppo antipartito
».
Cit–
tadini cecoslovacchi assai vicini alla dire–
zione del partito
mi
hanno assicurato che,
alla conferenza di Cierna, Suslov mostrò
un comportamento molto moderato e non
9
si associò alle violenze verbali di un Che–
lest o di un Breznev. Ci si era spiegati
la sua moderazione con la preoccupazio–
ne di non compromettere , provocando una
crisi in Cecoslovacchia, le probabilità di
successo della riunione internazionale dei
partiti comunisti, che era stata convocata
per novembre e che egli era incaricato di
organizzare nelle migliori condizioni pos–
sibili. Quanto a Kossighin, lo si conside–
rava generalmente una «colomba», un
liberale tanto nel campo economico che in
politica estera. Nel 1967, al momento del–
la crisi nel Medio Oriente , si ricordava,
Kossighin aveva fatto del suo meglio per
limitare i disastri e più recentemente, du–
rante la sua visita in Cecoslovacchia, nel–
la seconda metà di maggio, i negoziatori
cecoslovacchi non lo avevano trovato in–
sensibile alle loro argomentazioni.
D'altronde, il fatto che tra il mese
di
marzo e l'inizio di agosto la politica so–
vietica nei confronti della Cecoslovacchia
aveva così a lungo oscillato tra la manie–
ra forte e quella conciliativa sembrava di–
mostrare che i governanti del Cremlino
non erano tutti dei
«
falchi
»
ma c'erano
tra loro anche i fautori della moderazio–
ne, del buon senso e della distensione.
Era comunque comprensibile che, alle so–
glie della catastrofe, posti
di
fronte alla
scelta di un'azione militare senza la pre–
ventiva garanzia di un appoggio
«
alla
Kadar
»
o di un accordo con Dubcek che
permettesse loro di salvare la faccia, essi
avessero scelto il
«
male minore
».
4) ANCHE CONSIDERAZIONIdi politica
estera dovevano aver pesato sulla bilan–
cia. Certo, i sondaggi effettuati a Washing–
ton davano ai russi la quasi-certezza che
gli Stati Uniti, nel caso di un intervento
sovietico in Cecoslovacchia, non si sareb–
bero spinti, sulla via dell'indignazione e
delle proteste moralizzanti, più in là di
quanto avessero fatto per l'Ungheria nel
1956. Nella prospettiva americana,
il
de–
stino della Cecoslovacchia non sembra
avere molta più importanza di quanta ne
abbia la sorte del Guatemala per i so-
















