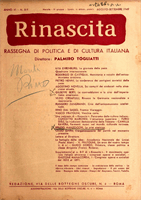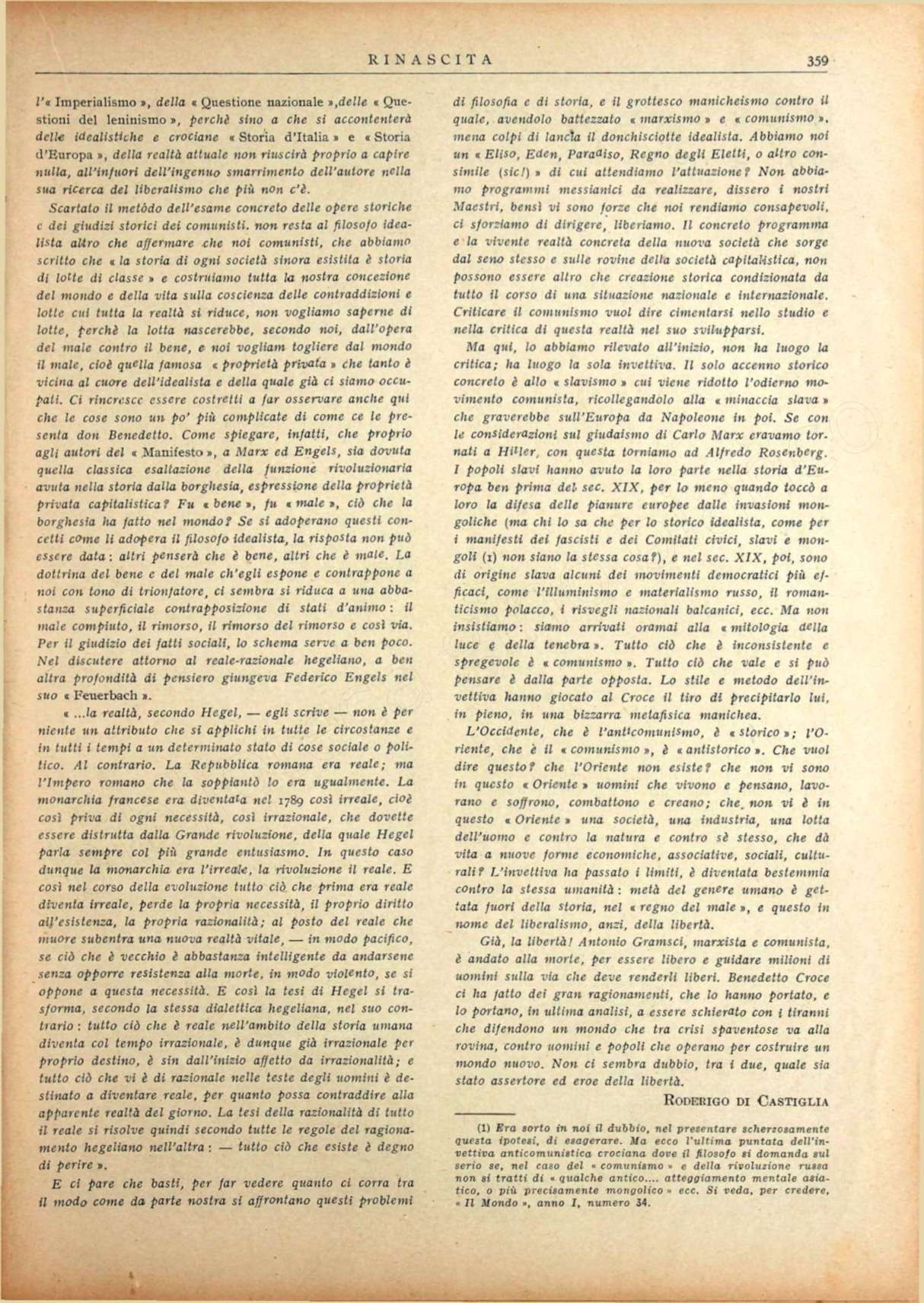
R I N A S C I T A
359
T« Imperialismo »,
della
a Questione nazionale
*
t
delle
«Que–
stioni del leninismo »,
perchè sino a che si accontenterà
delle idealistiche
e crociane *
Storia d'Italia » e t Storia
d'Europa »,
della realtà attuale non riuscirà proprio a capire
nulla, all'infuori
dell'ingenuo
smarrimento dell'autore n&Ua
sua ricerca del liberalismo che più non c'è.
Scartato il metodo dell'esame
concreto delle opere storiche
c dei giudizi storici dei comunisti, non resta al filosofo idea–
lista altro che affermare -che noi comunisti,
che abbiamo
scritto che « la storia di ogyii società sinora esistita è storia
di lotte di classe » e costruiamo tutta la nostra
concezione
del mondo e della vita sulla coscienza delle contraddizioni e
lotte cui tutta la realtà si riduce, non vogliamo saperne di
lotte, perchè la lotta nascerebbe,
secondo noi,
dall'opera
del male contro il bene, e noi vogliam togliere dal mondo
il male, cioè quella famosa a proprietà privata » che tanto è
vicina al cuore dell'idealista e della quale già ci siamo occu–
pati. Ci rincresce essere costretti a far osservare anche qui
che le cose sono un po' più complicate di come ce le pre–
senta don Benedetto,
Come spiegare, infatti, che proprio
agli autori del
« Manifesto»,
a Marx ed Engels, sìa dovuta
quella
classica
esaltazione
della funzione
rivoluzionaria
avuta nella storia dalla borghesia, espressione della proprietà
privata capitalistica?
Fu tbene*,
fu *male»
t
ciò che la
borghesia ha fatto nel mondo? Se si adoperano questi con–
cetti come li adopera il filosofo idealista, la risposta non pitò
essere data: altri penserà che è bene, altri che è male. La
dottrina del bene c del male ch'egli espone e contrappone a
noi con torio di trionfatore, ci sembra si riduca a una abba–
stanza superficiale
contrapposizione
di stati d'animo : il
male compiuto, il rimorso, il rimorso del rimorso e così via.
Per il giudizio dei fatti sociali, lo schema serve a ben poco.
Nel discutere
attorno al reale-razionale
hegeliano, a ben
altra profondità di pensiero giungeva Federico Engels nel
suo
* Feuerbach ».
« ...la realtà, secondo Hegel, — egli scrive — non i per
niente un attributo che si applichi in tutte le circostanze e
in tutti i tempi a un determinato stato di cose sociale o poli–
tico. Al contrario. La Repubblica
romana era reale; ma
l'Impero
romano che la soppiantò lo era ugualmente.
La
monarchia francese era diventata nel
1789
così irreale, cioè
così priva di ogni necessità, così irrazionale, che dovette
essere distrutta dalla Gratidc rivoluzione,
della quale
Hegel
parla sempre col più grande entusiasmo. In questo
caso
dunque la monarchia era l'irreale, la rivoluzione il reale. E
così nel corso della evoluzione tutto ciò che prima era reale
diventa irreale, perde la propria necessità, il proprio diritto
all'esistenza,
la propria razionalità; al posto del reale che
muore subentra una nuova realtà vitale, — in modo pacifico,
se ciò che è vecchio è abbastanza intelligente da andarsene
senza opporre resistenza alla morte, in modo violento, se si
oppone a questa necessità. E così la tesi dì Hegel si tra–
sforma, secondo la stessa dialettica hegeliana, nel suo con–
trario : tutto ciò che è reale nell'ambito
della storia umana
diventa col tempo irrazionale, è dunque già irrazionale per
proprio destino, è sin dall'inizio
affetto da irrazionalità; e
tutto ciò che vi è di razionale nelle teste degli nomini è de–
stinato a diventare reale, per quanto possa contraddire alla
apparente realtà del giortw. La lesi della razionalità di tutto
il reale si risolve quindi secondo tutte te regole del ragiona–
mento hegeliano nell'altra: — tutto ciò che esìste è degno
di perire ».
E ci pare che basti, per far vedere quanto ci corra tra
il modo come da parte nostra si affrontano questi
problemi
di filosofia e di storia, e il grottesco manicheismo
contro il
quale, avendolo
battezzato
« marxismo
» e «
comunismo »,
mena colpi di lancia il donchisciotte
idealista. Abbiamo noi
un « Eliso, Eden, Paradiso, Regno degli Eletti, o altro con–
simile
( s i c / ) »
di cui attendiamo
l'attuazione?
Non abbia–
mo programmi
messianici
da realizzare,
dissero i nostri
Maestri, bensì vi sono forze che noi rendiamo
consapevoli,
ci sforziamo di dirigere, liberiamo. Il concreto
programma
e la vivente realtà concreta della nuova società che sorge
dal seno stesso e sulle rovine della società capitalistica, non
possono essere altro che creazione storica condizionata da
tutto il corso di una situazione
nazionale e
internazionale.
Criticare il comunismo
vuol dire cimentarsi
nello studio e
nella crìtica di questa realtà nel suo
svilupparsi.
Ma qui, lo abbiamo rilevato all'inizio, non ha luogo la
critica; ha luogo la sola invettiva. Il solo accenno
storico
concreto è allo • slavismo • cui viene ridotto l'odierno mo–
vimento
comunista,
ricollegandolo
alla « minaccia slava »
che graverebbe
sull'Europa
da Napoleone in poi. Se con
le considerazioni sul giudaismo di Carlo Marx eravamo tor–
nati a Hitler, con questa torniamo ad Alfredo
Rosenberg.
I popoli slavi hanno avuto la loro parte nella storia
d'Eu–
ropa ben prima del sec. XIX, per lo meno quando toccò a
loro la difesa delle pianure europee dalle invasioni
mon–
goliche {ma chi lo sa che per lo storico idealista, come per
i manifesti dei fascisti e dei Comitati civici, slavi e mon–
goli
(1)
non siano la stessa cosa?), e nel sec. XIX, poi, sono
dì origine slava alcuni dei movimenti
democratici più ef–
ficaci, come l'illuminismo
e materialismo
russo, il roman–
ticismo polacco, i risvegli nazionali balcanici, ecc. Ma non
insistiamo : siamo arrivati
oramai alla
a
mitologìa
della
luce e della tenebra *. Tutto ciò che è inconsistente
e
spregevole è
t
comunismo ». Tutto ciò che vale e si può
pensare è dalla parte opposta. Lo stile e metodo
dell'in–
vettiva hanno giocato al Croce il Uro di precipitarlo lui,
in piciio, in una bizzarra metafisica
manichea.
L'Occidente,
che è t*antkoniuni$mo
t
è « storico »; l'O–
riente, che è il * comunismo », è « antistorico ». Che vuol
dire questo? che l'Oriente
non esìste? che non vi sono
in questo « Oriente » uomini che vivono e pensano,
lavo–
rano e soffrotw, combattono e creano; che
r
non vi è in
questo «t Oriente » una società, una industria, una lotta
dell'uomo
e contro ìa natura e contro sè stesso, che dà
vita a nuove forme economiche,
associative,
sociali,
cultu–
rali? L'invettiva ha passalo i limiti, è diventata
bestemmia
contro la stessa umanità : metà del genere umano è get–
tata fuori della storia, nel « regno del male », e questo in
nome del liberalismo,
anzi, della libertà.
Già, la libertà! Antonio Gramsci, marxista e comunista,
è attdato alla morie, per essere libero e guidare milioni di
uomini sulla via che deve renderli liberi. Benedetto
Croce
ci ha fatto dei gran ragionamenti, che lo hanno portato, e
lo portano, in ultima analisi, a essere schierato con ì tiranni
che difendono un mondo che tra crisi spaventose va alla
rovina, contro uomini e popoli che operano per costruire un
mondo nuovo. Non ci sembra dubbio, tra i due, quale sia
stato assertore ed eroe della libertà.
RODER I GO DI C A S T I G L I A
(1) E r a
sorto
in
noi il
dubbio, nel presentare
scherzosamente
questa ipotesi, di esagerare. Ma ecco V ultima puntata dell'in–
vettiva ant{comunistica crociana dove il filosofo si domanda sul
serio se, nel caso del « comunismo » e delta rivoluzione russa
non
si trat t i
di * qualche antico.... atteggiamento mentale asia–
tico, o più precisamente mongolico » ecc. Si veda, per credere,
« I l
Mondo », anno I , numero
34.