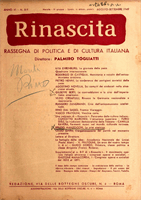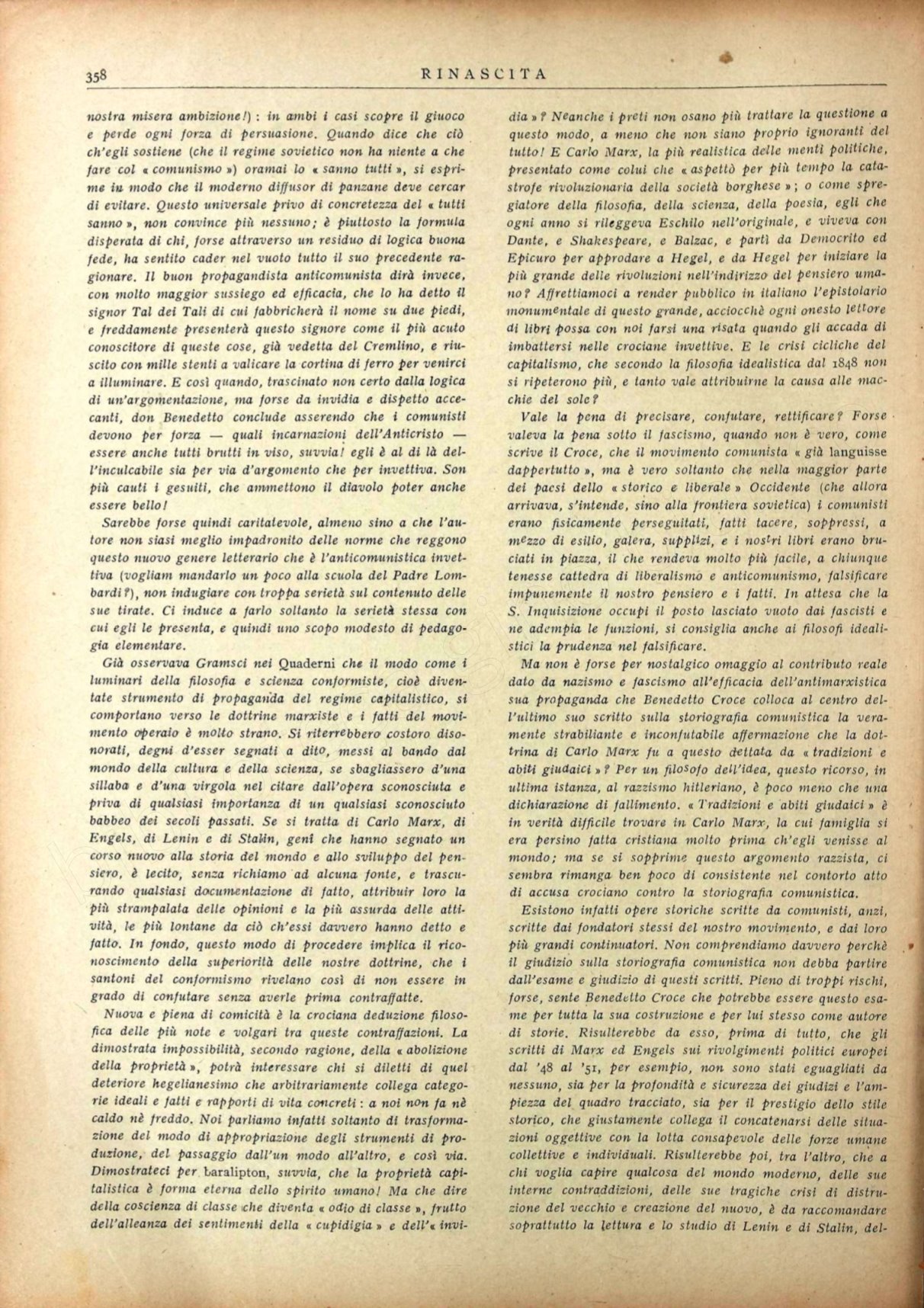
358
R I N A S C I T A
nostra misera ambizione!) : in ambi i casi scopre il giuoco
e perde ogni forza di persuasione.
Quando dice che ciò
ch'egli sostiene [che il regime sovietico non ha niente a che
fare col
a
comunismo ») oramai lo « sanno
t u t t i » ,
si espri–
me in modo che il moderno diffusor di panzane deve cercar
dì evitare. Questo universale privo di concretezza del
<t
tutti
sanno », non convìnce più nessuno; è piuttosto la formula
disperata di chi, forse attraverso un residuo di logica buona
fede, ha sentito cader nel vuoto tutto il suo precedente ra–
gionare. Il buon propagandista
anticomunista
dirà
invece,
con molto maggior sussiego ed efficacia, che lo ha detto il
signor Tal dei Tali di cui fabbricherà U nome su due piedi,
e freddamente
presenterà questo signore come il più acuto
conoscitore di queste cose, già vedetta del Cremlino, e riu–
scito con mille stenti a valicare la cortina di ferro per venirci
a illuminare. E così quando, trascinato non certo dalla logica
di un
r
argomentazìone
f
ma forse da invidia e dispetto
acce–
canti, don Benedetto
conclude asserendo che i
comunisti
devono per forza — quali incarnazioni
dell'Anticristo
—
essere anche tutti brutti in viso, suvvia! egli è al dì là del–
l' incittcabile sia per via d'argomento che per invettiva. Son
più cauti i gesuiti, che amtnettono il diavolo poter anche
essere
bello!
Sarebbe forse quindi caritatevole, almeno sino a che l'au–
tore non siasi meglio impadronito delle norme che reggono
questo nuovo genere letterario che è Vantìcomunistìca
invet–
tiva {vogliam mandarlo un poco alla scuola del Padre Lom–
bardi?), non indugiare con troppa serietà sul contenuto
delle
sue tirate. Ci induce a farlo soltanto la serietà stessa con
cui egli le presenta, e quindi uno scopo modesto di pedago–
gia
elementare.
Già osservava Gramsci nei
Quaderni
che il modo come ì
luminari della filosofia e scienza conformiste,
cioè diven–
tate strumento di propaganda del regime capitalistico,
si
comportano
verso le dottrine marxiste e i fatti del movi–
mento operaio è molto strano. Si riterrebbero costoro diso–
norati, degni d'esser
segnati a dito, messi al bando dal
mondo della cultura e della scienza, se sbagliassero
d'una
sillaba e d'una virgola nel citare dall'opera sconosciuta
e
priva di qualsiasi importanza di un qualsiasi
sconosciuto
babbeo dei secoli passati. Se sì tratta di Carlo Marx, di
Engels,
di Lenin e di StaUn, geni che hanno segnato un
corso nuovo alla storia del mondo e allo sviluppo del pen–
siero, è lecito, senza richiamo ad alcuna fonte, e trascu–
rando qualsiasi documentazione
dì fatto, attribuir loro la
più strampalata delle opinioni e la più assurda delle atti–
vità, le più lontane da ciò ch'essi davvero hanno detto e
fatto. In fondo, questo modo di procedere implica il rico–
noscimento
della superiorità delle nostre dottrine,
che ì
santoni dei conformismo
rivelano così di non essere in
grado di confutare senza averle prima
contraffatte.
Nuova e piena di comicità è la crociana deduzione
filoso–
fica delle più note e volgari ira queste contraffazioni.
La
dimostrata impossibilità, secondo ragione, della « abolizione
della proprietà
potrà interessare
chi si diletti di quel
deteriore hegelianesimo
che arbitrariamente
collega
catego–
rie ideali e fatti e rapporti di vita concreti : a noi non fa nè
caldo nè freddo. Noi parliamo infatti soltanto di trasforma–
zione del modo di appropriazione
degli strumenti di pro–
duzione, del passaggio datl'un modo all'altro, e così via.
Dimostrateci
per
baralipton,
suvvia, che la proprietà capi–
talistica è forma eterna dello spirito umano! Ma che dire
della coscienza dì classe \che diventa « odio di classe », frutto
dell'alleanza
dei sentimenti
della « cupidigia » e
dett'iinvi-
dia » f Neanche i preti non osano più trattare la questione a
questo modo, a meìio che non siano proprio ignoranti del
tutto! E Carlo Marx, la piti realìstica delle menti
politiche,
presentato come colui che « aspettò per più tempo la cata–
strofe rivoluzionaria
della società borghese*;
o come spre–
giatore della filosofia, della scienza, della poesia, egli che
ogni anno si rileggeva Eschilo nell'originale,
e viveva con
Dante, e Shakespeare,
e Balzac, e parti da Democrito
ed
Epicuro per approdare a Hegel, e da Hegel per iniziare la
piii grande delle rivoluzioni nell'indirizzo
del pensiero
uma–
no? Affrettiamoci
a render pubblico in italiano
l'epistolario
monumentale di questo grande, acciocché ogni onesto
lettore
di libri possa con noi farsi una risata quando gli accada dì
imbattersi
nelle crociane invettive.
E le crisi cicliche del
capitalismo, che secondo la filosofia idealìstica dal
1848
non
si ripeterono pìù
f
e tanto vale attribuirne la causa alle mac–
chie del sole ?
Vale la pena di precisare,
confutare,
rettificare?
Forse
valeva la pena sotto il fascismo,
quando non è vero, come
scrive il Croce, che il movimento
comunista « già
languisse
dappertutto », ma è vero soltanto che nella maggior
parie
dei paesi dello a storico e liberale*
Occidente
{che allora
1
arrivava, s'intende,
sino alla frontiera sovietica) i comunisti
erano
fisicamente
perseguitati,
fatti tacere, soppressi,
a
m
e
zzo di esìlio, galera, supplìzi, e i nostri libri erano bru–
ciati in piazza, il che rendeva molto più facile, a chiunque
tenesse cattedra di liberalismo e anticomunismo,
falsificare
impunemente
il nostro pensiero e i fatti. In attesa che la
S. Inquisizione
occupi il posto lasciato vuoto dai fascisti e
ne adempia le finizioni, sì consiglia anche ai filosofi ideali–
stici la prudenza nel
falsificare.
Ma non è forse per nostalgico omaggio al contributo
reale
dato da nazismo e fascismo all'efficacia
dell'antimarxistica
sua propaganda che Benedetto
Croce colloca al centro del–
l'ultimo suo scritto sulla storiografia comunistica
la vera–
mente strabiliante e inconfutabile
affermazione che la dot–
trina di Carlo Marx fu a questo dettata da « tradizioni e
abiti giudaici » ? Per un filosofo dell'idea, questo ricorso, in
ultima istanza, al razzismo hitleriano, è poco meno che una
dichiarazione di fallimento.
« Tradizioni e abiti giudaici » è
in verità difficile trovare in Carlo Marx, la cui famiglia si
era persino fatta cristiana molto prima ch'egli
venisse al
mondo; ma se si sopprime
questo argomento
razzista, ci
sembra rimanga ben poco di consistente
nel contorto
atto
di accusa crociano contro la storiografia
comunìstica.
Esistono
infatti opere storiche scrìtte da comunisti,
anzi,
scritte dai fondatori stessi del nostro movimento,
e dai loro
più grandi continuatori. Non comprendiamo
davvero perchè
il giudizio sulla storiografia comunìstica non debba partire
dall'esame e giudizio di questi scrìtti. Pieno di troppi
rischi,
forse, sente Benedetto Croce che potrebbe essere questo esa–
me per tutta la sua costruzione e per lui stesso come autore
di storie. Risulterebbe
da esso, prima di tutto, che gli
scrìtti di Marx ed Engels sui rivolgimenti
politici
europei
dal
'48
al
'51,
per esempio, non sono stati eguagliati da
nessuno, sia per la profondità e sicurezza dei giudizi e l'am–
piezza del quadro tracciato, sia per il prestigio
dello
stile
storico, che giustamente
collega il concatenarsi
delle situa–
zioni oggettive con la lotta consapevole
delle forze
umane
collettive e individuali.
Risulterebbe
poi, tra l'altro, che a
chi voglia capire qualcosa del mondo moderno,
delle sue
interne contraddizioni,
delle sue tragiche
crisi di distru–
zione del vecchio e creazione del nuovo, è da raccomandare
soprattutto la lettura e lo studio di Lenin e di Stalin, del-