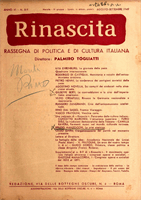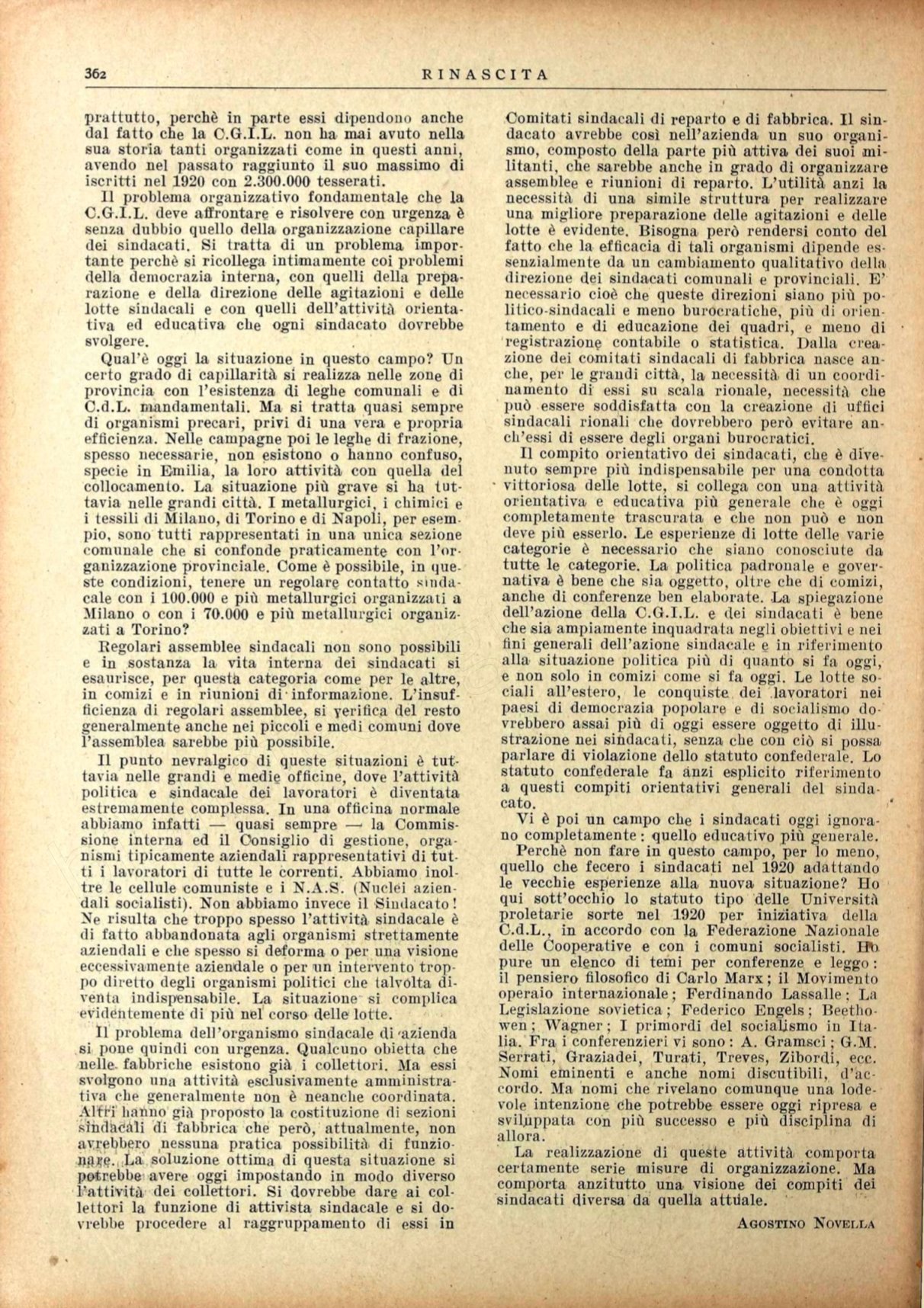
362
R I N A S C I T A
prattutto, perchè in parte essi dipendono anche
dal fatto che la C . G X L . non ha mai avuto nella
sua storia tanti organizzati come in questi anni,
avendo nel passato raggiunto i l suo massimo di
iscritti nel 1920 con 2.300.000 tesserati.
I l problema organizzativo fondamentale che la
C . G X L . deve affrontare e risolvere con urgenza è
senza dubbio quello della organizzazione capillare
dei sindacati. Si tratta di un problema impor–
tante perchè si ricollega intimamente coi problemi
della democrazia interna, con quelli della prepa–
razione e della direzione delle agitazioni e delle
lotte sindacali e con quelli dell'attività orienta–
tiva ed educativa che ogni sindacato dovrebbe
svolgere.
QuaFè oggi la situazione in questo campo? Un
certo grado di capillarità si realizza nelle zone di
provincia con l'esistenza di leghe comunali e di
C.d.L. mandamentali. Ma si tratta quasi sempre
di organismi precari, privi di una vera e propria
efficienza. Nelle campagne poi le leghe di frazione,
spesso necessarie, non esistono o hanno confuso,
specie in Emi l ia, la loro attività con quella del
collocamento. La situazione più grave si ha tut–
tavia nelle grandi città, I metallurgici, i chimici e
i tessili di Milano, di Torino e di Napoli, per esem
pio, sono tutti rappresentati in una unica sezione
comunale che si confonde praticamente con l'or–
ganizzazione provinciale. Come è possibile, in que–
ste condizioni, tenere un regolare contatto sinda–
cale con i 100.000 e più metallurgici organizzati a
Milano o con i 70.000 e più metallurgici organiz–
zati a Torino?
Regolari assemblee sindacali non sono possibili
e in sostanza la vita interna dei sindacati si
esaurisce, per questà categoria come per le altre,
in comizi e in riunioni di informazione. L'insuf–
ficienza di regolari assemblee, si verifica del resto
generalmente anche nei piccoli e medi comuni dove
l'assemblea sarebbe più possibile.
I l punto nevralgico di queste situazioni è tut–
tavia nelle grandi e medie officine, dove l'attività
politica e sindacale dei lavoratori è diventata
estremamente complessa. In una officina normale
abbiamo infatti — quasi sempre —
j
la Commis–
sione interna ed i l Consiglio di gestione, orga–
nismi tipicamente aziendali rappresentativi di tut–
ti i lavoratori di tutte le correnti. Abbiamo inol–
tre le cellule comuniste e i N.À. S . (Nuclei azien–
dali socialisti). Non abbiamo invece i l Sindacato!
Ne risulta che troppo spesso l'attività sindacale è
di fatto abbandonata agli organismi strettamente
aziendali e che spesso si deforma o per una visione
eccessivamente aziendale o per un intervento trop–
po diretto degli organismi politici che talvòlta di–
venta indispensabile. La situazione sì complica
evidéiitemente di più nel corso delle lotte.
I l problema dell'organismo sindacale di'azienda
si pone quindi con urgenza. Qualcuno obietta che
nelle- fabbriche esistono già i collettori. Ma essi
svolgono una attività esclusivamente amministra–
tiva che generalmente non è neanche coordinata.
Altfr hanno già proposto la costituzione d! sezioni
sihdadàli di fabbrica che però, attualmente, non
avrebbero nessuna pratica possibilità di funzio-
^ Ì g .
i :
L à soluzione ottima di questa situazione sì
potrebbe avere oggi impostando in modo diverso
l 'attività dei collettori. Si dovrebbe dare ai col–
lettori la funzione di attivista, sindacale e si do–
vrebbe procedere al raggruppamento di essi in
Comitati sindacali di reparto e di fabbrica. I l sin–
dacato avrebbe così nell'azienda un suo organi–
smo, composto della parte più attiva dei suoi mi–
litanti,
che sarebbe anche in grado di organizzare
assemblee e riunioni di reparto. L'utilità anzi la
nece
ssità di una simile struttura per realizzare
una
migliore preparazione delle agitazioni e delle
lotte è evidente. Bisogna però rendersi conto del
fatto che
la efficacia di tali organismi dipende es–
senzialmente da un cambiamento qualitativo della
direzione dei sindacati comunali e provinciali.
E '
necessario cioè
che queste direzioni siano più po–
litico-sindacali
e
meno
burocratiche,
più di orien–
tamento e di educazione dei quadri, e meno di
registrazione contabile o statistica.
Dalla crea–
zione dei comitati sindacali
di fabbrica nasce an–
che, per
le grandi città, la necessità di un coordi–
namento
di essi su scala
rionale, necessità che
può essere soddisfatta con la creazione
di uffici
sindacali rionali che dovrebbero però evitare an–
ch
'essi di essere degli organi burocratici.
I l compito orientativo dei sindacati, che è dive–
nuto sempre più indispensabile per una condotta
vittoriosa
delle lotte,
si collega
con una
att ivi tà
orientativ
a e
educativa più
generale che è oggi
completamente trascurata e che non può e non
deve più esserlo. Le esperienze di lotte delle varie
categorie è necessario che
siano
conosciute da
tutte le categorie. La politica padronale e gover–
nativa è bene che
sia
oggetto,
oltre che di comizi,
anche di conferenze ben elaborate. La
spiegazione
dell'azione della
C
. G . I . L .
e
dei sindaca
ti è bene
che sia ampiamente inquadrata negli
obiettivi e nei
fini generali dell'azione sindacale e in riferimento
alla situazione
politica più di
quanto si fa oggi
,
e non solo in comizi come si fa oggi. Le lotte so–
ciali
all
'estero,
le conquiste dei lavoratori nei
paesi di democrazia popolare
e
di
s
ocialismo do–
vrebbero assai più di oggi essere oggetto di illu–
strazione nei sindacati
,
senza che con
ciò
si possa
parlare di violazione dello statuto confederale. Lo
statuto confederale fa anzi esplicito riferimento
a questi compiti orientativi generali del sinda–
cato.
V i è poi un campo che
i
sindacati oggi ignora–
no completamente: quello educativo più
generale.
Perchè non fare in questo campo, per lo meno,
quello che fecero i sindacati nel 1920 adattando
le vecchie esperienze alla nuova situazione? Ho
qui sott'occhio lo statuto tipo delle Università
proletarie sorte nel 1920 per iniziativa della
C. d .L. , in accordo con la Federazione Nazionale
delle Cooperative e con i comuni socialisti. Hfe
pure un elenco di temi per conferenze e leggo :
il pensiero filosofico di Carlo Marx ; i l Movimento
operaio internazionale ; Ferdinando Lassalle :
La
Legislazione sovietica; Federico Engels; Beetho-
wen ; Wagner
; I
primordi del socialismo in Ita–
lia. Fr a
i
conferenzieri vi sono : A . Gramsci ; G.M.
Serrati, Graziadei, Turati, Treves, Zibordì, ecc.
Nomi eminenti e anche nomi discutibili,
d'ac–
cordo. Ma nomi che rivelano comunque una lode–
vole intenzione òhe potrebbe essere oggi ripresa
e
sviluppata con più successo e più disciplina di
allora.
La realizzazione di queste att ivi tà comporta
certamente serie misure di organizzazione. Ma
comporta anzitutto una visione dei compiti dei
sindacati diversa da quella attiiale.
AGOSTINO NOVELLA