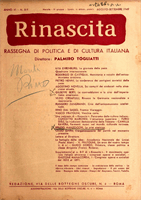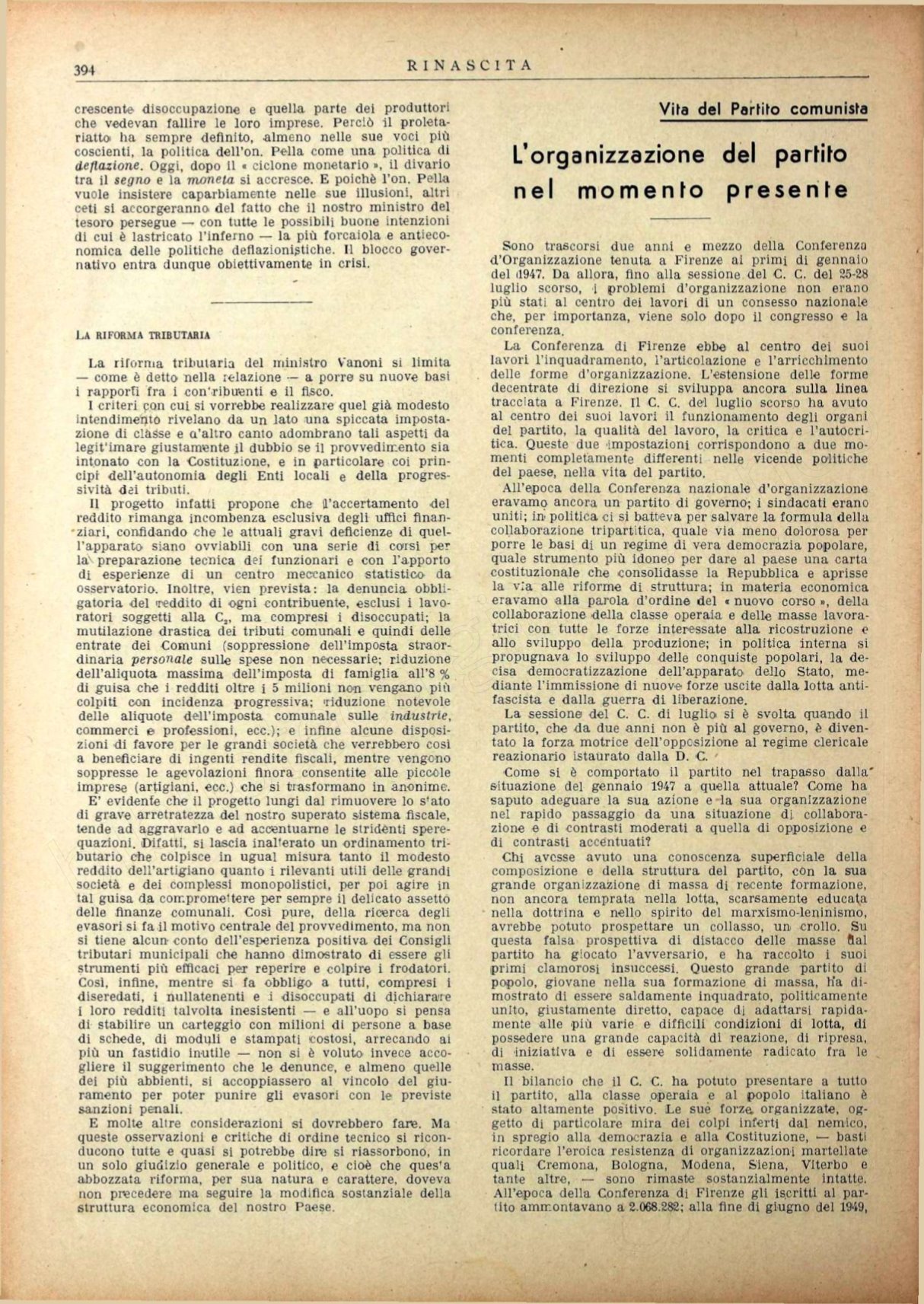
3 9 4
R I N A S C I T A
crescente disoccupazione e quella parte dei produttori
che vedevan fallire le loro imprese. Perciò i l proleta-
riatto ha sempre definito, -almeno nelle sue voci più
coscienti, la polìtica dell'on. Fella come una politica di
deflazione.
Oggi, dopo i l « ciclone monetario », i l divario
tra i l
segno
e la
moneta
si accresce. E poiché l 'on. Polla
vuole insistere caparbiamente nelle sue illusioni , al t r i
ceti si accorgeranno del fatto che i l nostro ministro del
tesoro persegue — con tutte le possibili buone intenzioni
di cui è lastricato l'inferno — la più forcatola e antieco–
nomica delle politiche deflazionistiche. I l blocco gover–
nativo entra dunque obiettivamente in crisi.
LA RIFORMA TRIBUTARIA
La riforma tributaria del ministro Vaironi si l imi ta
— come è detto nella relazione — a porre su nuove basi
i rapporti fra i contribuenti e 11 fisco.
I criteri con cui si vorrebbe realizzare quel già modesto
intendimento rivelano da un lato una spiccata imposta–
zione di classe e d'altro canto adombrano tal i aspetti da
legì t ' ìmare giustamente .il dubbio se i l provvedimento sia
intonato con la Costituzione, e in particolare coi prin–
cipi dell'autonomia degli Enti locali e della progres–
sività del tribut i .
I I progetto infat t i propone che d'accertamento dei
reddito rimanga incombenza esclusiva degli uffici finan-
-ziari, confidando che le attuali gravi deficienze di quel*
l'apparato siano ovviabili con una serie di corsi per
la- preparazione tecnica dei funzionari e con l'apporto
di esperienze di un centro meccanico statistico da
osservatorio. Inoltre, vien prevista: la denuncia obbli–
gatoria del "reddito d i ogni contribuente, esclusi i lavo–
ratori soggetti alla C
3
, ma compresi i disoccupati; la
mutilazione drastica dei t r ibut i comunali e quindi delle
entrate dei Comuni (soppressione dell'imposta straor–
dinaria
personale
sullo spese non necessarie; riduzione
dell'aliquota massima dell'imposta dì famiglia alP8 %
di guisa che i redditi oltre i 5 mi l ioni non vengano più
colpiti con incidenza progressiva; "riduzione notevole
delle aliquote dell'imposta comunale sulle
industrie,
commerci & professioni, ecc.); e infine alcune disposi–
zioni di favore per le grandi società che verrebbero così
a beneficiare di ingenti rendite fiscali, mentre vengono
soppresse le agevolazioni finora consentite alle piccole
imprese (artigiani, ecc.) che si trasformano in anonime.
E' evidente che i l progetto lungi dal rimuovere lo steto
di grave arretratezza del nostro superato sistema fiscale,
tende ad aggravarlo e ad accentuarne le stridenti spere–
quazioni. Difatti , si lascia inalterato un ordinamento t r i –
butario che colpisce in ugual misura tanto i l modesto
reddito dell'artigiano quanto i rilevanti ut i l i delle grandi
società e dei complessi monopolistici, per poi agire in
lai guisa da compromettere per sempre i l delicato assetto
delle finanze comunali. Così pure, della ricerca degli
evasori si f a l l motivo centrale del provvedimento, ma non
si tiene alcun'conto dell'esperienza positiva dei Consigli
tributari municipali che hanno dimostrato d i essere gl i
strumenti più efficaci per reperire e colpire i frodatori.
Cosi, infine, mentre si fa obbligo a tut t i , compresi i
diseredati, i nullatenenti e i disoccupati d i dichiarare
1 loro redditi talvolta inesistenti — e all'uopo si pensa
dì stabilire un carteggio con mi l ioni di persone a base
di schede, di moduli e stampati costosi, arrecando ai
più un fastidio inutile — non si è voluto invece acco–
gliere i l suggerimento che le denunce, e almeno quelle
dei più abbienti, si accoppiassero al vincolo del giu–
ramento per poter punire gl i evasori con le previste
sanzioni penali.
E molte altre considerazioni si dovrebbero fare. Ma
queste osservazioni e critiche di ordine tecnico si ricon–
ducono tutte e quasi si potrebbe dire si riassorbono, in
un solo giudizio generale e politico, e cioè che queste
abbozzata riforma, per sua natura e carattere, doveva
non precedere ma seguire la modifica sostanziale della
struttura economica del nostro Paese.
Vi ta del Par l i lo comun i s t e
L'organizzazione del partito
nel momento p r esen t o
Sono trascorsi due anni e mezzo della Conferenza
d'Organizzazione tenuta a Firenze ai pr imi di gennaio
del il947. Da allora, fino alla sessione del C. C. del 25-28
luglio scorso, i problemi d'organizzazione non erano
più stati al centro dei lavori di un consesso nazionale
che. per importanza, viene solo dopo i l congresso e la
conferenza.
La Conferenza di Firenze ebbe al centro dei suoi
lavori l'inquadramento, l'articolazione e l'arricchimento
delle forme d'organizzazione. L'estensione delle forme
decentrate di direzione si sviluppa ancora sulla linea
tracciata a Firenze, i l C. C. del luglio scorso ha avuto
al centro dei suoi lavori i l funzionamento degli organi
del partito, la qual i tà del lavoro, la critica e l'autocri–
tica. Queste due impostazioni corrispondono a due mo–
menti completamente differenti nelle vicende politiche
del paese, nella vita del partito.
All'epoca della Conferenza nazionale d'organizzazione
eravamo ancora un partito di governo; i sindacati erano
uni t i ; lai politica ci si batteva per salvare la formula della
collaborazione tripartitica, quale via meno dolorosa per
porre le basi dì un regime di vera democrazia popolare,
quale strumento più idoneo per dare al paese una carta
costituzionale che consolidasse la Repubblica e aprisse
la vìa alle riforme di struttura; i n materia economica
eravamo alla parola d'ordine del «nuovo corso della
collaborazione della classe operaia e delle masse lavora–
t r i c i con tutte le forze interessate alla ricostruzione e
allo sviluppo della produzione; in polìtica interna sì
propugnava lo sviluppo delle conquiste popolari, la de–
cisa democratizzazione dell'apparato' dello Stato, me–
diante l'immissione di nuove forze uscite dalla lotta anti–
fascista e dalla guerra d i liberazione.
La sessione del C. C. di lugl io si è svolta quando i l
partito, che da due anni non è più al governo, è diven–
tato la forza motrice dell'opposizione al regime clericale
reazionario istaurato dalla D. C
'
Come si è comportato i l partito nel trapasso dal la'
situazione del gennaio 1947 a quella attuale? Come ha
saputo adeguare la sua azione e da sua organizzazione
nel rapido passaggio da una situazione di collabora–
zione e di contrasti moderati a quella di opposizione e
di contrasti accentuati?
Chi avesse avuto una conoscenza superficiale della
composizione e della struttura del partito, con la sua
grande organizzazione di massa di recente formazione,
non ancora temprata nella lotta, scarsamente educata
nella dottrina e nello spirito del marxismo-leninismo,
avrebbe potuto prospettare un collasso, un crollo. Su
questa falsa prospettiva di distacco delle masse dal
partito ha giocato l'avversario, e ha raccolto i suoi
primi clamorosi insuccessi. Questo grande partito di
popolo, giovane nella sua formazione di massa, h'a di–
mostrato di essere saldamente Inquadrato, politicamente
unito, giustamente diretto, capace di adattarsi rapida–
mente alle più varie e diffici l i condizioni dì lotta, di
possedere una grande capaci tà di reazione, di ripresa,
di iniziativa e di essere solidamente radicato fra le
masse.
I l bilancio che i l C. C. ha potuto presentare a tutto
i l partito, alla classe operaia e al popolo italiano è
stato altamente positivo. Le sue forza organizzate, og–
getto di particolare mira dei colpi inferii dal nemico,
in spregio alla democrazia e alla Costituzione, — basti
ricordare l'eroica resistenza di organizzazioni martellate
quali Cremona, Bologna, Modena, Siena, Viterbo e
tante altro, — sono rimaste sostanzialmente intatte.
All'epoca della Conferenza di Firenze gl i Iscritti al par–
l i lo ammontavano a 2.068.282; alla fine di giugno del 1949,