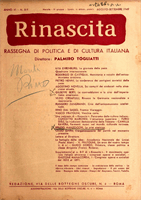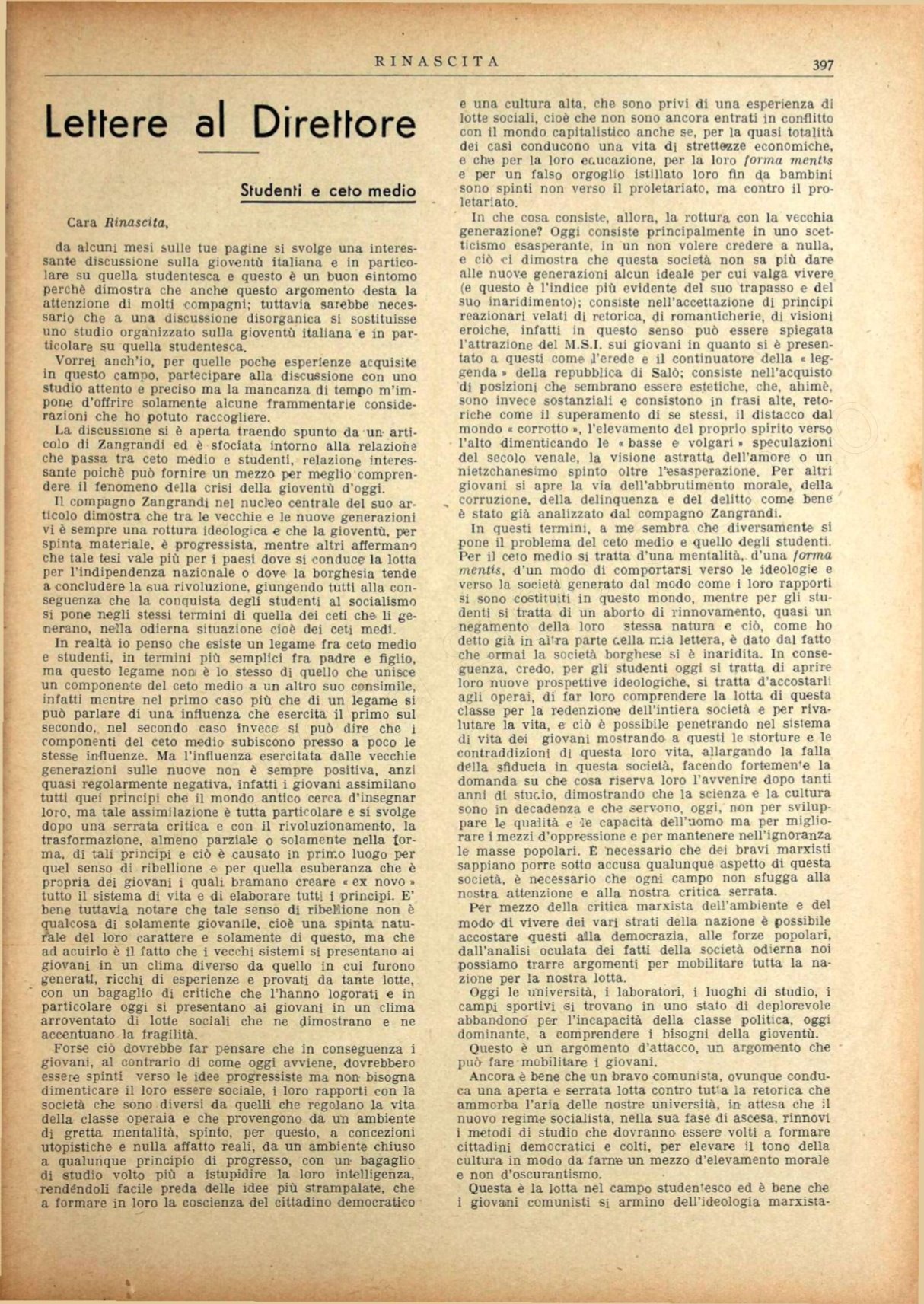
R I N A S C I T A
397
Lettere al Direttore
Student i e ceto med i o
•
Cara
Rinascita,
da alcuni mesi sulle tue pagine si
svolge
una interes–
sante
discussione
sulla gioventù italiana e
in
partico–
lare
su
quella studentesca e questo
è un buon sintomo
perchè
dimostra
che
anche questo argomento
-desta la
attenzione
dì
mol t i -compag
ni; tuttavia
sarebbe neces–
sario che a una discussione disorganica si sostituisse
uno
studio organizzato sulla gioventù italiana e in par–
ticolare
su
quella
studentesca.
Vorrei anch'io, per quelle poche
esperienze acquisite
in questo
campo,
partecipare alla discussione con uno
studio attento
e
preciso
ma
la mancanza
di
tempo m
' im–
pone
d
'offrire solamente alcune
frammentarie
conside–
razioni che ho potuto raccogliere.
La discussione si è aperta traendo spunto da un art ì–
colo di Zangrandi ed è sfociata intorno alla relazione
che passa tra ceto medio e studenti,
relazione
interes–
sante poiché può fornire un mezzo per meglio compren–
dere i l fenomeno
della
crisi della gioventù
d
'oggi.
I l
compagno Zangrandi
nel nucleo centrale del suo ar–
ticolo
dimostra
che tra
le vecchie e le
nuove generazioni
vi è sempre una rottura
ideologica
e
che
la gioventù, per
spinta materiale, è progressista,
mentre a l t r i affermano
che tale tesi vale più per i paesi dove si
conduce
la
lotta
per l'indipendenza nazionale o dove la borghesìa tende
a concludere
la
sua rivoluzione, giungendo
tut t i alla con–
seguenza che la conquista degli studenti al socialismo
si pone
negli stessi termini di quella dei ceti che l i ge–
nerano, nella
odierna situazione cioè dei ceti medi.
In real tà io penso
che
esiste un legame fra ceto medio
e studenti,
in termini più semplici fra padre e figlio,
ma questo legame non
è lo stesso
di quello che unisce
un componente
del ceto medio
a
un
altro
suo consimile,
infatti mentre nel primo caso più che di un legame si
può parlare
di
una influenza che esercita i l primo
sul
secondo, nel secondo
caso invece
si può dire che
i
componenti del ceto medio
subiscono
presso a poco le
stesse
influenze.
Ma l
'influenza
esercitata
dalle vecch
ie
generazioni
sulle
nuove non
è
sempre positiva,
anzi
quasi regolarmente
negativa, infat t i i giovani assimilano
tut t i quei
prìncipi che i l
mondo
antico cerca d'insegnar
loro, ma tale
assimilazione è tutta particolare e
si svolge
dopo una serrata critica
e con
i l
rivoluzionamento, la
trasformazione, almeno parziale o
solamente
nella
for–
ma, di tal i principi e
ciò
è
causato in
primo luogo per
quel senso
d i
ribellione e per quella esuberanza che è
propria
dei
giovani i quali bramano creare
• ex novo •
tutto
i l
sistema di
vita e d i elaborare tutti i princìpi .
E'
bene tuttavia notare che tale senso di ribellione non è
qualcosa di
solamente giovanile, cioè una spinta natu–
rale
del loro carattere
e solamente
di
questo, ma che
ad
acuirlo è i l fatto
che
i vecchi sistemi si
presentano
ai
giovani in un clima
diverso da quello
in
cui
furono
generati, r icchi di esperienze e
provati
da tante lotte,
con
un bagaglio di
critiche che
l'hanno logorati e in
particolare oggi
si presentano ai
giovani in un clima
arroventato di lotte sociali che
ne
dimostrano e
ne
accentuano la
iragilitù.
Forse ciò dovrebbe far pensare
che in conseguenza
i
giovani, al contrario di come
oggi
avviene, dovrebbero
essere spinti
verso le idee progressiste ma non
bisogna
dimenticare
i l loro essere
sociale, i loro rapporti con la
società che
sono diversi da quelli che
regolano la vita
della classe operaia
e che provengono da un ambiente
dì gretta mental i tà, spinto, per questo, a concezioni
utopistiche e nulla
affatto reali,
da un
ambiente
chiuso
a qualunque
principio di progresso, con un
bagaglio
di studio volto più
a
istupidire la loro intelligenza,
rendendoli facile preda delle
idee
più
strampalate, che
a formare in
loro la
coscienza
del cittadino
democratico
e una cultura alta, che sono pr ivi di una esperienza di
lotte sociali, cioè che non sono ancora entrati in
conflitto
con
i l mondo capitalistico
anche se, per
la quasi total i tà
dei casi conducono una vita di strettwze economiche,
e
eh© per la loro educazione, per la loro
forma
mentis
e per un falso orgoglio istillato loro fin
d£
bambini
sono spinti non
verso
iì proletariato, ma contro i l pro–
letariato.
In che cosa consiste, allora, l a rottura con la vecchia
generazione? Oggi consiste principalmente in uno
scet–
ticismo esasperante, in
un non volere credere
a nulla,
e ciò c i dimostra che questa società non sa più dare
alle
nuove generazioni
alcun ideale
per cui
valga vìvere
(e
questo
è
l'indice più evidente del suo trapasso
e
del
suo inaridimento); consiste nell'accettazione di principi
reazionari velati di retorica, di romanticherie, di visioni
eroiche, infat t i in questo senso può essere spiegata
l
'attraz
ione del M.S.L sui giovani in quanto si è presen–
tato a
questi come J'erede e i l continuatore della « leg–
genda »
della repubblica di Salò;
consiste nell
'acquisto
di posizioni che sembrano essere estetiche, che, ahimè,
sono invece sostanziali e
consistono
in frasi alte, reto–
riche come 11 superamento di se stessi, i l distacco dal
mondo « corretto l'elevamento del proprio spirito verso
l'alto dimenticando le « basse
e
volgari » speculazioni
del secolo venale, la visione astratta dell'amore o un
nietzchanesimo spinto oltre l'esasperazione. Per al tri
giovani
sì apre la via dell'abbrutimento morale, della
corruzione,
della delinquenza e del delitto come bene
è stato
già analizzato dal compagno Zangrandi.
In questi termini,
a me sembra che diversamente
si
pone ìl problema
del ceto
medio e quello degli studenti.
Per
i l
ceto medio
si
tratta d'una
mental i tà,
,
d
'una
forma
mentis,
d'un modo di comportarsi verso
le
ideologie
e
verso
la società generato dal modo come i loro rapporti
si
sono costituiti in questo mondo, mentre per
gl i
stu–
denti si tratta di un aborto di rinnovamento, quasi un
negamento della loro stessa natura e ciò, come ho
detto già
in
altra parte
cella
mia lettera, è dato dal
fatto
che ormai la
società
borghese si è inaridita. In conse–
guenza, credo, per gl i studenti oggi si tratta di aprire
loro nuove prospettive ideologiche, si tratta d'accostarli
agli
operai,
dì far loro comprendere la
lotta
di questa
classe
per la redenzione dell'intiera società
e
per riva–
lutare la vita,
e ciò è
possibile penetrando nel sistema
di vita dei giovani mostrando a questi le storture e le
contraddizioni
di questa
loro vita,
allargando la
falla
dèlia sfiducia in questa
società, facendo
fortemente la
domanda su che cosa riserva loro l'avvenire dopo tanti
anni
di stucio, dimostrando
che la scienza e
la cultura
sono
in decadenza e che
servono, oggi, non
per svilup–
pare 1©
qual i tà
e ìe
capaci tà dell'uomo ma per miglio–
rare i mezzi d'oppressione e per mantenere
nell'ignoranza
le
masse popolari. E necessario che
dei
bravi marxisti
sappiano porre sotto accusa qualunque aspetto di questa
società, è necessario che ogni campo non sfugga alla
nostra attenzione
e
alla nostra critica serrata.
Per mezzo della critica marxista dell'ambiente e del
modo d i vivere dei vari strati delia nazione
è possibile
accostare questi alla democrazìa,
alte forze popolari,
dall'analisi oculata dei fatti della
socie
tà odierna noi
possiamo trarre argomenti per mobilitare tutta la na–
zione per la nostra lotta.
Oggi le universi tà, i laboratori, i luoghi di studio, i
campi sportivi
si
trovano in uno
stato
di deplorevole
abbandono
per l
' incapaci tà della classe politica, oggi
dominante, a comprendere i bisogni della gioventù.
Questo è un argomento d'attacco, un argomento che
può fare mobilitare i
giovani.
Ancora è bene che un bravo comunista,
ovunque condu–
ca una aperta e serrata lotta contro tutta la retorica che
ammorba l'aria delle nostre università,
i n
attesa che i l
nuovo regime socialista, nella sua fase di ascesa, rinnovi
i metodi d i studio che dovranno essere vol t i a formare
cittadini democratici e colti, per elevare i l tono della
cultura in modo da farne un mezzo d'elevamento morale
e
non d'oscurantismo.
Questa
è
la lotta nel campo studentesco
ed è
bene che
i giovani comunisti
SÌ
armino dell'ideologia marxista-