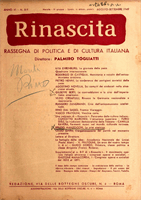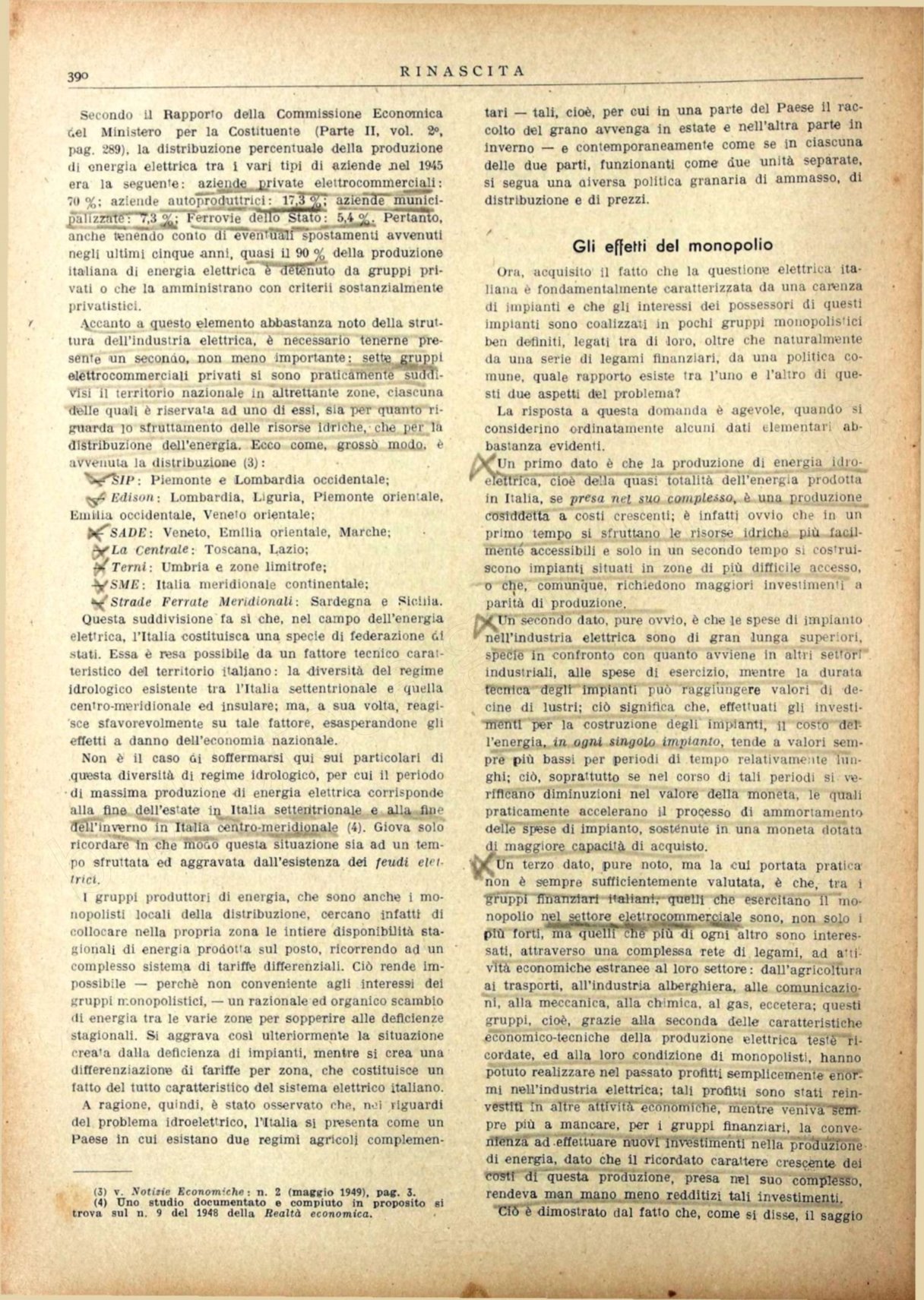
39o
R I N A S C I T A
Secondo i l Rapporto delia Commissione Economica
nel Ministero per la Costituente (Parte I I , voi .
2°,
pag. 289), la distribuzione percentuale della produzione
di energia elettrica tra i vari t ipi di aziende nel 1945
era la seguente : aziende jyiva t e elettrocommerciali :
7tl %; aziende autopfoduttrici: 17/3%; azienae^muntcì -
j
&l l za f l t f i :
" f f i f f i ' f e r r ov i e dello Stato: 5^%, Pertam
anche
tenendo conto dT"^entu3! l f^póstament i avvenuti
negli ul t imi cinque anni, quasi U 90 % della produzione
italiana di energia elettrica è detenuto da gruppi pr i –
vati o che la amministrano con criteri! sostanzialmente
privatistici.
Accanto a questo elemento abbastanza noto della strut–
tura dell'industria elettrica, è necessario tenerne pre–
sente un secondo, non meno importante: sette gruppi
elettrocommercialì privati si sono praticamente suddi–
visi i l territòrio nazionale in altrettante zone, ciascuna
delle quali è riservata ad uno di essi, sia per quanto r i –
guarda io sfruttamento delle risorse Idriche,-che per la
distribuzione dell'energia. Ecco come, grosso modo, è
avvenuta la distribuzione (3):
^<**5
J
/': Piemonte e Lombardia occidentale;
^
Edison \
Lombardia, Liguria, Piemonte orientale,
Emilia occidentale, Veneto orientale;
Ì^SABE
:
Veneto, Emilia orientale, Marche;
$fLa
Centrale;
Toscana, Lazio;
m Terni ;
Umbria e zone limìtrofe;
tySME;
Italia meridionale continentale;
^Strade
Ferrate
Meridionali
: Sardegna e Sicilia.
Questa suddivisione fa si che, nel campo dell'energia
elettrica, l ' I tal ia costituisca una specie di federazione òl
stati. Essa è resa possibile da un fattore tecnico carat–
teristico del territorio italiano: la diversi tà del regime
idrologico esistente tra l ' I tal ia settentrionale e quella
centro-meridionale ed insulare; ma, a sua volta, reagi–
sce sfavorevolmente su tale fattore, esasperandone gl i
effetti a danno dell'economia nazionale.
Non è i l caso
GÌ
soffermarsi qui sui particolari dì
.questa diversità di regime idrologico, per cui i l periodo
•di massima produzione -di energia elettrica corrisponde
alla fine dell'estate in Italia setteittrionale e alla fin-
1
rléll'inverno in Italia centro-meridionale (4). Giova solo
ricordare in che modo questa situazione sia ad un tem–
po sfruttata ed aggravata dall'esistenza dei
feudi
elet–
trici.
I gruppi produttori di energia, che sono anche i mo–
nopolisti locali della distribuzione, cercano infat t i di
collocare nella propria zona le intiere disponibi l i tà sta–
gionali di energia prodotta sul posto, ricorrendo ad un
complesso sistema di tariffo differenziali. Ciò rende im–
possibile — perchè non conveniente agli interessi dei
gruppi monopolistici, — un razionale ed organico scambio
di energìa tra le varie zone per sopperire alle deficienze
stagionali. Si aggrava così ulteriormente la situazione
creata dalla deficienza di impianti, mentre si crea una
differenziazione dì tariffe per zona, che costituisce un
fatto del tutto caratteristico del sistema elettrico italiano.
A ragione, quindi, è stato osservato che, noi riguardi
del problema idroelettrico, ]'"Italia si presenta come un
Paese in cui esistano due regimi agricoli complemen–
t i v.
Notizie Economiche:
n. 2 (maggio 1949), pag. 3.
(4) Uno studio documentato e compiuto in proposito si
trova sul n. 9 del 194S della
Realtà
economica.
tar i — tal i , cioè, per cui in una parte de) Paese i l rac–
colto del grano avvenga i n estate e nell 'altra parte In
Inverno — e contemporaneamente come se in ciascuna
delle due parti, funzionanti come due uni t à separate,
si segua una diversa
politica
granaria dì ammasso, dì
distribuzione e di prezzi.
G l i effetti del mo n o p o l i o
Ora, acquisito i l fatto che la questione elettrica ita–
liana
è fondamentalmente caratterizzata da una carenza
di impianti e che gl i interessi
dei possessori
di questi
impiant i sono coalizzati
in
pochi gruppi monopolistici
ben definiti, legati tra di
loro,
oltre che naturalmente
da una serie di legami finanziari,
da una politica co–
mune, quale rapporto
esiste tra l'uno e l 'altro
di que–
sti due aspetti del prob
lema?
La risposta a
questa domanda è agevole,
quando si
considerino ordinatamente
alcuni
dati elementari ab–
bastanza evidenti,
A
^ U n
primo dato è
che la
produzione di energia
idru-
f
elettrica,
cioè della quasi totalità dell'energia prodotta
in Italia, se presa
nel
suo complessa,
è una produzione
cosiddetta a costi
crescenti; è infatt} ovvio che in
un
primo tempo si sfruttano le risorse idriche più facil–
mente accessibili e solo in un secondo tempo
si
costrui–
scono impianti situati in zone di più difficile
accesso,
o che, comunque, richiedono maggiori
Investimenti a
par i tà di produzione.
y Un secondo dato, pure ovvio, è che le spese di impianto
^nel l
' indust r ia elettrica sono dì gran
lunga superiori,
specie i n confronto con quanto avviene in
al t r i settóri
industriali, alle spese di esercizio, mentre la durata
tecnica degli impiant i può raggiungere valori di
de-
k
cine di lustri ; ciò significa che, effettuati gl i investi–
menti per la costruzione degli' impiant i , n costo del–
l'energia,
in ogni singolo impianto,
tende
a valori sem–
pre più bassi per periodi di tempo
relativamente
lun–
ghi; ciò, soprattutto se nel corso di tal i periodi
si ve–
rificano diminuzioni nel valore della moneta, le quali
praticamente accelerano U proqesso di ammortamento
delle spese di impianto, sostenute in una moneta
dotata
di maggiore capaci tà di acquisto.
v un terzo dato, pure noto, ma la cuj portata pratica
non è
sempre sufficientemente valutata, è che, tra i
gruppi finanziari I tal iani ; quelli che esercitano i l mo–
nopolio ne l ^ t l o r e^ elctuocoininerc^ale sono, non
solo
i
più forti,
ma qTO f P r c n F p n ^ i
ogni
altro sono
interes–
sati, attraverso una complessa rete di legami, ad atti*
vìtà economiche estranee ; i l [uro settore: dall'agricoltura
ai trasporti, all ' industria alberghiera, alle comunicazio–
ni , alla meccanica, alla chimica, al gas, eccetera; questi
gruppi, cioè, grazie alla seconda delle caratteristiche
ecònomico-tecniche della produzione elettrica teste " r i –
cordate, ed alla loro condizione di monopolisti, hanno
potuto realizzare nel passato profitti semplicemente enor–
mi nell'industria elettrica; tal i profitti sono stati rein–
vestiti In altre at t ivi tà economiche, mentre veniva sem–
pre più a mancare, per i gruppi finanziari, la conve–
nienza ad effettuare nuovi investimenti nella produzione
di energia, dato che i l ricordato carattere crescente dei
costi di questa produzione, presa nei suo complesso,
rendeva man mano meno redditizi t a l i investimenti.
Ciò è dimostrato dal fatto che, come si disse, i l saggio