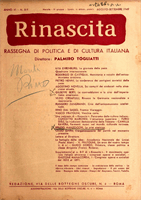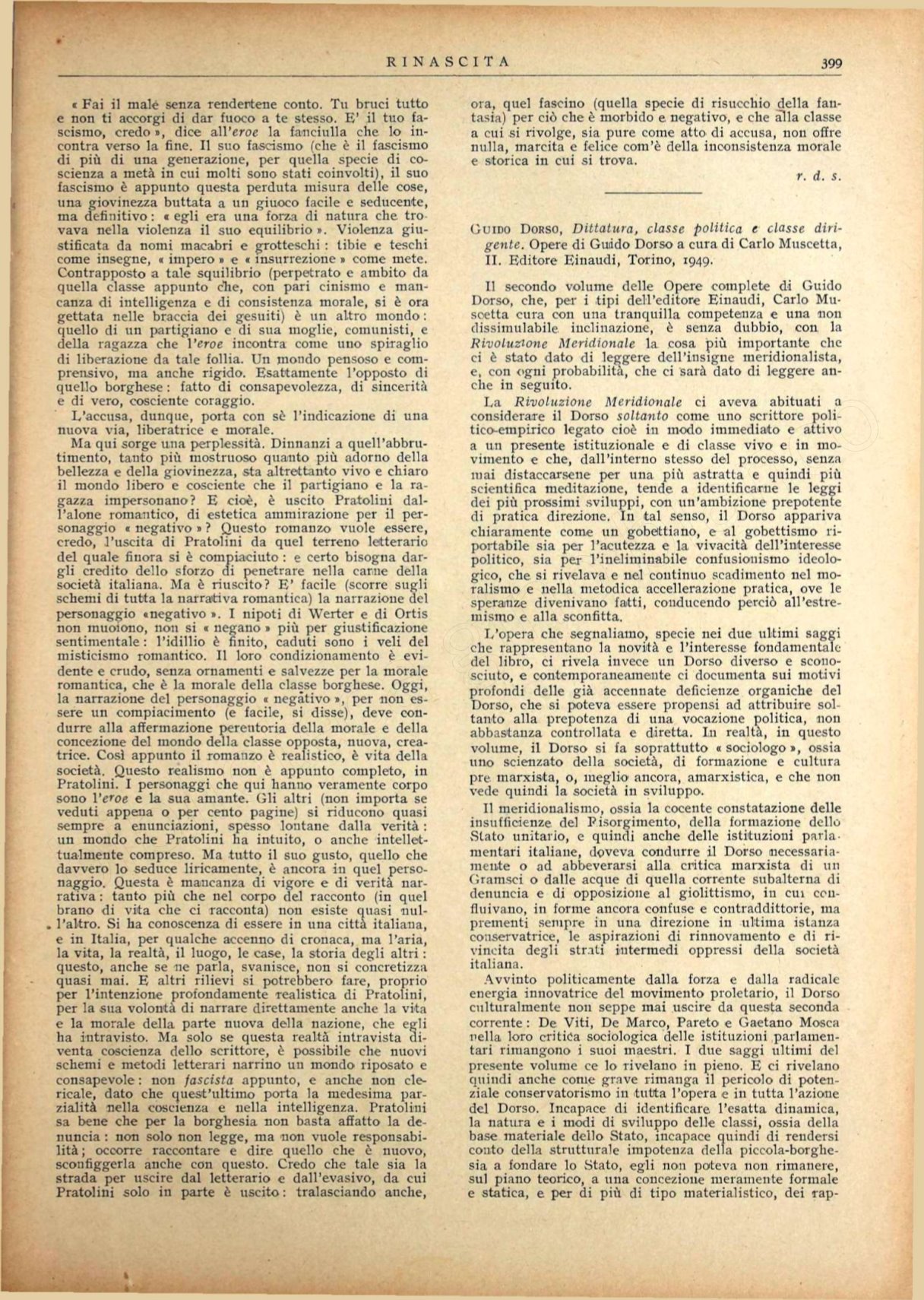
R I N A S C I T A
3 9 9
« Fai ìl male senza rendertene conto. Tu bruci tut to
e non t i accorgi di dar fuoco a te stesso. E ' i l tuo fa–
scismo, c r edo» , dice all'eroe la fanciulla che lo in–
contra verso la fine. I l suo fascismo (che è i l fascismo
d i più d i una generazione, per quella specie di co–
scienza a metà in cui mol t i souo stati coinvolti), i l suo
fascismo è appunto questa perduta misura delle cose,
una giovinezza buttata a un giuoco facile e seducente,
ma def ini t ivo: «eg l i era una forza di natura che tro–
vava nella violenza i l suo equi l ibr io» . Violenza giu–
stificata da nomi macabri e grotteschi : tibie
e
teschi
come insegne, a impero » e « insurrezione » come mete.
Contrapposto a tale squi l ibrio (perpetrato e ambito da
quella classe appunto che, con pari cinismo e man–
canza d i intelligenza e di consistenza morale, si è ora
gettata nelle braccia dei gesuiti) è un altro mondo
:
quello di un partigiano e di sua moglie, comunisti,
e
della ragazza che l'eroe incontra come uno spiraglio
di liberazione da tale follia. Un mondo pensoso e com–
prensivo, ma anche r igido. Esattamente l'opposto di
quello borghese : fatto di consapevolezza, di sinceri tà
e di vero, cosciente coraggio.
L'accusa, dunque, porta con sè l'indicazione di una
nuova via, liberatrice e morale.
Ma qui sorge una perplessi tà. Dinnanzi a quell'abbru–
timento, tanto più mostruoso quanto più adorno della
bellezza e della giovinezza, sta altrettanto vivo e chiaro
i l mondo libero e cosciente che i l partigiano e la
ra–
gazza impersonano? E cioè, è uscito Pratolini dal–
l'alone romantico, di estetica ammirazione per i l per–
sonaggio « negativo » ? Questo romanzo vuole essere,
credo, l 'uscita di Pratolini da quel terreno letterario
del quale finora si è compiaciuto :
e
certo bisogna dar–
g l i credito dello sforzo di penetrare nella carne della
società italiana. Ma è riuscito? E ' facile (scorre sugli
schemi di tut ta la narrativa romantica) la narrazione del
personaggio «negat ivo ». I nipot i di Werter e di Ortis
non muoiono, non sì « negano
*
più per giustificazione
sentimentale : l ' i d i l l i o è finito, caduti sono i vel i del
misticismo romantico. I l loro condizionamento
è
evi–
dente e crudo, senza ornamenti e salvezze per la morale
romantica, che è la morale della classe borghese. Oggi ,
la narrazione del personaggio « nega t i vo» , per non es–
sere un compiacimento (e facile, si disse), deve con–
durre alla affermazione perentoria della morale e della
concezione del mondo della classe opposta, nuova, crea–
trice. Così appunto i l romanzo è realistico, è vi ta della
società. Questo realismo non è appunto completo, in
Pratol ini . I personaggi che qui hanno veramente corpo
sono
Veroe
e la sua amante. ( ì l i a l t r i (non importa se
veduti appena o per cento pagine) si riducono quasi
sempre a enunciazioni, spesso lontane dalla ver i tà :
un mondo che Pratolini ha intui to, o anche intellet–
tualmente compreso. Ma tut to i l suo gusto, quello che
davvero ]o seduce liricamente, è ancora i n quel perso–
naggio. Questa è mancanza di vigore e di ver i tà nar–
rativa : tanto più che nel corpo del racconto (in quel
brano d i vi t a che ci racconta) non esiste quasi nul -
.
l ' al t ro. Si ha conoscenza di essere i n una ci t tà italiana,
e i n I tal ia, per qualche accenno di cronaca, ma l 'aria,
la vi ta, la real tà, i l luogo, le case, la storia degli a l t r i :
questo, anche se ne parla, svanisce, non si concretizza
quasi mai . E a l t r i r i l i evi si potrebbero fare, proprio
per l'intenzione profondamente realistica di Pratolini,
per la sua volontà di narrare direttamente anche
la
vi ta
e la morale della parte nuova della nazione, che egli
ha intravisto. Ma solo se questa real tà intravista di –
venta coscienza dello scrittore, è possibile che nuovi
schemi e metodi letterari narrino un mondo riposato
e
consapevole : non
fascista
appunto, e anche non cle–
ricale, dato che quest 'ultimo porta la medesima par–
zialità nella coscienza e nella intelligenza. Pratolini
sa bene che per la borghesia non basta affatto la de–
nuncia : non solo non legge, ma non vuole responsabi–
l i t à ; occorre raccontare e dire quello che è nuovo,
sconfiggerla anche cou questo. Credo che tale sia la
strada per uscire dal letterario e dall'evasivo, da cui
Pratol ini solo in parte è uscito : tralasciando anche,
ora, quel fascino (quella specie di risucchio della fan–
tasia) per ciò che è morbido e negativo, e che alla classe
a cui si rivolge, sia pure come atto di accusa, non offre
nul la, marcita e felice com'è della inconsistenza morale
e storica i n cui si trova.
r.
d.
s.
G U I D O DORSO,
Dittatura,
classe politica
t classe
diri–
gente.
Opere d i Guado Dorso a cura di Carlo Muscetta,
I L Editore Einaudi , Torino,
1 949 .
I l secondo volume delle Opere complete di Guido
Dorso, che, per i t i p i dell'editore Einaudi , Carlo Mu-
soetta cura con una tranqui l la competenza e una non
dissimulabile, inclinazione, è senza dubbio, con la
Rivoluzione
Meridionale
la cosa più importante che
ci è stato dato d i leggere dell'insigne meridionalista,
e, con ogni probabi l i tà, che ci sarà dato di leggere an–
che in seguito.
La
Rivoluzione
Meridionale
ci aveva abituati a
considerare i l Dorso
soltanto
come uno scrittore pol i–
tico-empirico legato cioè in modo immediato e attivo
a un presente istituzionale e di classe vivo e in mo–
vimento e che, dall ' interno stesso del processo, senza
mai distaccarsene per una più astratta e quindi più
scientifica meditazione, tende a identificarne le leggi
dei più prossimi svi luppi , con un'ambizione prepotente
di pratica direzione. I n tal senso, i l Dorso appariva
chiaramente come un gobettinno, e al gobettismo r i -
portabile sia per l'acutezza e la vivaci tà dell'interesse
politico, sia per l ' inel iminabi le confusionismo ideolo–
gico, che si rivelava e nel continuo scadimento nel mo–
ralismo e nella metodica accellerazione pratica, ove le
speramze divenivano fat t i , conducendo perciò all'estre–
mismo e alla sconfitta.
L'opera che segnaliamo, specie nei due u l t imi saggi
che rappresentano la novi tà e l'interesse fondamentale
del l ibro, ci rivela invece un Dorso diverso e scono–
sciuto, e contemporaneamente ci documenta sui mot ivi
profondi delle già accennate deficienze organiche del
Dorso, che si poteva essere propensi ad attribuire sol–
tanto alla prepotenza di una vocazione politica, non
abbastanza controllata e diretta. I n real tà, i n questo
volume, i l Dorso si fa soprattutto «soc iologo» , ossia
uno scìenzato della società, di formazione e cultura
pre marxista, o, meglio ancora, amarxistica, e che non
vede quindi la società in sviluppo.
I l meridionalismo, ossia la cocente constatazione delle
insufficienze del Risorgimento, della formazione dello
Stato unitario, e quindi anche delle istituzioni parla–
mentari italiane, doveva condurre i l Dorso necessaria–
mente o ad abbeverarsi alla critica marxista di un
Gramsci o dalle acque di quella corrente subalterna di
denuncia e di opposizione al gìol i t t i smo, in cui con–
fluivano, i n forme ancora confuse e contraddittorie, ma
prementi sempre in una direzione i n ul t ima istanza
conservatrice, le aspirazioni d i rinnovamento e di r i –
vincita degli strati intermedi oppressi della società
italiana.
Avvinto politicamente dalla forza e dalla radicale
energia innovatrice del movimento proletario, i l Dorso
culturalmente non seppe mai uscire da questa seconda
corrente: De V i t i , De Marco, Pareto e Gaetano Mosca
nella loro critica sociologica delle istituzioni parlamen–
tar i rimangono i suoi maestri. I due saggi u l t imi del
presente volume ce lo rivelano iu pieno. E ci rivelano
quindi anche come grave rimanga i l pericolo di poten–
ziale conservatorismo in tut ta l'opera e i n tut ta l'azione
del Dorso. Incapace di identificare, l'esatta dinamica,
la natura e i modi dì sviluppo delle classi, ossìa della
base materiale dello Stato, incapace quindi di reudersi
conto della strutturale impotenza della piccola-borghe-
sia a fondare lo Stato, egli non poteva non rimanere,
sul piano teorico, a una concezione meramente formale
e statica, e per di più di t ipo materialistico, dei rap-