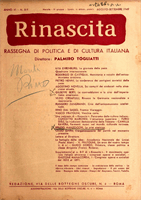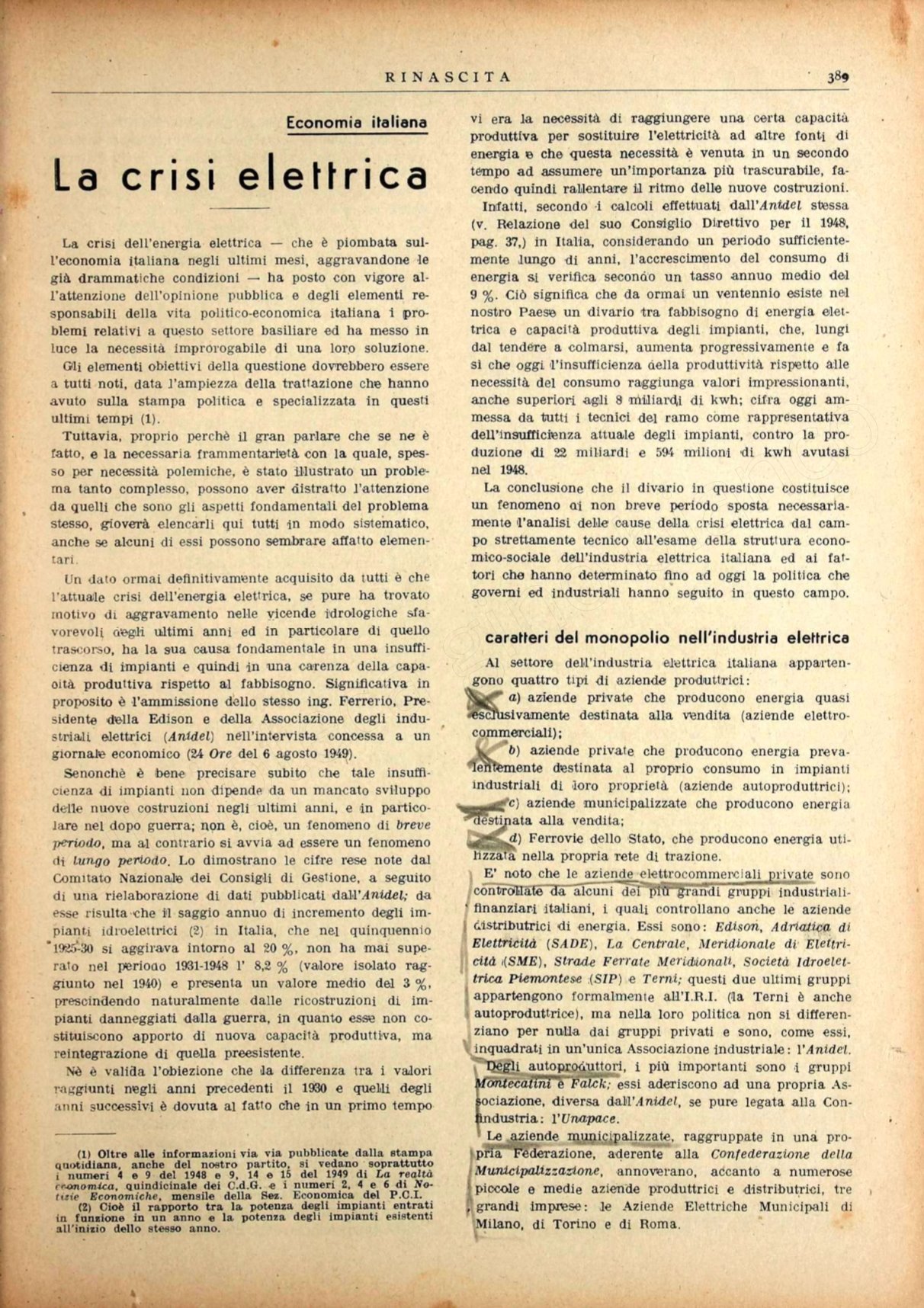
I
R I N A S C I T A
3 8 9
E c o n om i a i tal iana
La c r i s i e l e t t r i c a
La crisi dell'energia
-
elettrica
—
che è
piombata sul-
Teconomia italiana negli ul t imi
mesi,
aggravandone le
già drammat
iche
condizioni
—
ha
posto con vigore
al–
l'attenzione
dell'opinione pubblica e degli
elementi
re–
sponsabili delia vita
politico
-economica italiana ì pro–
blemi relat ivi
a questo settore
basiliare ed ha messo i n
luce
la
necessità
improrogabile d i una lorp soluzione.
Gli elementi obiettivi
della
questione dovrebbero
essere
a tut t i noti , data l
'ampiezza
della trattazione
che
hanno
avuto sulla stampa
politica
e specializzata i n questi
ul t imi tempi
(1).
Tuttavia,
proprio perchè i l gTan parlare
che
se
ne
è
fatto, e l a
necessaria
frammentar ietà
con la quale, spes–
so per necessità polemiche,
è
stato
illustrato un proble–
ma
tanto complesso,
possono
aver distratto l'attenzione
da quelli che sono
gl i aspetti fondamentali
del problema
stesso,
'gioverà
elencarli qui
tut t i in
modo
sistematico,
anche se alcuni d i essi possono sembrare
affatto elemen–
tari .
Un dato
ormai definitivamente acquisito
da
tut t i è che
l'
attuale
crisi
del l ' energìa elettrica, se pure ha trovato
motivo d i aggravamento nelle vicende idrologiche
sfa–
vorevoli degli
ul t imi
anni
ed in particolare di quello
trascorso
, ha la sua causa fondamentale in una insuffi–
cienza d i impiant i e quindi i n una
carenza della capa–
cità produttiva rispetto al fabbisogno. Significativa in
proposito è l'ammissione dello stesso ing. Ferrerie Pre–
sidente della Edison e della Associazione degli indu–
strial i
elettrici
(Anìdel)
nell'intervista concessa
a
un
giornale economico (24
Ore
del 6 agosto 1949).
Senonchè è bene precisare subito che tal
e
insuffi–
cienza
d i impiant i non dipende da
un
mancato
sviluppo
delle
nuove costruzioni negli ul t imi anni,
e
i n
partico–
lare nel
dopo guerra; non
è, cioè, un
fenomeno
di
breve
periodo,
ma
al
contrario si avvia
ad
essere un fenomeno
di
lungo periodo.
Lo dimostrano
le cifre re
-se note dal
Comitato
Nazionale dei Consigli
di
Gestione, a seguito
di
una
rielaborazione dì dati pubblicati
daiVAnideU
da
esse risulta "che i l saggio annuo
di
incremento degli im–
pianti idroelettrici
(2)
i n Italia,
che nei quinquennio
'1925-30 si
aggirava intorno al 20%, non ha mai supe–
rato
nel
periodo 1931-1948
V
8,2
%
{valore isolato rag–
giunto nel 1940)
e
presenta un valore medio del 3
%,
prescindendo naturalmente dalle ricostruzioni dì im–
pianti danneggiati dalla guerra, in quanto
esse
non
co–
stituiscono apporto di nuova capaci tà produttiva,
ma
reintegrazione di quella preesistente.
Nè
è
valida l'obiezione che da differenza tra i valori
raggiu
nti negli anni precedenti i l 1930 e quelli degli
anni
successivi è dovuta al fatto che i n un primo tempo
(1) Ol tre al le informazioni v i a v i a pubblicate dal la stampa
quotidiana, anche del nostro part i to, s i vedano soprattutto
i numeri 4 e 9 del 1948 e 9, 14 e 15 del 1949 di
La
realtà
economica.
Quindicinale dei C.d_G. e i numeri
2,
4 e 6 di
No–
tizie
Economiche, mensile del ia 8ez. Economica del P . C . L
(2) Cioè i l rapporto t ra l a potenza degli impiant i entrat i
in funzione in un anno e l a potenza degli impiant i esistenti
all'inizio dello stesso anno.
vi era l a necessità di raggiungere una certa capaci tà
produttiva per sostituire l 'elettricità ad altre fonti di
energia e che questa necessi tà è venuta in un secondo
tempo ad assumere un'importanza più trascurabile, fa–
cendo quindi rallentare i l ri tmo delle nuove costruzioni.
Infatti , secondo
-i
calcoli effettuati
dall'Artide l
stessa
(v. Relazione del suo Consiglio Direttivo per i l 1948,
pag. 37,) in Ital ia, considerando un periodo sufficiente–
mente lungo d i anni, l'accrescimento del consumo di
energia si verifica secondo un tasso annuo medio del
9 %. Ciò significa che da ormai un ventennio esiste nel
nostro Paese un divario t ra fabbisogno di energia
elet–
trica e capaci tà produttiva degli impiant i , che, lungi
dal tendere a colmarsi, aumenta progressivamente e fa
sì che oggi Tinsufficienza della produt t ivi tà rispetto alle
necessi tà del consumo raggiunga valori impressionanti,
anche superiori agl i
8
mi l i ardi d i kwh; cifra oggi am–
messa da tut t i i tecnici del ramo come rappresentativa
dell'insufficienza attuale degli impianti , contro la pro–
duzione d i 22 mi l iardi e 594 mi l ioni d i kwh avutasi
nel 1948.
La conclusione che i l divario in questione costituisce
un fenomeno ai non breve perìodo sposta necessaria–
mente l 'analisi delle cause della crisi elettrica dal cam–
po strettamente tecnico all'esame della struttura econo–
mico-sociale dell'industria elettrica italiana ed ai fat–
tor i che hanno determinato fino ad oggi la politica che
governi ed industriali hanno seguito in questo campo.
caratter i del monopo l i o ne l l ' indust r i a e l et t r i ca
Al settore dell'industria elettrica italiana apparten–
gono quattro t ipi d i aziende produt trici :
a) aziende private che producono energia quasi
dvamente destinata alla vendita (aziende elettro-
commerciali);
b)
aziende private che producono energia preva–
lentemente destinata al proprio consumo in impiauii
industriali di loro propr ietà (aziende autoproduttrici);
p
c)
aziende municipalizzate che producono energia
'stipata al la vendita;
d)
Ferrovie dello Stato, che producono energìa ut i-
nella propria rete dì trazione.
E' noto che le aziende elettrocommeiciali private sono
i
cóntr3Hafe da alcuni diT
^'iJlfl'Trami
i grappi industriaii-
1
finanziari i tal iani , i quali controllano anche le aziende
distributrici d i energia. Essi sono:
Edison,
Adriatica
di
Elettricità
[SADE),
La Centrale,
Meridionale
dì
Elettri-
cìtà'iSME),
Strade Ferrate
MeruUonali,
Società
Idroelet–
trica Piemontese {SIP)
e
Terni;
questi due ul t imi gruppi
!
appartengono formalmente all'I.R I . (la Terni è anche
.
autoproduttrice), ma nella loro polìtica non si differen–
ziano per nul la dai gruppi privati e sono, come essi,
inquadrati i n un'unica Associazione industriale :
V Anìdel.
Degli auto produttori, i più importanti sono i gruppi
fifoTUecatvn^eFMCÌc; essi
aderiscono ad una propria As-
ociazione, diversa
d&WAnidel,
se pure legata alla Con-
Indus t r ìa:
VUwapace.
Le aziende municipalizzate, raggruppate in una pro–
pria Federazione, aderente alla
Confederazione
della
Municipalizzazione,
annoverano, accanto a numerose
piccole e medie aziende produttrici e distributrici , tre
'l
grandi imprese: le Aziende Elettriche Municipali di
'^Milano, di Torino e di Roma.
k
4