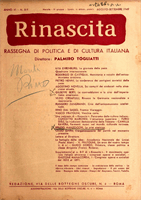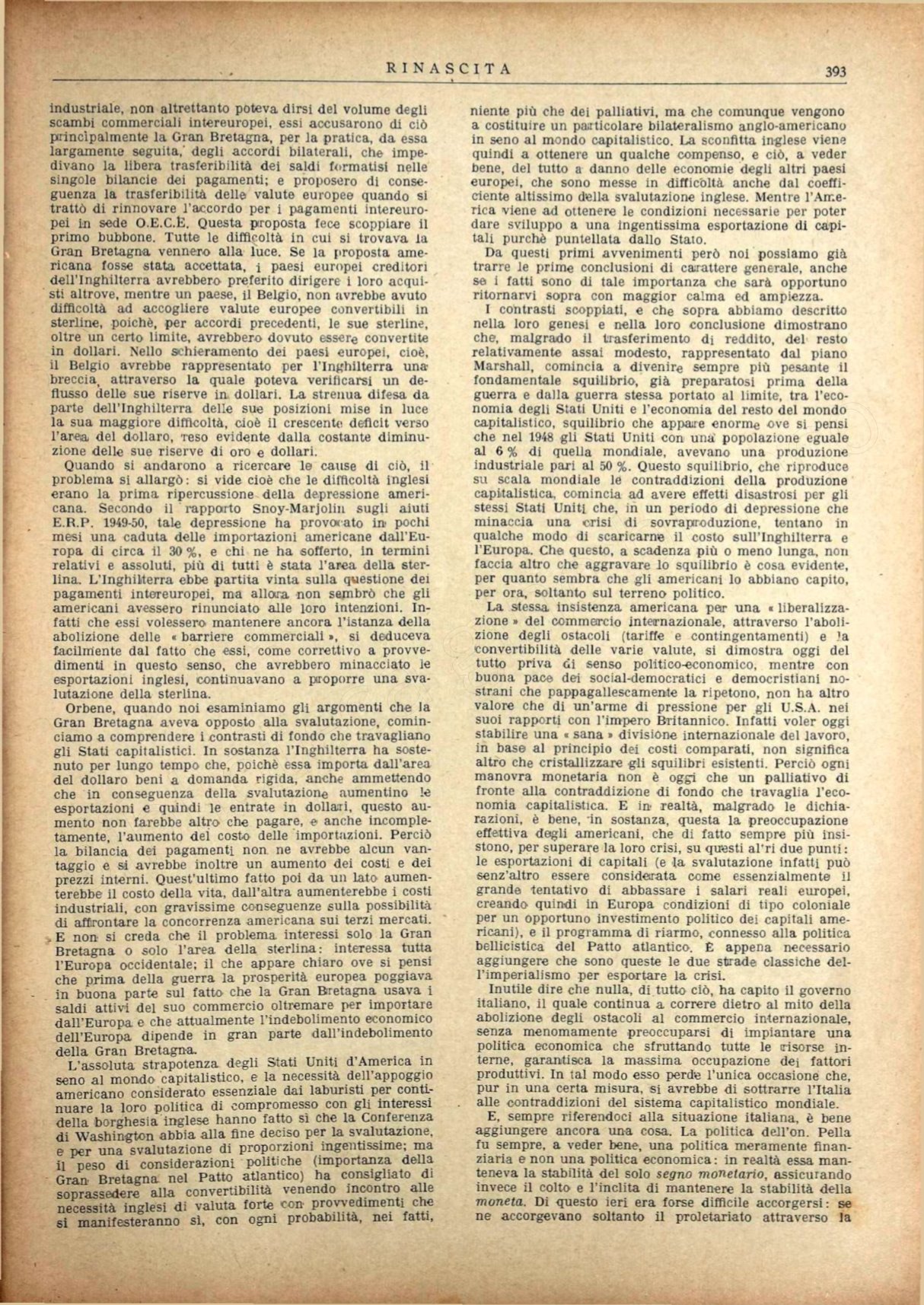
I
R I N A S C I T A
3 9 3
I
_
industriale, non altrettanto poteva dirsi del volume degli
scambi commerciali intereuropei, essi accusarono di ciò
principalmente la Gran Bretagna, per la pratica, da essa
largamente seguita,' degli accordi bilaterali, che impe–
divano la lìbera trasferibilità dei saldi formatisi nelle
singole biiancie dei pagamenti; e proposero d i conse–
guenza la trasferibilità delle valute europee quando si
t rat tò d i rinnovare raccordo per i pagamenti intereuro–
pei in sede O.E.C.E. Questa proposta fece scoppiare i l
primo bubbone. Tutte le difficoltà i n cui sì trovava la
Gran Bretagna vennero alla luce. Se la proposta ame–
ricana fosse stata accettata, i paesi europei creditori
dell ' Inghilterra avrebbero preferito dirigere i loro acqui–
sti altrove, mentre un paese, i l Belgio, non avrebbe avuto
difficoltà ad accogliere valute europee convertibili in
sterline, poiché, per accordi precedenti, le sue sterline,
oltre un certo limite, avrebbero dovuto
essere
convertite
in dol lari . Nello schieramento dei paesi europei, cioè,
i l Belgio avrebbe rappresentato per l ' Inghilterra una
breccia attraverso l a quale poteva verificarsi un de–
flusso delle sue riserve in. dol lar i . La strenua difesa da
parte dell 'Inghilterra delle sue posizioni mise in luce
l a sua maggiore difficoltà, cioè i l crescente deficit verso
Tar-eia del dollaro, reso evidente dalla costante diminu–
zione delle sue riserve di oro e dollari.
Quando si andarono a ricercare le cause d i ciò, i l
r
problema si a l l a rgò : si vide cioè che le difficoltà inglesi
erano la prima ripercussione della depressione ameri–
cana. Secondo i l rapporto Snoy-Marjolin sugli aiut i
E.R.P. 1949-50, tale depressione ha provarato l f l pochi
mesi una caduta delle importazioni americane dall'Eu–
ropa di circa
i l
30%, e chi ne ha sofferto, in termini
relat ivi e assoluti, più d i tut t i è stata l'area della ster–
lina. L' Inghi l terra ebbe partita vinta sulla questione dei
pagamenti intereuropei, ma allora non sembrò che gl i
americani avessero rinunciato alle loro intenzioni. In–
fatti che essi volessero mantenere ancora l'istanza della
abolizione delle « barriere commerciali », si deduceva
facilmente dal fatto che essi, come correttivo a provve–
dimenti in questo senso, che avrebbero minacciato le
esportazioni inglesi, continuavano a proporre una sva–
lutazione della sterlina.
Orbene, quando noi esaminiamo gl i argomenti che Ja
Gran Bretagna aveva opposto alla svalutazione, comin–
ciamo a comprendere i contrasti di fondo che travagliano
gl i Stati capitalistici. I n sostanza l ' Inghilterra ha soste–
nuto per lungo tempo che, poiché essa importa dall'area
del dollaro beni
a
domanda rigida, anche ammettendo
che in conseguenza della svalutazione aumentino le
esportazioni e quindi le entrate in dol lari , questo au–
mento non farebbe altro che pagare,
-e-
anche incomple–
tamente, l'aumento dei costo delle importazioni. Perciò
la bilancia dei pagamenti non. ne avrebbe alcun van–
taggio e sd avrebbe inoltre un aumento dei costi e dei
prezzi interni . Quest'ultimo fatto poi da un lato aumen–
terebbe i l costo della vita, dall 'altra aumenterebbe i costi
industrial i , con gravissime conseguenze sulla possibilità
di affrontare la concorrenza americana sui terzi mercati.
j
E non si creda che i l problema interessi solo l a Gran
Bretagna o solo l'area della sterlina: interessa tutta
l'Europa occidentale; i l che appare chiaro ove si pensi
che prima della guerra la prosperi tà europea poggiava
in buona parte sul fatto che la Gran Bretagna usava i
saldi at t ivi del suo commercio oltremare per importare
dall 'Europa e che attualmente l'indebolimento economico
dell'Europa dipende i n gran parte dall'indebolimento
della Gran Bretagna.
L'assoluta strapotenza degli Stati Uni t i d'America in
seno al mondo capitalistico, e la necessità dell'appoggio
americano considerato essenziale dai laburisti per conti–
nuare la loro politica di compromesso con gl i interessi
della borghesia inglese hanno fatto sì che la Conferenza
d i Washington abbia al la fine deciso per la svalutazione,
e per una svalutazione di proporzioni ingentissime; ma
i l peso d i considerazioni politiche (importanza della
Gran Bretagna nel Patto atlantico) ha consigliato di
soprassedere alla convertibilità venendo incontro alle
necessi tà inglesi di valuta forte con provvedimenti che
si manifesteranno sì, con ogni probabilità, nei fatti,
niente più che dei pal l iat ivi , ma che comunque vengono
a costituire un particolare bì lateral ismo anglo-americano
in seno al mondo capitalistico. La sconfìtta inglese viene
quindi a ottenere un qualche compenso, e ciò. a veder
bene, del tutto a danno delle economie degli al t r i paesi
europei, che sono messe in difficoltà anche dal coeffi–
ciente altissimo della svalutazione inglese. Mentre l'Ame–
rica viene ad ottenere le condizioni necessarie per poter
dare sviluppo a una ingentissima esportazione di capi–
tal i purché puntellata dallo Staio.
Da questi pr imi avvenimenti però noi possiamo già
trarre le prime conclusioni di carattere generale, anche
so i fatti sono di tale importanza che sarà opportuno
ri tornarvi sopra con maggior calma ed ampiezza.
I contrasti scoppiati, e che sopra abbiamo descritto
nella loro genesi e nella loro conclusione dimostrano
che, malgrado i l trasferimento di reddito, de l resto
relativamente assai modesto, rappresentato dal piano
Marshall, comincia a divenire sempre più pesante i i
fondamentale squilibrio, già preparatosi prima della
guerra e dalla guerra stessa portato al limite, tra l'eco–
nomia degli Stati Uni t i e l'economia del resto del mondo
capitalistico, squilibrio che appare enorme -o
-
ve si pensi
che nel 1948 gl i Stati Uni t i con unà popolazione eguale
al 6 % di quella mondiale, avevano una produzione
industriale pari al 50 %. Questo squilibrio, che riproduce
su scala mondiale le contraddizioni della produzione
capitalistica, comincia ad avere effetti disastrosi per gl i
stessi Stati Uni t i ohe, in un periodo d i depressione che
minaccia una crisi di sovra produzione, tentano i n
qualche modo di scaricarne i l costo sull ' Inghilterra e
l'Europa. Cha questo, a scadenza più o meno lunga, non
faccia altro che aggravare lo squilibrio è cosa evidente,
per quanto sembra che gl i americani lo abbiano capito,
per ora, soltanto sul terreno politico.
La stessa insistenza americana par una « liberalizza–
zione » del commercio interaazionale, attraverso l'aboli–
zione degli ostacoli (tariffe e contingentamenti) e !a
convert ibi l i tà delle varie valute, si dimostra oggi del
tutto priva di senso politico-economico, mentre con
buona pace dei social-democratici e democristiani no–
strani che pappagallescamente la ripetono, non ha altro
valore che di un'arme di pressione per gl i U.S.A. nei
suoi rapporti con l'impero Britannico. Infatti voler oggi
stabilire una • sana • divisione internazionale del lavoro,
in base al principio dei costi comparati, non significa
altro che cristallizzare gl i squilibri esistenti. Perciò ogni
manovra monetaria non è oggi che un palliativo di
fronte alla contraddizione di fondo che travaglia l'eco–
nomia capitalistica. E in- real tà, malgrado le dichia–
razioni, è bene, i n sostanza, questa l a preoccupazione
effettiva dagli americani, che di fatto sempre più insi–
stono, per superare la loro crisi, su questi a l ' r i due punt i :
le esportazioni di capitali (e -la svalutazione infat t i può
senz'altro essere considerata come essenzialmente i l
grande tentativo di abbassare ì salari reali europei,
creando quindi in Europa condizioni di tipo coloniale
per un opportuno investimento politico dei capitali ame–
ricani), e i l programma di riarmo, connesso alla politica
bellicistica del Patto atlantico. È appena necessario
aggiungere che sono queste le due strade classiche del–
l'imperialismo per esportare la crisi.
Inutile dire che nulla, di tutto ciò, ha capito i l governo
italiano, i l quale continua a correre dietro al mito della
abolizione degli ostacoli al commercio internazionale,
senza menomamente preoccuparsi di impiantare una
polìtica economica che sfruttando tutte le risorse in–
terne, garantisca la massima occupazione dej fattori
produttivi. In tal modo esso perde Tunica occasione che,
pur in una certa misura, si avrebbe di sottrarre l ' I tal ia
alle contraddizioni del sistema capitalistico mondiale.
E, sempre riferendoci alla situazione italiana, è bene
aggiungere ancora una cosa. La politica delTon. Pella
fu sempre, a veder bene, una politica meramente finan–
ziaria e non una politica economica: i n real tà essa man–
teneva la stabilità del solo
segno monetario,
assicurando
invece i l colto e l ' incl i ta di mantenere la stabi l i tà della
moneta.
Di questo ieri era forse difficile accorgersi: se
ne accorgevano soltanto i l proletariato attraverso la