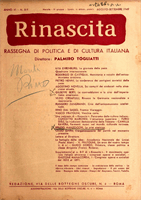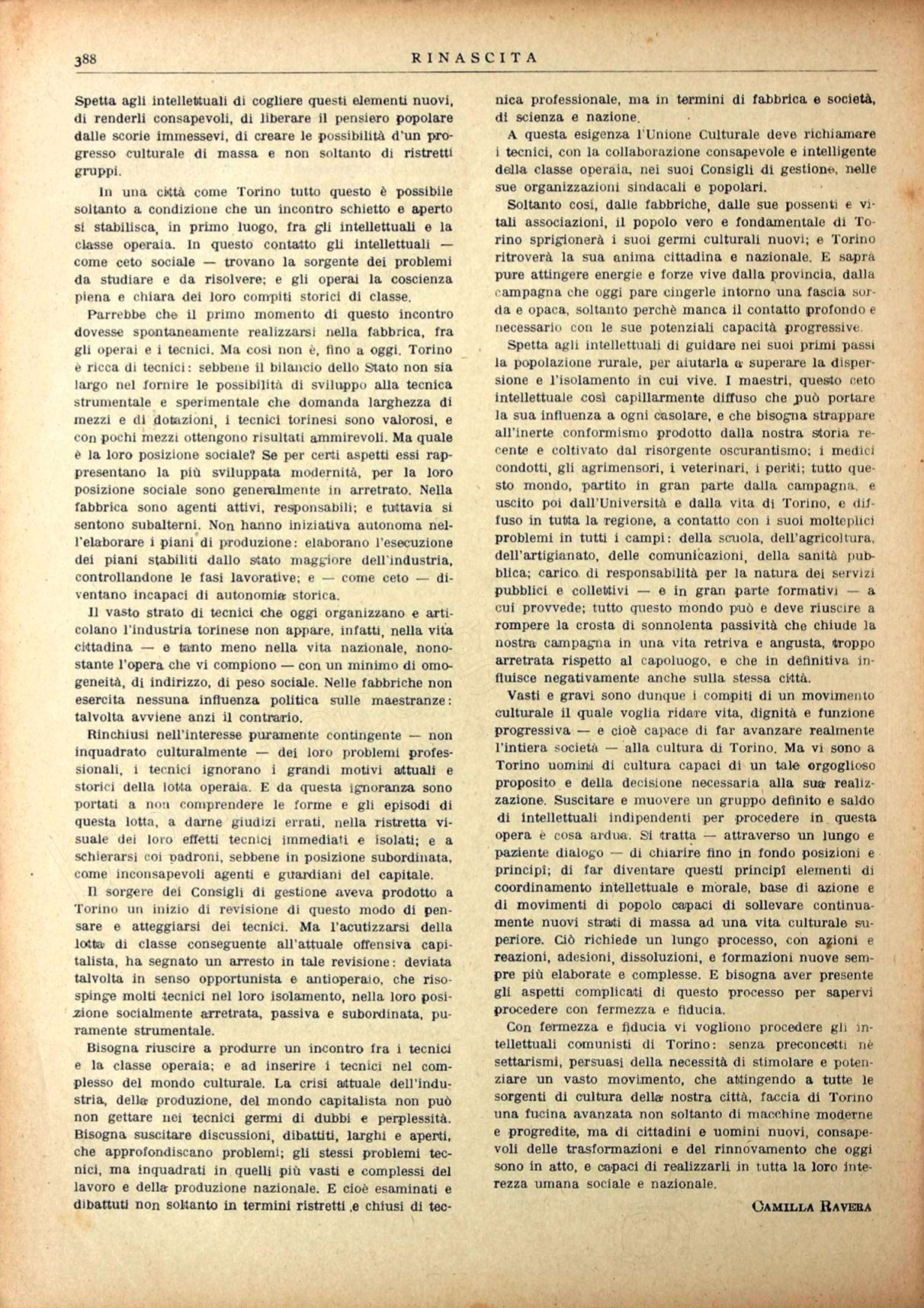
R I N A S C I T A
3 S 8
Spetta agli intellettuali di cogliere questi elementi nuovi,
di renderli consapevoli, di liberare i l pensiero popolare
dalle scorie immessevi, di creare le possibilità d'un pro–
gresso culturale di massa e non soltanto di ristretti
grappi.
In una città come Torino tutto questo è possibile
soltanto a condizione che un incontro schietto e aperto
sì stabilisca in pruno luogo, fra gl i intellettuali e la
classe operaia. In questo contatto gl i intellettuali —
come ceto sociale — trovano la sorgente dei problemi
da studiare e da risolvere; e gl i operai la coscienza
piena e chiara dei loro compiti storici di classe.
Parrebbe che i l primo momento di questo incontro
dovesse spontaneamente realizzarsi nella fabbrica, fra
gl i operai e
i
tecnici. Ma così non
è,
fino a oggi. Torino
è
ricca di tecnici: sebbene i l bilancio dello Stato non sia
largo nel fornire le possibilità dì sviluppo alla tecnica
strumentale e sperimentale che domanda larghezza di
mezzi e di
.
dotazioni, i tecnici torinesi sono valorosi, e
con
pochi mezzi ottengono risultati ammirevoli. Ma quale
è
la loro posizione sociale? Se per certi aspetti essi rap–
presentano la più sviluppata moderni tà, per la loro
posizione sociale sono generalmente in arretrato. Nella
fabbrica sono agenti attivi , responsabili; e tut tavìa si
sentono subalterni. Non hanno iniziativa autonoma nel-
Telaborare i piani dì produzione: elaborano l'esecuzione
dei piani stabiliti dallo stato maggiore dell'industria,
controllandone le fasi lavorative;
e —
come ceto — di–
ventano incapaci di autonomia storica.
lì
vasto strato di tecnici che oggi organizzano e arti–
colano l ' industria torinese non appare, infat t i , nella vita
cittadina — e tanto meno nella vita nazionale, nono–
stante l'opera che vi compiono —con un minimo di omo–
geneità, dì indirizzo, dì peso sociale. Nelle fabbriche non
esercita nessuna influenza polìtica sulle maestranze :
talvolta avviene anzi i l contrario.
Rinchiusi nell'interesse puramente contingente — non
inquadrato culturalmente — dei loro problemi profes–
sionali, i tecnici ignorano i grandi mot ivi attuali e
storici della lotta operaia. E da questa ignoranza sono
portati a non comprendere le forme e gl i episodi di
questa lotta, a darne giudizi errati, nella ristretta v i –
suale dei loro effetti tecnici immediati e isolati; e a
schierarsi coi padroni, sebbene in posizione subordinata,
come inconsapevoli agenti e guardiani del capitale.
I l sorgere dei Consìgli d i gestione aveva prodotto a
Torini) un inizio di revisione di questo modo di pen–
sare e atteggiarsi dei tecnici. Ma l'acutizzarsi della
lotta* di classe conseguente all'attuale offensiva capi–
talista, ha segnato un arresto in tale revisione: deviata
talvolta in senso opportunista e ant ìoperaio, che riso–
spinge molti tecnici nel loro isolamento, nella loro posi–
zione socialmente arretrata, passiva e subordinata, pu–
ramente strumentale.
Bisogna riuscire a produrre un incontro fra i tecnici
e la classe operaia; e ad inserire i tecnici nel com–
plesso del mondo culturale. La crisi attuale dell'indu–
stria, della produzione, del mondo capitalista non può
non gettare nei tecnici germi di dubbi e perplessità.
Bisogna suscitare discussioni, dibattiti , larghi e aperti,
che approfondiscano problemi; gl i stessi problemi tec–
nici , ma inquadrati in quelli più vasti e complessi del
lavoro e della produzione nazionale. E cioè esaminati e
dibattuti non soltanto in termini ristretti .e chiusi di tec–
nica professionale, ma in termini di fabbrica e società,
di scienza e nazione,
A questa esigenza l
1
Unione Culturale deve richiamare
i tecnici, con la collaborazione consapevole e intelligente
della classe operaia, nei suoi Consigli d i gestione, nelle
sue organizzazioni sindacali e popolari.
Soltanto cosi, dalie fabbriche, dalle sue possenti
e
vi –
tal i associazioni, i l popolo vero e fondamentale di To–
rino spr igionerà i suoi germi culturali nuovi; e Torino
r i t roverà la sua anima cittadina e nazionale. E saprà
pure attingere energie e forze vive dalla provìncia, dalla
campagna che oggi pare cingerle intorno una fascia
sor–
da e opaca, soltanto perchè manca i l contatto profondo e
necessario
con
le
sue
potenziali capaci tà progressive.
Spetta
agli
intellettuali di guidare nei suoi pr imi passi
la popolazione rurale, per aiutarla a- superare la disper–
sione e l'isolamento in cui vive. I maestri, questo
ceto
intellettuale così capillarmente diffuso che p u ò portare
la sua influenza a ogni casolare, e che bisogna strappare
all'inerte conformismo prodotto dalla nostra storia
re–
cente
e coltivato
dal risorgente oscurantismo;
ì
medici
condotti, gl i agrimensori, i veterinari, i periti; tutto que–
sto mondo, partito in gran parte dalla campagn
a, e
uscito poi dal l 'Universi tà e dalla vita di Torino, e dif–
fuso in tutta la regione, a contatto con i suoi molteplici
problemi in tut t i i camp ì : della scuola, de i r agricoltura,
dell'artigianato, delle comunicazioni, della sani tà pub–
blica; carico, di responsabi l i tà per la natura dei
servizi
pubblici e collettivi — e in gran parte formativi
—
a
cui provvede; tutto questo mondo può e deve riuscire a
rompere la crosta di sonnolenta passività che chiude la
nostra campagna in una vita retriva e angusta, troppo
arretrata rispetto al capoluogo, e che i n definitiva
in–
fluisce negativamente anche sulla stessa città.
Vasti e gravi sono dunque
i
compiti di un movimento
culturale i l quale voglia ridare vita, digni tà e funzione
progressiva — e cioè capace di far avanzare realmente
l ' intiera società
—
alla cultura di Torino. Ma v i sono a
Torino uomini di cultura capaci di un tale orgoglioso
proposito e della decisione necessaria alla sua? realiz–
zazione. Suscitare e muovere un gruppo definito e saldo
d i intellettuali indipendenti per procedere i n questa
opera è cosa ardua. Si tratta — attraverso un lungo e
paziente dialogo — di chiarire fino in fondo posizioni
e
principi ; di far diventare questi principi elementi di
coordinamento intellettuale e morale, base di azione e
di movimenti dì popolo capaci di sollevare continua–
mente nuovi strati di massa ad una vi ta culturale su–
periore. Ciò richiede un lungo processo, con anioni e
reazioni, adesioni, dissoluzioni, e formazioni nuove sem–
pre più elaborate e complesse. E bisogna aver presente
gl i aspetti complicati di questo processo per sapervi
procedere con fermezza e fiducia.
Con fermezza e fiducia v i vogliono procedere gli in–
tellettuali comunisti di Torino : senza preconcetti
nè
settarismi, persuasi della necessi tà di stimolare e poten–
ziare un vasto movimento, che attingendo
a
tutte le
sorgenti di cultura della nostra città, faccia di Tonno
una fucina avanzata non soltanto di macchine moderne
e progredite, ma di cittadini e uomini nuovi, consape–
voli delle trasformazioni e del rinnovamento che oggi
sono in atto, e capaci di realizzarli in tutta la loro inte–
rezza umana sociale e nazionale.
C
A M I L L A
B
AVERA