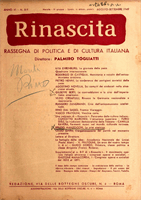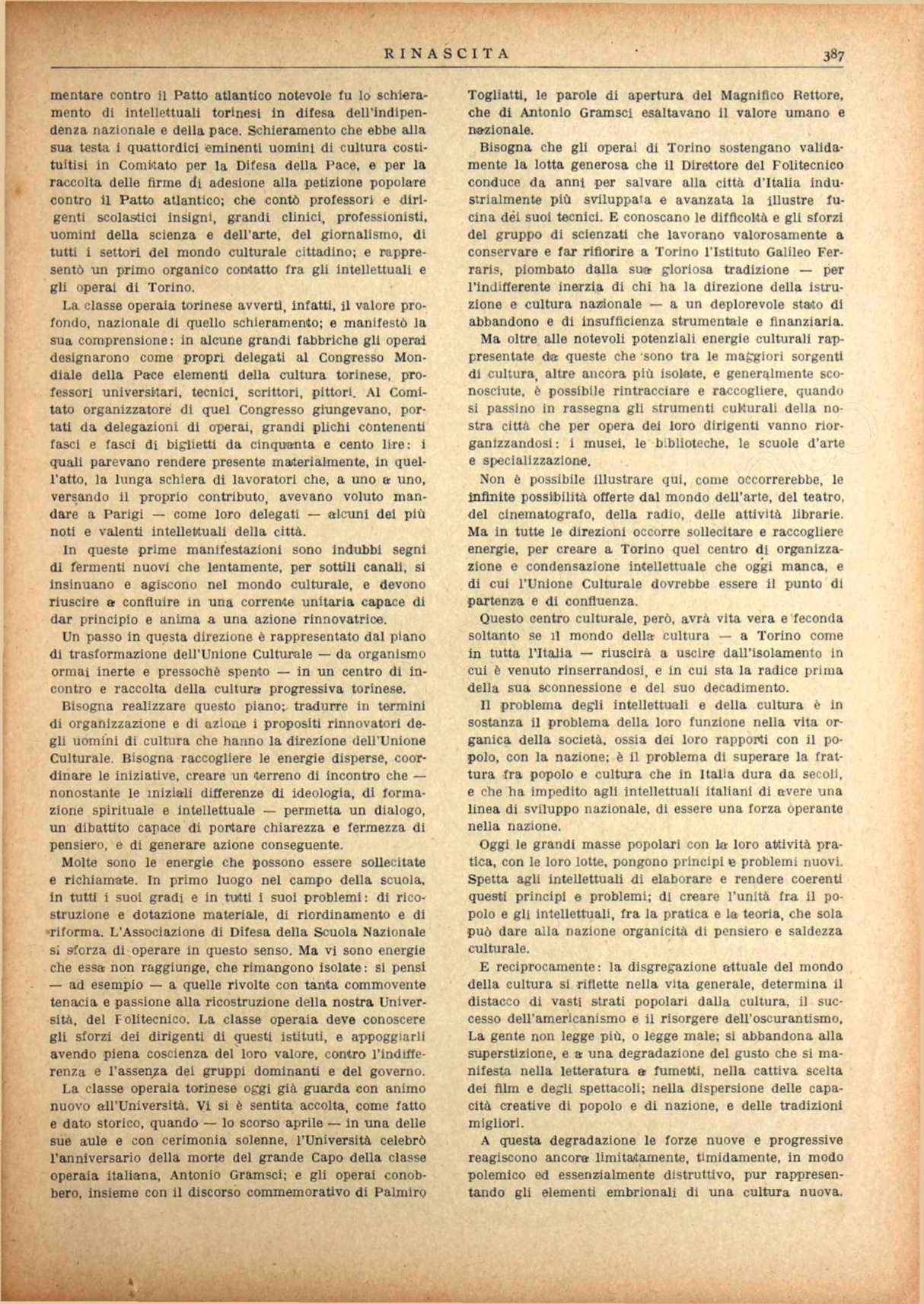
R I N A S C I T A
3 8 7
meritare contro
i l Patto atlantico
notevole fu
lo
schiera–
mento di
intellettuali torinesi i n difesa dell
'indipen–
denza nazionale e della pace.
Schieramento che ebbe alla
sua testa i quattordici
•eminenti uomini di
cultura costi–
tui t isi in Comitato per
la Difesa della
Pace, e per
la
raccolta delle firme di adesione alla petizione popolare
contro i l Patto atlantico; che contò professori
e
d i r i –
genti scolastici
insigni, grandi
clinici ,
professionisti,
uomini
della scienza e dell'arte, del
giornalismo, d i
tut t i i settori del mondo
culturale
cittadino;
e rappre–
sentò un
primo organico contatto fra gl i intellettuali
e
gl i
operai
d i
Torino,
La classe
operaia torinese avvertì , infat t i , i l
valore pro–
fondo, nazionale
di quello schieramento; e
manifestò la
sua comprensione: in alcune grandi fabbriche gl i operai
designarono come
propri delegati al
Congresso Mon–
diale della Pace elementi della cultura
torinese,
pro–
fessori universitari, tecnici, scrittori, pi t tori . Al Comi–
tato
organizzatore di quel
Congresso giungevano,
por–
tati da delegazioni
di operai,
grandi
pl ichi
contenenti
fasci e
fasci
di biglietti da
cinquanta
e cento l i r e :
i
quali parevano
rendere presente materialmente,
i n
quel-
Tatto, la lunga schiera di lavoratori che,
a
uno a uno,
versando
i l
proprio contributo, avevano
voluto man–
dare a
Parigi —
come
loro
delegati
—
alcuni dei più
noti e valenti intellettuali della
città.
In
queste
prime
manifestazioni
sono indubbi segni
di
fermenti
nuovi
che lentamente, per sottili canali,
si
insinuano e
agiscono nel mondo
culturale, e
devono
riuscire a confluire in una
corrente
uni taria
capace di
dar
principio
e anima
a una azione rinnovatrice.
Un passo
in questa
direzione è
rappresentato
dal piano
di
trasformazione
dell'Unione
Culturale — da
organismo
ormai
inerte
e pressoché spento
—
i n
un
centro di
in–
contro e raccolta della cultura
progressiva
torinese.
Bisogna
realizzare questo piano; tradurre in termini
di organizzazione
e di azione i
propositi rinnovatori de–
gl i uomini
di
cultura che hanno
l a direzione
dell'Unione
Culturale.
Bisogna raccogliere
le
energie disperse,
coor–
dinare le iniziative,
creare
un terreno
di
incontro che —
nonostante
le
inizial i
differenze di ideologia, di
forma–
zione
spirituale e intellettuale — permetta un dial
ogo,
un dibattito capace di portare chiarezza
e
fermezza di
pensiero, e
di generare azione conseguente.
Molte
sono
le energìe che
possono
essere sollecitate
e richiamate.
In
primo luogo
nel campo della scuola,
in tut t i
i suoi gradi e
in
tut t i
i
suoi problemi: di
rico-
-
struzione
e
dotazione
materiale, di riordinamento e
di
'riforma. L'Associazione di Difesa della
Scuola
Nazionale
si
sferza
di
operare
in
questo
senso.
Ma v i sono
energie
che essa
non raggiunge,
che rimangono
isolate:
si
pensi
— ad esempio
—-
a quelle
rivolte con tanta commov
ente
tenacia e passione
alla
ricostruzione della
nostra Univer–
sità, del
Politecnico. La classe
operaia deve
conoscere
g l i
sforzi dei dirigenti di questi ist i tut i , e
appoggiarli
avendo piena coscienza del
loro valore, contro l
'indiffe–
renza e
l'assenna
dei gruppi dominanti e del
governo.
La classe operaia torinese oggi
già guarda con
animo
nuovo al l 'Universi tà.
Vi sì è sentita accolta, come fatto
e dato storico, quando — lo
scorso aprile — in una delle
sue aule e
con cerimonia solenne,
l 'Università
celebrò
Tannìversar io della morte del grande Capo della
classe
operaia italiana, Antonio Gramsci; e
gl i operai
conob–
bero, insieme con i l discorso
commemorativo di Palmiro
Togliatti, le parole di apertura del Magnifico Rettore,
che d i Antonio Gramsci esaltavano i l valore umano e
nazionale.
Bisogna che gl i operai di Torino sostengano valida–
mente la lotta generosa che i l Direttore del Politecnico
conduce da anni per salvare alla ci t tà d' Italia indu–
strialmente più sviluppata e avanzata la illustre fu–
cina dèi suoi tecnici. E conoscano le difficoltà e gl i sforzi
del gruppo di scìenzati che lavorano valorosamente a
conservare e far rifiorire a Torino l 'Istituto Galileo Fer–
raris, piombato dalla sua gloriosa tradizione — per
Tindifferente inerzia dì chi ha la direzione della istru–
zione e cultura nazionale
—
a un deplorevole stato di
abbandono e di insufficienza strumentale e finanziaria.
Ma oltre alle notevoli potenziali energie culturali rap–
presentate da queste che 'sono tra
le
maggiori sorgenti
di cultura
i
altre ancora più isolate, e
generqlmente sco–
nosciute,
è
possibile rintracciare e raccogliere,
quando
si passino in rassegna gl i strumenti culturali
della no–
stra città che per opera dei loro dirìgenti vanno rior–
ganizzandosi: i musei, le biblioteche, le scuole d
'arte
e specializzazione.
Non
è
possibile illustrare qui, come occorrerebbe, le
infinite possibilità offerte dal mondo dell'arte, del teatro,
del cinematografo, della radio, delle at t ivi tà librarie.
Ma in tutte le direzioni occorre sollecitare e raccogliere
energie, per creare a Torino quel centro di organizza–
zione e condensazione intellettuale che oggi manca, e
di cui l'Unione Culturale dovrebbe essere i l punto di
partenza e di confluenza.
Questo centro culturale, però, avrà vita vera e'feconda
soltanto se i l mondo della cultura
—
a Torino come
i n tutta Istal la — riuscirà a uscire dall'isolamento in
cui è venuto rinserrando si
t
e in cui sta la radice prima
della sua sconnessione e del suo decadimento.
I l problema degli intellettuali e della cultura
è
in
sostanza i l problema della loro
funzione
nella vita
or–
ganica della società, ossia dei loro rapporti con i l
po–
polo, con l a nazione;
è
i l problema di superare la frat–
tura fra popolo e cultura che in Italia dura da
secoli,
e che ha impedito agli intellettuali i tal iani di
avere
una
linea di sviluppo nazionale, di essere una forza operante
nella nazione.
Oggi le grandi masse popolari con la loro attività pra–
tica, con le loro lotte, pongono principi «e problemi
nuovi.
Spetta agli intellettuali di elaborare e rendere coerenti
questi principi e problemi; dì creare l 'uni tà fra
i l po–
polo e gl i intellettuali, fra la pratica e la teoria, che sola
può dare alla nazione organici tà di pensiero e saldezza
culturale.
E reciprocamente: la disgregazione attuale del mondo
della cultura si riflette nella vita generale, determina i l
distacco di vasti strati popolari dalla cultura, j ]
suc–
cesso dell'americanismo e i l risorgere dell'oscurantismo.
La gente non legge più,
0
legge male; si abbandona alla
superstizione, e a una degradazione del gusto che sì ma–
nifesta nella letteratura & fumetti, nella cattiva scelta
dei film e degli spettacoli; nella dispersione delle capa–
cità creative di popolo e d i nazione, e delle tradizioni
migl ior i .
A questa degradazione le forze nuove e progressive
reagiscono ancora limitatamente, timidamente, in modo
polemico ed essenzialmente distruttivo, pur rappresen–
tando gl i elementi embrionali di una cultura nuova.