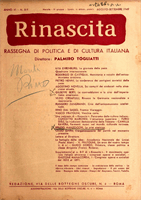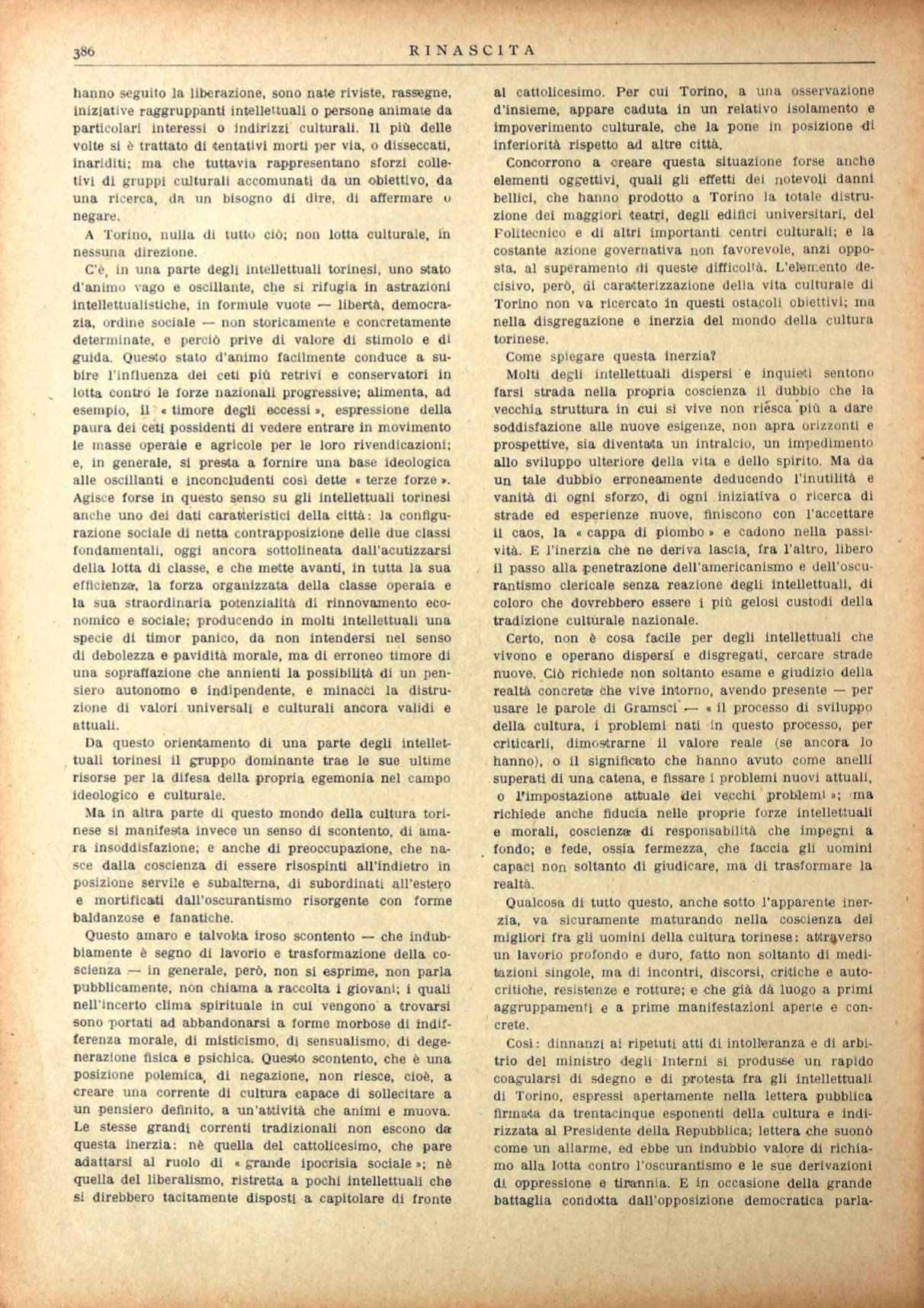
R I N A S C I T A
3«h
hanno seguito la liberazione, sono nate riviste, rassegne,
iniziative raggruppanti intellettuali o persone animate da
particolari interessi o indirizzi culturali . I l più delle
volte si
è
trattato di "tentativi mort i per via, o disseccati,
inar idi t i ; ma che tuttavia rappresentano sforzi colle-
tivì d i gruppi culturali accomunati da un obiettivo, da
una ricerca, da un bisogno di dire, di affermare u
negare.
A Torino, nulla
di
tutto ciò; non lotta culturale, ih
nessuna direzione.
Cè
ì
in una parte degli intellettuali torinesi, uno stato
d'animo vago e oscillante, che si rifugia in astrazioni
intellettualistiche, in formule vuote — libertà, democra–
zia, ordine sociale — non storicamente e concretamente
determinate, e perciò prive d i valore di stimolo e di
guida. Questo stato d'animo facilmente conduce a su–
bire l'influenza dei ceti più ret r ivi e conservatori i n
lotta contro le forze nazionali progressive; alimenta, ad
esempio, i l « timore degli eccessi », espressione della
paura dei ceti possidenti di vedere entrare in movimento
le masse operaie e agrìcole per le loro rivendicazioni;
e, in generale, si presta a fornire una base ideologica
alle oscillanti e inconcludenti così dette «terze forze».
Agisce forse in questo senso su gl i intellettuali torinesi
anche uno dei dati caratteristici della ci t tà; Ja configu–
razione sociale di netta contrapposizione delle due classi
fondamentali, oggi ancora sottolineata dal l ' acut izzarsì
delia lotta dì classe, e che mette avanti, i n tutta la sua
efficienza, la forza organizzata della classe operaia e
ia sua straordinaria potenzial i tà di rinnovamento eco–
nomico e sociale; producendo i n mol t i intellettuali una
specie di timor panico, da non intendersi nel senso
h
di debolezza e pavidi tà morale, ma di erroneo timore di
una sopraffazione che annienti la possibilità di un pen–
siero autonomo e indipendente, e minacci la distru–
zione di valori universali e culturali ancora validi e
attuali.
Da questo orientamento di una parte degli intellet–
tuali torinesi i l gruppo dominante trae le sue ultime
risorse per la difesa della propria egemonia nel campo
ideologico e culturale.
Ma in altra parte di questo mondo della cultura tori–
nese si manifesta invece un senso di scontento, di ama–
ra insoddisfazione; e anche dì preoccupazione, che na–
sce dalia coscienza di essere risospìnt i all'indietro in
posizione servile e subalterna, d i subordinati all'estero
e mortificati dall'oscurantismo risorgente con forme
baldanzose e fanatiche.
Questo amaro e talvolta iroso scontento — che indub–
biamente è segno dì lavorio e trasformazione della co–
scienza r-r in generale, però, non si esprime, non parla
pubblicamente, non chiama a raccolta ì giovani; i quali
nell'incerto clima spirituale in cui vengono a "trovarsi
sono portati ad abbandonarsi a forme morbose di indif–
ferenza morale, di misticismo, di sensualismo, di dege–
nerazione fisica e psichica. Questo scontento, che è una
posizione polemica, d i negazione, non riesce, cioè, a
creare una corrente di cultura capace di sollecitare a
un pensiero definito, a un ' at t ivi tà che animi e muova.
Le stesse grandi correnti tradizionali non escono da
questa inerzia: nè quella del cattolicesimo, che pare
adattarsi al ruolo di « grande ipocrisia sociale »; nè
quella dei liberalismo, ristretta a pochi intellettuali che
si direbbero tacitamente disposti a capitolare di fronte
al cattolicesimo. Per cui Torino, a
una osservazione
d'insieme, appare caduta i n un relativo isolamento e
impoverimento culturale, che l a pone
in
posizione -di
inferiori tà rispetto ad altre città.
Concorrono a creare questa situazione forse anche
elementi oggettivi, quali gl i effetti dei
notevoli
danni
bellici,
che hanno
prodotto a Torino la totale
distru–
zione dei
maggiori
teatri, degli
edifici universitari,
del
Politecnico e
di al t r i
importanti
,
ce
ntri cul tural i ; e la
costante azione
governativa non
favorevole,
anzi
oppo–
sta, al superamento di queste difficoltà.
L
'elemento
de–
cisivo, però, di caratterizzazione
della vita
culturale
di
Torino non va
ricercato
In questi
ostacoli obiettivi; ma
nella
disgregazione
e inerzia del
mondo della cultura
torinese.
Come spiegare questa
inerzia?
Molti
degli
intellettuali dispersi e inquieti sentono
farsi strada nella propria coscienza
i l
dubbio
che
la
vecchia struttura in cui
si vive
non
riesca
più a
dare
soddisfazione alle nuove
esigenze,
non
apra orizzonti e
prospettive, sia diventata un
intralcio, un impedimento
allo sviluppo ulteriore della vita e dello spirito. Ma da
un tale dubbio erroneamente deducendo l ' inut i l i tà e
vani tà di ogni sforzo, di
ogni iniziativa o ricerca
di
strade ed esperienze nuove, finiscono con l'accettare
i l caos, la « cappa di piombo » e cadono nella
passi–
vità.
E l
' inerzia che
ne
deriva lascia, fra l 'altro, libero
i l passo alla penetrazione dell'americanismo
e
dell
'oscu–
rantismo clericale senza reazione degli intellettuali, di
coloro che dovrebbero essere ì più gelosi custodi delia
tradizione culturale nazionale.
Certo, non è cosa facile
per
degli intellettuali che
vivono e operano dispersi e disgregati, cercare strade
nuove. Ciò richiede non soltanto
esame
e giudizio della
real tà
concreta
che vive intorno, avendo presente
— per
usare le parole
di
Gramsci*
—
«
i l
processo dì sviluppo
della cultura,
i
problemi nat i
in
questo processo, per
cri t icarl i , dimostrarne i l valore
reale (se
ancora lo
hanno), o i l significato che
hanno
avuto come anelli
superati dì una catena, e fissare i problemi nuovi attuali,
o l
'impostazione attuale dei ve;cchi ' problemi »; mia
richiede anche fiducia nelle proprie
forze
intellettuali
e morali , coscienza di responsabi l i tà che impegni a
fondo; e fede, ossìa fermezza
j
che faccia gl i uomini
capaci
non
soltanto
di
giudicare, ma d i trasformare la
real tà.
Qualcosa di tutto questo, anche sotto l'apparente iner–
zia, va sicuramente maturando nella coscienza dei
migl ior i fra gl i uomini della cultura torinese: attraverso
un lavorio
profondo e duro, fatto
non soltanto di medi–
tazioni singole, ma di incontri , discorsi, critiche e auto–
critiche,
resistenze e rotture; e che già dà luogo
a
pr imi
aggruppamenti e
a prime manifestazioni aperte e
con–
crete.
Così: dinnanzi ai
ripetuti atti di intolleranza
e
di arbi–
trio del ministro degli Interni
sì
produsse un rapido
coagularsi di
sdegno
e di protesta fra gl i intellettuali
di
Torino, espressi
apertamente nella lettera pubblica
firmata
da trentacinque esponenti della cultura e indi–
rizzata al Presidente dèl ia Repubblica; lettera che suonò
come un allarme, ed ebbe un indubbio valore di richia–
mo alla lotta contro l'oscurantismo e le sue derivazioni
di oppressióne è tirannia. E in occasione della grande
battaglia condotta dall'opposizione democratica parla-