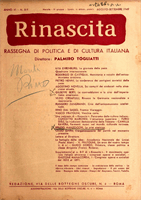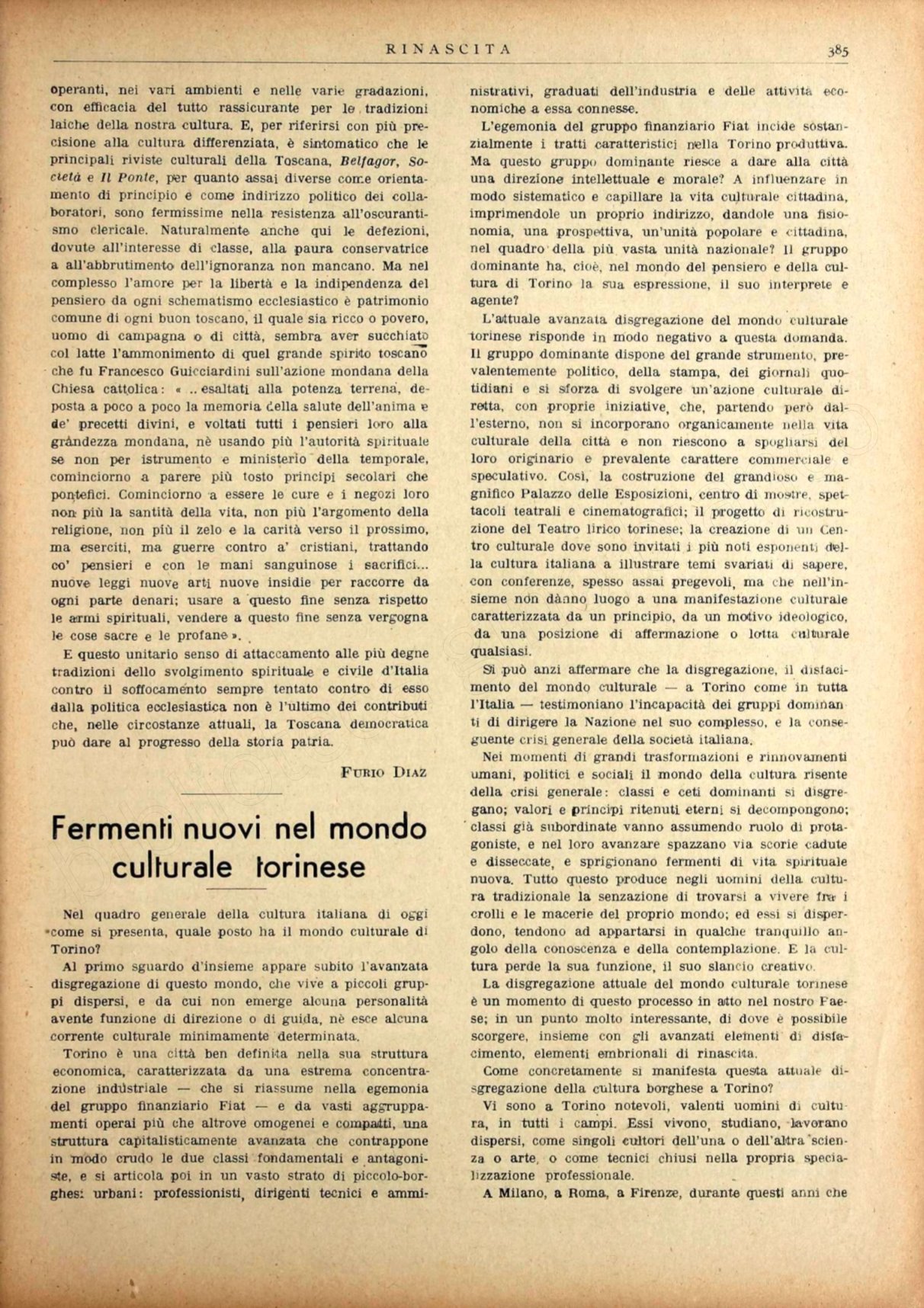
R I N A S C I T A
385
operanti, nei var i ambienti e nelle varie gradazioni,
con efficacia del tutto rassicurante per l o . tradizioni
laiche della nostra cultura. E, per riferirsi con più pre–
cisione al la cultura differenziata,
è
sintomatico che le
principal i riviste culturali della Toscana,
Belfagor,
So–
cietà e II Ponte,
per quanto assai diverse come orienta–
mento dì principio e come indirizzo politico dei colla–
boratori, sono fermissime nella resistenza alToscuranti-
smo clericale. Naturalmente anche qui Je defezioni,
dovute all'interesse d i classe, alla paura conservatrice
a
all'abbrutimento dell'ignoranza non mancano. Ma nel
complesso l
'amore per
la l ibertà e l a indipendenza del
pensiero da ogni schematismo ecclesiastico
è
patrimonio
comune di ogni buon toscano, i l quale sia ricco o povero,
uomo d i campagna *> d i città, sembra aver succhiato
col latte l'ammonimento di quel grande spirito toscano
che fu Francesco Guicciardini sull'azione mondana della
Chiesa cattolica:
«
..esaltati alla potenza terrena, de–
posta
a
poco a poco la memoria della salute dell
'anima
e
de' precetti divini , e voltati tut t i i pensieri
loro
alla
grandezza mondana, nè usando più l 'autor i tà spirituale
se non per istrumento e ministerio della temporale,
comìnciorno a parere più tosto principi secolari che
pontefici. Cominciorno a essere le cure
e
i negozi loro
non più la sant i tà della vita, non più l'argomento della
religione, non più i l zelo e la car i tà verso
i l
prossimo,
ma eserciti, ma guerre contro a' cristiani, trattando
co' pensieri e con le mani sanguinose i sacrifici...
nuove leggi nuove ar t i nuove insìdie per raccorre da
ogni parte denari; usare a questo fine senza rispetto
Je armi spirituali, vendere
a
questo fine senza vergogna
le cose sacre e le profane».
E questo unitario senso dì attaccamento alle più degne
tradizioni dello svolgimento spirituale e civile d' Italia
contro i l soffocamento sempre tentato contro di esso
dalla politica ecclesiastica non
è
l 'ul t imo dei contributi
che, nelle circostanze attuali, la Toscana democratica
può dare al progresso della storia patria.
F UR I O DIAZ
Fermenti nuovi nel mondo
culturale torinese
Nel quadro
generale
della cultura italiana di
oggi
•come si
presenta, quale posto ha i l mondo culturale dì
Torino?
Al
primo sguardo d'insieme appare subito l'avanzata
disgregazione di questo
mondo, che vìve a piccoli grup–
pi dispersi, e
da cui non emerge alcuna personal i tà
avente funzione di direzione
o di guida, nè esce alcuna
corrente culturale
minimamente
determinata.
Torino è una città ben definita nella sua struttura
economica, caratterizzata da una estrema
concentra–
zione
industriale
— che si riassume nella
egemonia
del
grappo finanziario Fiat — e da
vasti aggruppa–
menti operai
più che altrove omogenei e compatti, una
struttura
capitalisticamente avanzata che
contrappone
in modo crudo le due
classi fondamentali
e antagoni–
ste, e sì articola poi in un vasto strato di piccolo-bor-
ghes; urbani : professionisti, dirigenti tecnici e ammi–
nistrativi, graduati dell'industria e delle
attività eco–
nomiche a essa connesse.
L'egemonia del gruppo finanziario Fiat incìde
sostan–
zialmente ì tratti caratteristici
nella Torino
produttiva.
Ma questo gruppi) dominante
riesce a
dare alla
città
una direzione intellettuale e morale?
A influenzare in
modo sistematico e capillare la vita culturale
cittadina,
imprimendole un proprio Indirizzo, dandole una
fisio–
nomia, una prospettiva, un ' un i t à popolare
e cittadina,
nel quadro della più vasta uni t à nazionale?
1J
gruppo
dominante ha,
cioè, nel
mondo del
pensiero e della cul–
tura di Torino
la sua espress
ione, i l suo interprete
e
agente?
L'attuale
avanzata disgregazione
del mondo
culturale
torinese risponde in modo negativo a questa domanda.
I l gruppo dominante dispone dei grande
strumento, pre–
valentemente polìtico, della stampa, dei
giornali guo-
tidiani e
si
siforza dì svolgere un
'azione culturale di¬
retta,
con
proprie iniziative,
che,
partendo
però dal–
l'esterno, non si
incorporano
organicamente nella vita
culturale della città
e
non riescono a
spogliarsi
del
loro originario
e
prevalente carattere
commerciale e
speculativo. Così, la costru
zione
del
grandioso e ma–
gnifico Palazzo delle
Esposizioni,
centro di
mostre, spet–
tacoli teatrali e
cinematografici; i l
progetto
dì ricostru–
zione del Teatro lirico
torinese;
la
creazione di un Cen–
tro culturale dove sono invi tat i
ì più noti esponenti del–
la cultura italiana a illustrare temi svariali
di sapere,
con conferenze, spesso
assai
pregevoli,
ma che nell ' in–
sieme non danno luogo
a
una manifestazione
culturale
caratterizzata da un principio, da un motivo
ideologico,
da una posizione di affermazione o lotta
culturale
qualsiasi.
Si può anzi affermare che la disgregazione,
i l disiaci-
mento del mondo culturale — a Torino
come in
tutta
l ' I tal ia — testimoniano l ' incapaci tà dei gruppi dominan
–
t i di dirigere l a Nazione nel suo complesso, e
la conse–
guente
crisi generale
della
società
italiana.
Nei momenti di grandi
trasformazioni e r imi ov amen ti
umani, pol i t ici e sociali i l mondo della cultura risente
della crisi generale: classi e
ceti
dominanti
si disgre–
gano; valori e principi r i tenut i eterni si decompongono;
classi già subordinate vanno assumendo ruolo
di
prota–
goniste, e nel loro avanzare spazzano
via scorie cadute
e
disseccate, e sprigionano fermenti d i vita
spirituale
nuova. Tutto questo produce negli uomini della
cultu–
ra tradizionale l a senzazìone di trovarsi
a vivere fre* i
crol l i e le macerie del proprio mondo;
ed essi si disper–
dono, tendono ad appartarsi in qualche
tranquillo an–
golo della
conoscenza e
della contemplazione. E
la cul–
tura perde la sua funzione, i l suo slancio
creativo.
La disgregazione attuale del mondo culturale
torinese
è
un momento dì questo processo in atto nel nostro Fae-
se; in un punto molto interessante, di dove è possibile
scorgere, insieme con
gl i
avanzati elementi
di disfa–
cimento, elementi embrionali di rinascite.
Come concretamente
si
manifesta questa
attuate di –
sgregazione della cultura borghese a Torino?
Vi sono a Torino notevoli, valenti uomini di eultu
ra, in tut t i i campi. Essi vivono, studiano, lavorano
dispersi, come sìngoli cultori dell'una o dell'altra'scien–
za o arte, o come tecnici chiusi nella propria
specia–
lizzazione professionale.
A Milano,
a
Roma, a Firenze, durante questi anni che