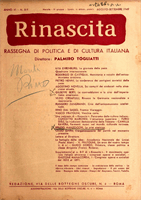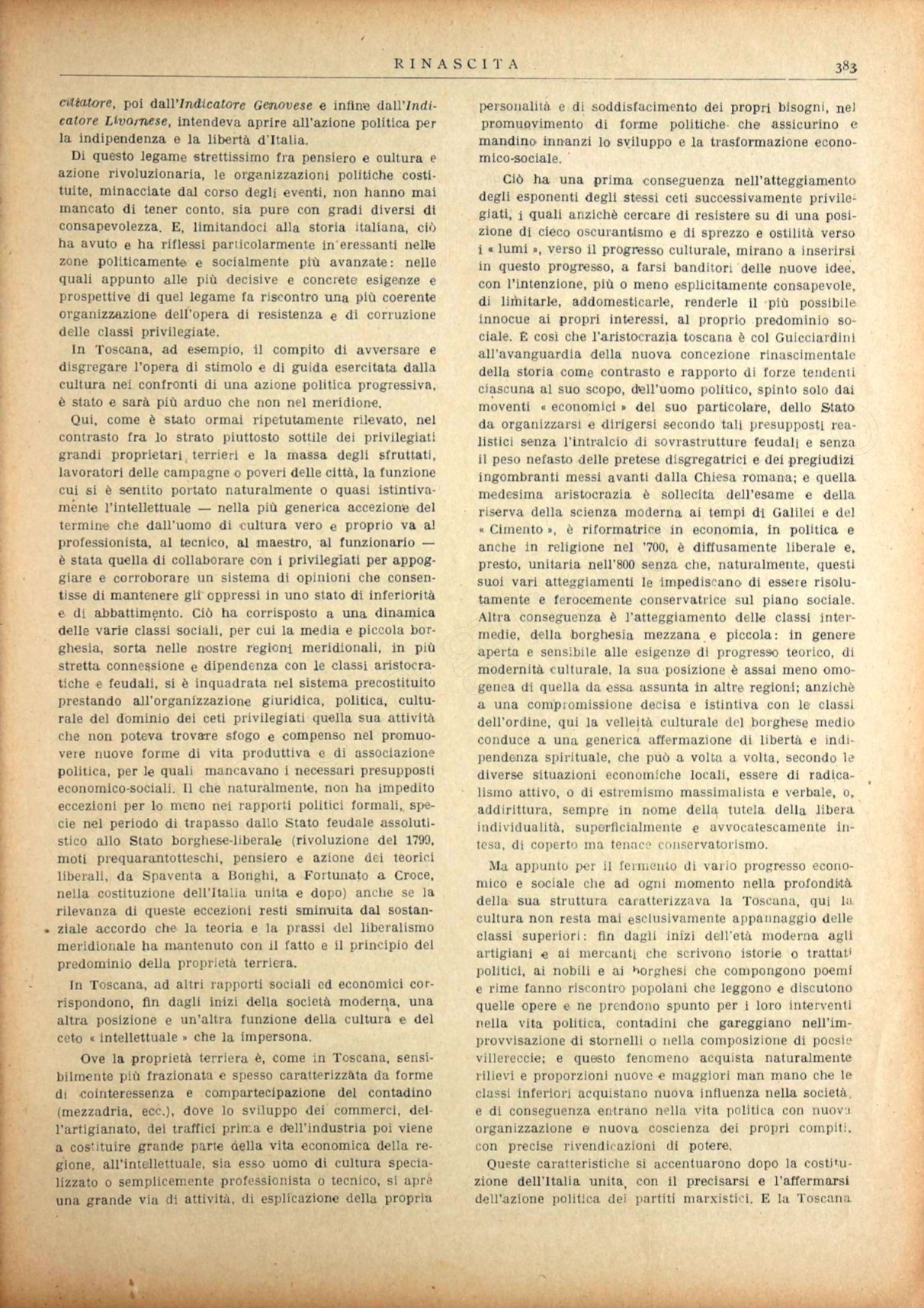
f
R I N A S C I T A
3 8 3
coautore,
poi
dall
'Indicatore
Genovese
e infine dal l ' Indi–
catore
Livornese,
intendeva aprire all'azione politica per
la
indipendenza
e la l ibertà
d
'Italia.
Di questo
legame strettissimo fra pensiero e cultura e
azione rivoluzionaria, le
organizzazioni polìtiche
costi–
tuite, minacciate dal corso degli eventi, non hanno mai
mancato
d i
tener conto, sia pure con gradi diversi
di
consapevolezza. E,
limitandoci alla storia italiana, ciò
ha avuto e ha riflessi panicolarmente interessanti nelle
zone politicamente
e
socialmente più avanzate: nelle
quali appunto alle più decisive e concrete esigenze e
prospettive di quei legame
fa
riscontro una più coerente
organizzazione dell'opera dì resistenza e di corruzione
delle classi privilegiate.
In Toscana, ad esempio, i l compito di avversare e
disgregare l'opera di stimolo e di guida esercitata dalla
cultura nei confronti di una
azione
polìtica progressiva,
è
stato
e
sarà più arduo che non nel meridione.
Qui, come
è
stato ormai ripetutamente rilevato, nel
contrasto fra lo strato piuttosto sottile dei privilegiati
grandi
proprietari
J
terrieri
e
la
massa degli sfruttati,
lavoratori delle campagne
o poveri
delle città, la funzione
cui si
è
sentito portato naturalmente
0
quasi istintiva¬
mente
l'intellettuale
—
nella
più generica accezione del
termine
che dall'uomo di cultura vero e proprio va al
professionista, al tecnico, al maestro, al funzionario
—
è
stata quella di collaborare con
i
privilegiati per appog–
giare e
corroborare un sistema di opinioni che consen–
tisse
dì mantenere gl i oppressi in
uno stato di inferiorità
e
di abbattimento. Ciò ha corrisposto a
una dinamica
delle varie classi sociali, per cui la media e piccola bor–
ghesìa, sorta
nelle nostre
regioni meridionali, in più
stretta connessione e dipendenza con le classi aristocra–
tiche e feudali,
si è inquadrata nel sistema
precostituito
prestando all'organizzazione giuridica, politica,
cultu–
rale del dominio d
ei ceti privilegiati quella sua at t ivi tà
che non poteva
trovare sfogo e compenso nel promuo–
vere nuove forme di vita produttiva e di
associazione
politica, per le quali mancavano ì necessari presupposti
economico-sociali. I l che naturalmente,
non
ha impedito
eccezioni per lo meno
nel
rapporti politici formali,,
spe–
cie noi periodo di
trapasso
dallo
Stato
feudale assoluti–
stico
allo Slato borghese-liberale (rivoluzione
del
1790,
moti prequarantotteschi, pensiero e azione dei teorici
liberali ,
da Spaventa
a Bonghi, a Fortunato a
Croce,
nella
costituzione dell ' Italia unita e dopo)
anche se
la
rilevanza dì queste eccezioni resti sminuita dal sostan-
. ziale accordo che l a teoria e la prassi del liberalismo
meridionale ha
mantenuto con l i fatto e i l
principio del
predominio della
proprietà terriera.
In
Toscana, ad al t r i rapporti sociali ed economici cor–
rispondono, fin dagli inizi della società moderna, una
altra posizione
e
un'altra funzione della cultura
e
del
ceto « intellettuale
»
che la impersona.
Ove la
propr ietà terriera è, come in Toscana, sensi–
bilmente più frazionata e spesso caral terìzzàta da forme
di cointeressenza e compartecipazione
dei
contadino
(mezzadria, ecc.), dove lo sviluppo dei commerci, del–
l'artigianato, dei traffici prima e dall'industria poi viene
a
costituire
grande parte della vita economica della re–
gione, all'intellettuale, sia
esso
uomo di cultura
specia–
lizzato
0
semplicemente
professionista
0
tecnico, si apre
una grande via di attività, di esplicazione della
propria
personal i tà e di soddisfacimento dei propri bisogni, nei
promuovimento di forme politiche- che assicurino e
mandino' innanzi lo sviluppo e la trasformazione econo–
mico-sociale.
'
Ciò ha una prima conseguenza nell'atteggiamento
degli esponenti degli stessi ceti successivamente privile^
giati, i quali anziché cercare dì resistere su dì una posi–
zione di cieco oscurantismo e di sprezzo e ostilità verso
i « lumi », verso i l progresso culturale, mirano a inserirsi
in questo progresso, a farsi banditori delle nuove idee»
con l'intenzione, più
0
meno esplicitamente consapevole,
di limitarle, addomesticarle, renderle i l più possibile
innocue ai propri interessi, al proprio predominio so–
ciale. E cosi che l'aristocrazia toscana
è
col Guicciardini
ali'avanguardia della nuova concezione rinascimentale
della storia come contrasto e rapporto dì forze tendenti
ciascuna al suo scopo, dell'uomo politico, spinto solo dai
moventi « economici » del suo particolare, dello Stato
da organizzarsi e dirigersi secondo tal i presupposti rea–
listici senza l ' intralcio d i sovrastrutture feudali e senza
i l peso nefasto delle pretese disgregatrici e dei pregiudìzi
ingombranti messi avanti dalla Chiesa romana; e quella
medesima aristocrazia è sollecita dell'esame e della,
riserva della scienza moderna ai tempi di Galilei e del
« Cimento
», è
riformatrice in economia, in politica e
anche in religione nel '700, è diffusamente liberale e»
presto, unitaria nell'800 senza che, naturalmente, questi
suoi vari atteggiamenti le impediscano di esseie risolu–
tamente e ferocemente conservatrice sul piano sociale.
Altra conseguenza è l'atteggiamento delle classi inter–
medie, della borghesia mezzana e piccola: In genere
aperta e sensibile alle esigenze di progress
o
teorico, dì
moderni tà 'culturale, la sua posizione è assai meno omo–
genea di quella da
ossa
assunta in altre regioni; anziché
a una compromissione decisa e istintiva con le classi
dell'ordine, qui la velleità culturale del borghese medi
o
conduce a una generica affermazione di libertà e indi–
pendenza spirituale, che può a volta a volta, secondo le
diverse situazioni economiche locali, essere di radica–
lismo attivo,
0
di estremismo massimalista e verbale,
0,
addirittura, sempre in nome della tutela della libera
individualità, superficialmente e avvocatescamente in–
tesa, di copertu ma tenace
conser
vatorismo.
Ma appunto per i l fermento di vario progresso econo–
mico e sociale che ad ogni momento nella profondi tà
della sua struttura caratterizzava la Toscana, qui la
cultura non resta mai esclusivamente appannaggio delle
classi superiori: fin dagli inizi dell 'età moderna agli
artigiani e ai mercanti che scrivono istorie
0
trattat»
politici , ai nobili e ai borghesi che compongono poemi
e
rime fanno riscontro popolani che leggono e discutono
quelle opere e ne prendono spunto per i loro interventi
nella vita politica, contadini che gareggiano nel l ' im–
provvisazione di stornelli
0
nella composizione di poesie
villereccie; e questo fenomeno acquista naturalmente
ri l ievi e proporzioni nuove e maggiori man mano che le
classi inferiori acquistano nuova influenza nella società,
e di conseguenza entrano nella vita polìtica con nuovj
organizzazione
e
nuova coscienza dei propri compiti,
con precise rivendii azioni di potere,
Queste caratteristiche si accentuarono dopo la costru–
zione dell 'Italia unita, con i l precisarsi e l'affermarsi
dell'azione politica dei partiti marxistici. E la Toscana
I