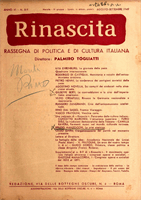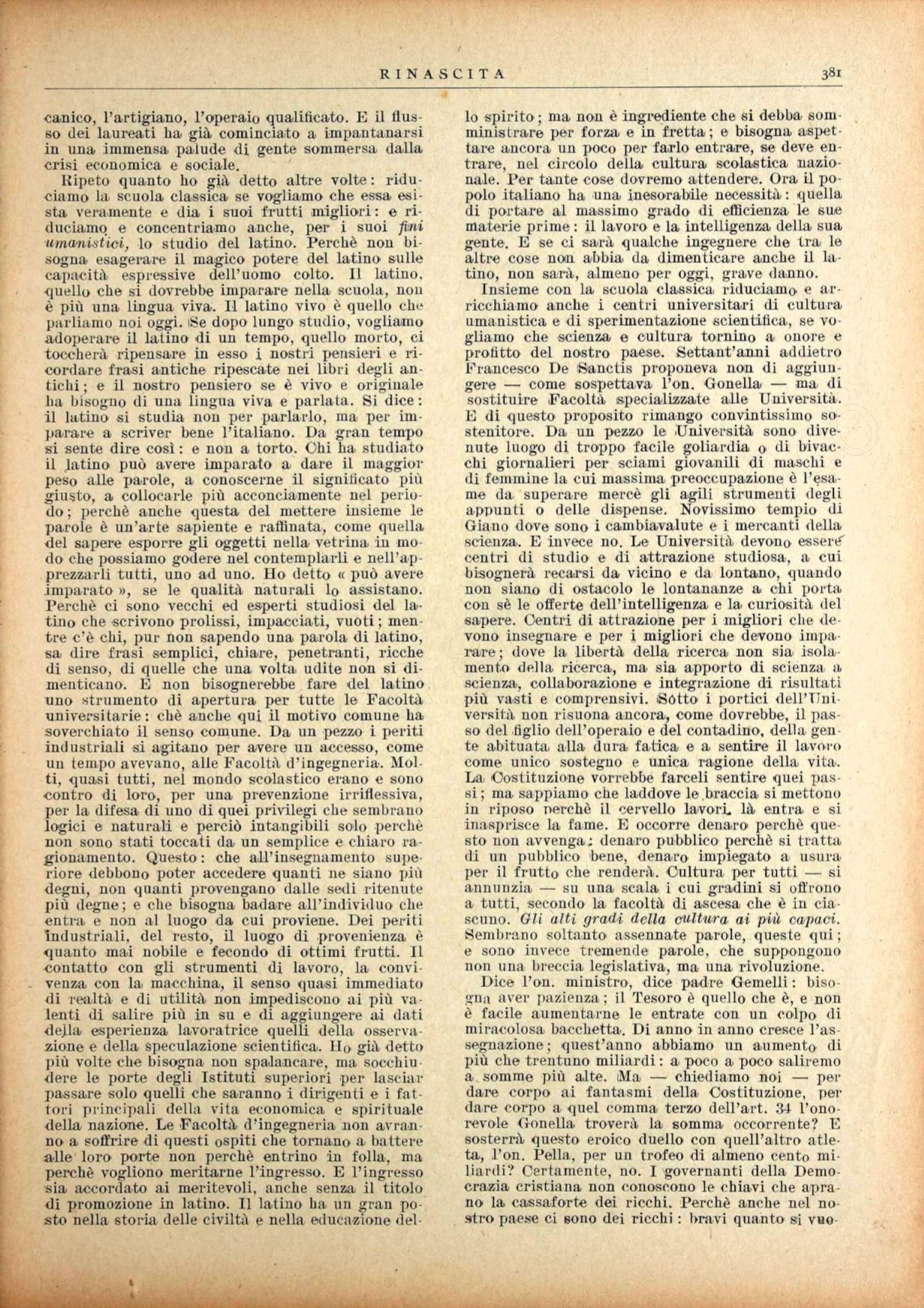
R I N A S C I T A
canieo, l'artigiano, l'operaio qualificato, E i l flus–
so dei laureati ha già cominciato a impantanarsi
in una immensa palude di gente sommersa dalla
crisi economica e sociale.
Ripeto quanto ho già detto altre volte: ridu–
ciamo la scuola classica se vogliamo che essa esi–
sta veramente e dia i suoi frutti migliori : e ri–
duciamo e concentriamo anche, per i suoi
ffflÀ
umanistici; lo
studio del latino. Perchè non bi–
sogna esagerare i l magico potere del latino sulle
capacità espressive dell'uomo colto. I l latino,
quello che si dovrebbe imparare nella scuola, non
è più una lingua viva. I l latino vivo è quello che
parliamo noi oggi. tèe dopo lungo studio, vogliamo
adoperare i l latino di un tempo, quello morto, ci
toccherà ripensare in esso i nostri pensieri e ri–
cordare frasi antiche ripescate nei libri degli an–
tichi ; e i l nostro pensiero se è vivo e originale
ha bisogno di nna lingua viva e parlata. Si dice:
i l latino si studia non per parlarlo, ma per im–
parare a scriver bene l'italiano. Da gran tempo
s i sente dire cos ì : e non a torto. Ohi ha studiato
il latino può avere imparato a dare iL maggior
peso alle parole, a conoscerne i l significato più
giusto, a collocarle più acconciamente nel perio–
do; perchè anche questa del mettere insieme le
parole è un'arte sapiente e raffinata, come quella
del sapere esporre gli oggetti nella vetrina in mo–
do che possiamo godere nel contemplarli e nelTap-
.
prezzarli tutti, uno ad uno. Ho detto « può avere
imparato », se le qualità naturali lo assistano.
Perchè ci sono vecchi ed esperti studiosi del la–
tino che scrivono prolissi, impacciati, vuoti; men–
tre c'è chi, pur non sapendo una parola di latino,
sa dire frasi semplici, chiare, penetranti, ricche
di senso, di quelle che una volta udite non si di–
menticano. E non bisognerebbe fare del latino
uno strumento di apertura per tutte le Facoltà
universitarie : che anche qui i l motivo comune ha
soverchiato i l senso comune. Da un pezzo i periti
industriali si agitano per avere un accesso, come
un tempo avevano, alle Facoltà d'ingegneria. Mol–
ti, quasi tutti, nel mondo scolastico erano e sono
contro di loro, per una prevenzione irriflessiva,
per la difesa di uno di quei privilegi che sembrano
logici è naturali e perciò intangibili solo perchè
non sono stati toccati da un semplice e chiaro ra–
gionamento. Questo : che all'insegnamento supe–
riore debbono poter accedere quanti ne siano più
degni, non quanti provengano dalle sedi ritenute
più degne; e che bisogna badare all'individuo che
entra e non al luogo da cui proviene. Dei periti
industriali, del resto, i l luogo di provenienza è
quanto mai nobile e fecondo di ottimi fratti. I l
contatto con gli strumenti di lavoro, la convi-
,
venza con la macchina, i l senso quasi immediato
di realtà e di utilità non impediscono ai più va–
lenti di salire più in su e di aggiungere ai dati
della esperienza lavoratrice quelli della osserva–
zione e della speculazione scientifica. HQ già detto
più volte che bisogna non spalancare, ma socchiu–
dere le porte degli Istituti superiori per lasciar
passare solo quelli che saranno i dirigenti e i fat–
tori principali della vita economica e spirituale
della nazione. Le -Facoltà d'ingegnerìa non avran–
no a soffrire di questi ospiti che tornano a battere
alle loro porte non perchè entrino in folla, ma
perchè vogliono meritarne l'ingresso. E l'ingresso
sia accordato ai meritevoli, anche senza i l titolo
di promozione in latino. I l latino ha un gran po–
sto nella storia delle civiltà e nella educazione del-
381
lo spirito; ma non è ingrediente che si debba som–
ministrare per forza e in fretta; e bisogna aspet–
tare ancora un poco per farlo entrale, se deve en–
trare, nel circolo della cultura scolastica nazio–
nale. Per tante cose dovremo attendere. Ora i l po–
polo italiano ha una inesorabile necessi tà: quella
di portare al massimo grado di efficienza le sue
materie prime : i l lavoro e la intelligenza della sua
gente. E se ci sarà qualche ingegnere che tra le
altre cose non abbia da dimenticare anche i l la–
tino, non sarà, almeno per oggi, grave danno.
Insieme con la scuola classica riduciamo e ar–
ricchiamo anche i centri universitari di cultura
umanistica e di sperimentazione scientifica, se vo–
gliamo che scienza e cultura tornino a onore e
profitto del nostro paese. Settant'anni addietro
Francesco De
i
&anctis proponeva non di aggiun–
gere —' come sospettava l'on. Gonella — ma di
sostituire Facol tà ispecializzate alle Università.
E di questo proposito rimango convintissimo so–
stenitore. Da un pezzo le Università sono dive–
nute luogo di troppo facile goliardia
0
di bivac–
chi giornalieri per sciami giovanili di maschi e
di femmine la cui massima preoccupazione è l'esa–
me da superare mercè gli agili strumenti degli
appunti
0
delle dispense. Novissimo tempio di
Giano dove sono i cambiavalute e i mercanti della
scienza. E invece no. Le Università devono esser*?
centri di studio e di attrazione studiosa, a cui
bisognerà recarsi da vicino e da lontano, quando
non siano di ostacolo le lontananze a chi porta
con sè le offerte dell'intelligenza e la curiosità del
sapere. Centri di attrazione per i migliori che de–
vono insegnare e per i migliori che devono impa–
rare; dove la libertà della ricerca non sia isola–
mento della ricerca, ma sia apporto di scienza a
scienza, collaborazione e integrazione di risultati
più vasti e comprensivi. Sótto i portici dell'Uni
versila non risuona ancora, come dovrebbe, i l gas–
so del figlio dell'operaio e del contadino, della gen
te abituata alla dura fatica e a sentire i l lavoro
come unico sostegno e unica ragione della vita.
La. Costituzione vorrebbe farceli sentire quei pas–
s i ; ma sappiamo che laddove le braccia si mettono
in riposo perchè il cervello lavori, là entra e si
inasprisce la fame. E occorre denaro perchè que–
sto non avvenga; denaro pubblico perchè si tratta
di un pubblico bene, denaro impiegato a usura
per i l fratto che renderà. Cultura per tutti — si
annunzia — su una scala i cui gradini si offrono
a tutti, secondo là facoltà di ascesa che è in cia–
scuno.
Gli alti gradi della cultura ai più capaci.
Sembrano soltanto assennate parole, queste qui;
e sono invece tremende parole, che suppongono
non una breccia legislativa, ma una rivoluzione.
Dice l'on. ministro, dice padre Gemelli : biso–
gna aver pazienza ; il Tesoro è quello che è, e non
è facile aumentarne le entrate con un colpo di
miracolosa bacchetta-. Di anno in anno cresce l'as–
segnazione; quest'anno abbiamo un aumento di
più che trentuno miliardi: a. poco a poco saliremo
a sommo più alte. Ma — chiediamo noi — per
dare corpo ai fantasmi della Costituzione, per
dare corpo a quel comma terzo dell'art. 34 Tono–
revole Gonella troverà la somma occorrente? E
sosterrà questo eroico duello con quell'altro atle–
ta, l'on. Pella, per un trofeo di almeno cento mi–
liardi? Certamente, no. I governanti della Demo–
crazia cristiana non conoscono le chiavi che apra–
no la cassaforte dei ricchi. Perchè anche nel no–
stro paese ci sono dei ricchi : bravi quanto si vuo-