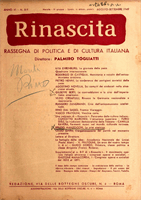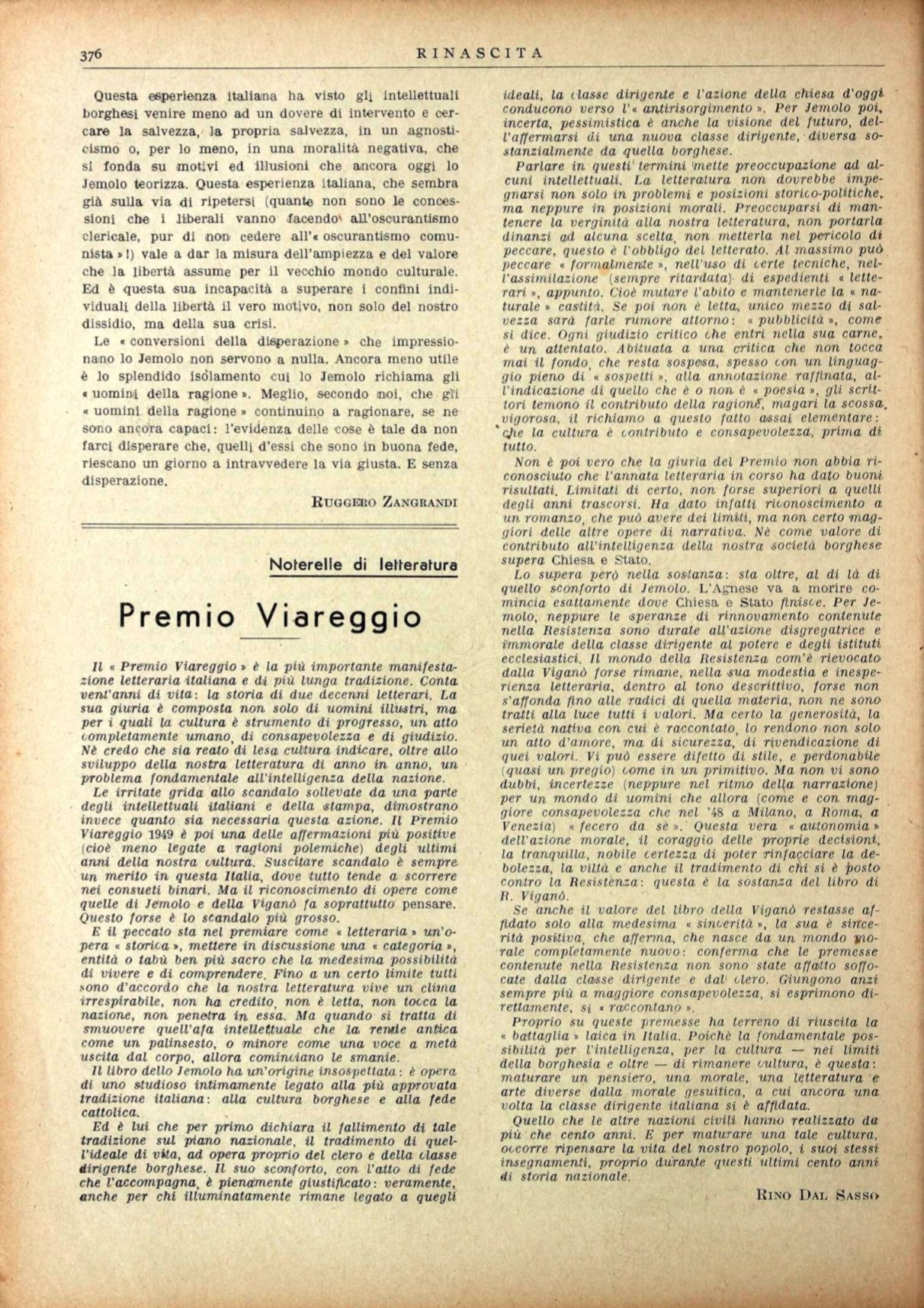
3 7 6
R I N A S C I T A
Questa esperienza italiana ha visto gl i intellettuali
borghesi venire meno ad un dovere dì intervento e cer–
care la salvezza, l a propria salvezza, in un agnosti–
cismo o, per lo meno, in una moral i tà negativa, che
si fonda su mot ivi ed i l lusioni che ancora oggi lo
Jemolo teorizza. Questa esperienza italiana, che sembra
già sulla via dì ripetersi (quante non sono le conces–
sioni che i l iberal i vanno .facendo^ all'oscurantismo
clericale, pur di non cedere alT« oscurantismo comu–
nista » I) vale a dar la misura dell'ampiezza e dei valore
che l a l ibertà assume per i l vecchio mondo culturale.
Ed è questa sua incapaci tà a superare i confluì indi–
vidual i della l ibertà i l vero motivo, non solo del nostro
dissidio, ma della sua crisi.
Le « conversioni della disperazione » che impressio–
nano lo Jemolo non servono a nulla. Ancora meno utile
è lo splendido isolamento cui lo Jemolo richiama gl i
«uomini della ragione» . Meglio, secondo noi, che gh
« uomini della ragione » continuino a ragionare, se ne
sono ancora capaci: l'evidenza delie cose è tale da non
farci disperare che, quelli d'essi che sono in buona fede,
riescano un giorno a intravvedere la via giusta. E senza
disperazione,
RUGGERO ZANGRANDI
No t e r e l l e di letteratura
P r emi o V i a r e g g i o
II « Premio
Viareggio » è la più importante
manifesta–
zione letteraria italiana e di più lunga tradizione.
Conta
venVannì dì vita-, la storia di due decenni
letterari.
La
sua giuria è composta
non solo di uomini
illustri,
ma
per i quali la
-
cultura è strumento di progresso,
un atto
completamente
umano, dì consapevolezza
e di
giudizio.
Nè credo che sia reato di lesa cultura indicare,
oltre allo
sviluppo
della nostra
letteratura
di anno in anno, un
problema
fondamentale
all'intelligenza
della
nazione,
Le irritate
grida allo scandalo
sollevate da una parte
degli intellettuali
italiani
e della stampa,
dimostrano
invece
quanto sia necessaria
questa azione. Il
Premio
Viareggio
1949
è poi una delle affermazioni
più
positive
{cioè meno
legate a ragioni
polemiche)
degli
ultimi
anni della nostra cultura.
Suscitare
scandalo
è
sempre
un merito in questa Italia,
dove tutto tende a
scorrere
nei consueti
binari. Ma il
riconoscimento di opere
come
quelle di J&molo e della Viganò fa soprattutto
pensare.
Questo forse è lo scandalo più
grosso.
E il peccato sta nel premiare
come « letteraria » un'o–
pera « storica*,
mettere in discussione
una « categoria »,
entità o tabù ben più sacro che la medesima
possibilità
dì vivere e di comprendere.
Fino a un certo limite
tutti
sono d'accordo
che la nostra letteratura
vive un clima
irrespirabile,
non ha credito, non è letta, non tocca la
nazione,
non penetra in essa. Ma quando si tratta di
smuovere
quell'afa
intellettuale
che la rende
antica
come un palinsesto,
o minore
come una voce a metà
uscita dal corpo, allora cominciano
le
smanie.
Il libro dello Jemolo ha un'origine
insospettata
: è opera
di uno studioso
ìntimamente
legato alla più
approvata
tradizione
italiana:
alla cultura
borghese
e alla
fede
cattolica.
Ed è lui che per primo dichiara il fallimento
di tale
tradizione
sul piano nazionale,
il tradimento
dì quel-
Videale di vita, ad opera proprio del clero e della
classe
dirigente
borghese.
Il suo sconforto,
con Valto di fede
che Vaccompagna,
è pienamente
giustificato:
veramente,
anche per chi illuminatamente
rimane
legato a quegli
ideali, la das-sc dirigente
e l'azione
della chiesa
d'oggi
conducono
verso [*« antirisorgimento
». Per Jemolo
poi*
incerta,
pessimistica
è anche la visione del futuro,
del–
l'affermarsi
di una nuova
classe dirigente,
-diversa
so–
stanzialmente
da quella
borghese.
Parlare in questV termini mette preoccupazione
ad al–
cuni intellettuali.
La letteratura
non dovrebbe
impe–
gnarsi non solo in problemi e posizioni
storico-politiche,,
ma neppure in posizioni
morali.
Preoccuparsi
dì man–
tenere la verginità alla nostra letteratura,
non
portarla
dinanzi
od alcuna
scelta, non metterla nel pericolo
di
peccare,
questo è l'obbligo del letterato. Al massimo
può
peccare « fm-malmente », nell'uso
di certe tecniche,
nel-
Vassimilazione
[sempre
ritardata)-
di espedienti
« lette–
rari », appunto. Cioè mutare l'abito e mantenerle
la • na–
turale » castità. Se poi non è letta, unico mezzo dì sal–
vezza sarà farle rumore
attorno:
«pubblicità*,
come
si dice. Ogni giudìzio critico che entri nella sua carne*
è un attentato.
Abituata
a una critica che non
tocca
mai il fondo, che resta sospesa,
spesso con un
linguag–
gio pieno di « sospetti », alla annotazione
raffinata,
al–
l'indicazione
di quello che è o non è « poesia », gli scrit–
tori temono il contributo
della ragione,
magari la scossa,
vigorosa,
il richiamo
a questo
fatto assai
elementare:
cjie la cultura è contributo
e consapevolezza,
prima di
tutto.
Non è poi vero che la giuria del Premio non abbia ri–
conosciuto
che l'annata
letteraria in corso ha dato
buoni
risultati.
Limitati di certo, non forse superiori
a quelli
degli anni trascorsi.
Ha dato infatti
riconoscimento
a
un romanzo, che può avere dei lìmiti, ma non certo mag–
giori delle altre opere dì narrativa.
Nè come valore di
contributo
all'intelligenza
della nostra società
borghese
supera
Chiesa e Stato,
Lo supera però nella sostanza:
sta oltre, al di là di
quello
sconforto
di Jemolo.
L'Agnese va a morire
co–
mincia
esattamente
dove
Chiesa e Stato
finisce. Per Je–
molo, neppure
le speranze
di rinnovamento
contenute
nella
Resistenza
sono durate
all'azione
disgregatrice
e
immorale
della classe dirigente
al potere e degli
istituti
ecclesiastici.
Il mondo
della Resistenza
com'è
rievocalo
dalla Viganò forse rimane, nella sua modestia e inespe–
rienza
letteraria,
dentro al tono descrittivo,
forse non
s'affonda
fino alle radici di quella materia, non ne sono
tratti alla luce tutti i valori. Ma certo la generosità, la
serietà nativa con cui è raccontato^ lo rendono non solo
un aito d'amore, ma di sicurezza,
di rivendicazione
di
quei valori. Vi può essere difetto dì stile, e
perdonabile
(quasi un pregio) come in un primitivo.
Ma non vi sono
dubbi, incertezze
(neppure
nel ritmo del\a
narrazione)
per un mondo dì uomini che allora (come e con mag–
giore consapevolezza
che nel
'48
a Milano, a Roma, a
Venezia)
« fecero da sè
Questa
vera «
autonomia*
dell'azione
morale, il coraggio
delle proprie
decisioni*
la tranquilla,
nobile certezza dì poter rinfacciare
la de–
bolezza, la viltà e anche il tradimento
di chi si è posto
contro la Resistènza:
questa è la sostanza del libro di
R.
Viganò.
Se anche il valore del libro della Viganò restasse af–
fidato solo alla medesima
« sincerità»,
la sua è since–
rità positiva,
che afferma, che nasce da un mondo mo–
rale completamente
nuovo : conferma
che le
premesse
contenute
nella Resistenza
non sono state affatto
soffo–
cate dalla classe dirigente
e daV clero.
Giungono
anzi
sempre più a maggiore
consapevolezza,
sì esprimono
di–
rettamente,
si " raccontano »,
Proprio
su queste premesse
ha terreno di riuscita
la
« battaglia » laica in Italia. Poiché la fondamentale
pos–
sibilità per Vintelligenza,
per la cultura — nei
lìmiti
della borghesia e oltre — di rimanere
cultura, è questa:
maturare
un pensiero,
una morale,
una letteratura
e
arte diverse
dalla morale gesuitica,
a cui ancora
una
volta la classe dirigente
italiana sì è affidata.
Quello che le altre nazioni
civili hanno realizzato
da
più che cento anni. E per maturare
una tale
cultura,
occorre
ripensare la vita del nostro popolo, i suoi
stessi
insegnamenti,
proprio
durante
questi ultimi
cento
anni
di storia
nazionale.
R I NO D A L SASSO