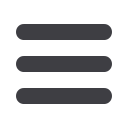
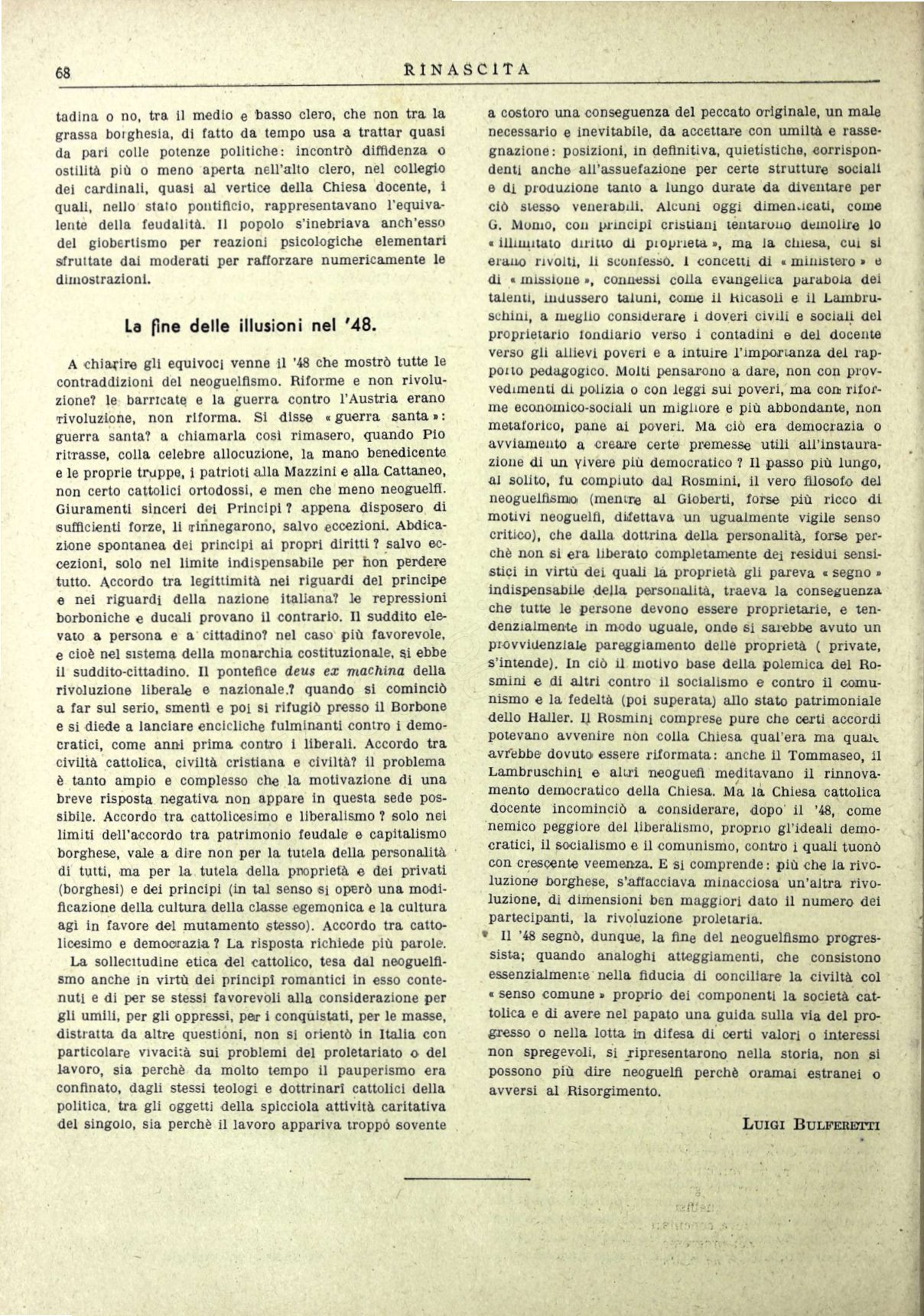
68 k I N A S C I T A
tadinao no, tra il medioebassoclero, chenon tra la
grassabolghesia, di fatto datempousaa trattar quasi
dapari collepotenzepolitiche: incontrò diffidenza o
ostilità più omenoaperta nell'alto clero, nel collegio
deicardinali, quasi al vertice dellaChiesadocente, i
quali, nello stato pontificio, rappresentavano l'equiva-
lentedella feudalità. I l popolo s'inebriavaanch'esso
delgiobertismo per reazioni psicologicheelementari
sfruttatedai moderati per rafforzarenumericamente le
diinostrazioni.
La finedeleilusioninel'48.
A'chiarire gli equivocivenne il '48chemostrò tutte le
contraddizioni del neoguelfismo.Riformee non rivolu-
zione? le barricate e la guerracontro l'Austria erano
Tivoluzione, non riforma. Si disse « guerrasanta»:
guerrasanta? a chiamarlacosì rimasero,quandoPio
ritrasse, collacelebreallocuzione, lamanobenedicente
eleproprietruppe, i patrioti allaMazzinieallaCattaneo,
noncertocattolici ortodossi, emenchemenoneoguelfi.
Giuramenti sinceri dei Principi?appenadisposero di
'sufficienti forze, li rinnegarono,salvoeccezioni.Abdica-
zionespontaneadei principi ai propri diritti? salvoec-
cezioni,solo nel limite indispensabileper nonperdere
tutto.Accordo tra legittimità nei riguardi del principe
enei riguardi della nazione italiana? le repressioni
borbonicheeducali provano il contrarlo. Il sudditoele-
vatoa personae a cittadino? nel casopiù favorevole.
ecioènelsistemadellamonarchiacostituzionale., siebbe
il suddito-cittadino. I l pontefice
deusexmachina
della
rivoluzione liberale e nazionale.?quando si cominciò
afar sul serio,smentìepoi si rifugiòpresso il Borbone
esidiedealanciareencicliche fulminanti contro i demo-
cratici,comeanni primacontro i liberali.Accordo tra
civiltàcattolica, civiltà cristiana e civiltà? il problema
ètantoampio ecomplessoche lamotivazione. di una
breverispostanegativanonappare in questasedepos-
sibile.Accordo tra cattolicesimoe liberalismo?solonei
limiti dell'accordo tra patrimoniofeudaleecapitalismo
borghese,vale a direnonper la tuteladellapersonalità
di tutti, ma per la tutela dellaprioprietà e dei privati
(borghesi)edei principi (in tal sensosioperòunamodi-
ficazionedellaculturadellaclasseegemonicaela cultura
agì in favoredelmutamentostesso).Accordo tra catto-
licesimoedemocrazia?La rispostarichiedepiùparole.
Lasollecitudineeticadel cattolico, tesadal neoguelfi-
smoanche in virtù dei principi romantici inessoconte-
nuti edi persestessi favorevoli allaconsiderazioneper
gli umili, per gli oppressi,per i conquistati,per lemasse,
distrattadaaltrequestioni,non si orientò in Italia con
particolarevivacizà sui problemi del proletariato o del
lavoro, siaperchè da molto tempo i l pauperismoera
confinato,dagli stessi teologi e dottrinari cattolici della
politica, tra gli oggetti dellaspicciola attività caritativa
'delsingolo, siaperchè il lavoroapparivatropposovente
acostorounaconseguenzadelpeccatooriginale,unmale
necessarioe inevitabile, daaccettareconumiltàerasse-
gnazione:posizioni, in definitiva, quietistiche,corrispon-
dentiancheall'assuefazioneper certe strutture sociali
edi produzione tanto a lungoduratedadiventareper
ciòstessavenerabili. Alcuni oggi dimen‘icati, come
G.Munio, con principi cristiani tentaronodemolire lo
a illimitato diritto di pioprieta»,ma la chiesa, cui si
erailo rivolti, l i sconfessò. I concetti di «ministero»e
di «missione»,connessi collaevangelicaparabola dei
talenti, indussero taluni, come il lticasoli e il Lambru-
schini, ameglioconsiderare i doveri civili e sociali del
proprietario iondiario verso i contadini e del docente
versogli allievi poveri e a intuire l'imperianzadel rap-
pollopedagogico.Moltipensaronoadare,nonconprov-
vedimenti di poliziaoconleggi sui poveri,macon rifor-
meeconomico-sociali unmiglioreepiùabbondante,non
metaforico,pane ai poveri. Ma ciò erademocrazia o
avviamento a crearecertepremesse utili all'instaura-
zionedi unviverepiudemocratico? Il passopiù lungo,
al solito, fu compiuto dal Rosmini, i l vero filosofodel
neoguelfismo(menire al Gioberti, forse più ricco di
motivi neoguelfi, dilettava unugualmentevigilesenso
critico), che dalla dottrina dellapersonalità, forse per-
chenon si era liberatocompletamentedei residui sensi-
stici in virtù dei quali la. proprietà gli pareva«segno»
indispensabiledella personalità, traeva la conseguenza
chetutte le personedevonoessereproprietarie, e ten-
denzialmenteMmodouguale,ondesisarebbeavutoun
provvidenzialepareggiamentodelleproprietà ( private,
s'intende). In ciò il motivobasedellapolemicadelHo-
salini e di altri contro i l socialismo e contro il comu-
nismoe la fedeltà (poisuperata.)allo statopatrimoniale
delloHaller. Il Rosminicompresepurechecerti accordi
potevanoavvenirenon collaChiesaqual'eramaqualk.
a.vfebbedovutaessereriformata: anche il Tommaseo, il
Lambruschini e aliri neoguefimeditavano i l rinnova-
mentodemocraticodellaChiesa.Ma laChiesacattolica
docenteincominciò a considerare, dopo i l '48, come
nemicopeggioredel liberalismo, proprio gl'idealidemo-
cratici, il socialismoe il comunismo,contro i quali tuonò
concrescenteveemenza.Esicomprende: piùchela rivo-
luzioneborghese,s'.affacciavaminacciosaun'altra rivo-
luzione, di dimensionibenmaggiori dato il numerodei
partecipanti, la rivoluzione proletaria.
v i l '48segnò,dunque, la finedelneoguelfismoprogres-
sista;quandoanaloghi atteggiamenti, che consistono
essenzialmenzenella fiducia di concilia;re la civiltà col
«sensocomune»proprio dei componenti la societàcat-
tolicaedi averenelpapatounaguidasulla via del pro-
gressoo nella lotta in difesa di certi valori o interessi
nonspregevoli, s'i ripresentarono nella storia, non si
possonopiù dire neoguelfi perchèoramai estranei o
avversi al Risorgimento.
LUIGI BULFEREITI
















