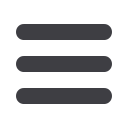
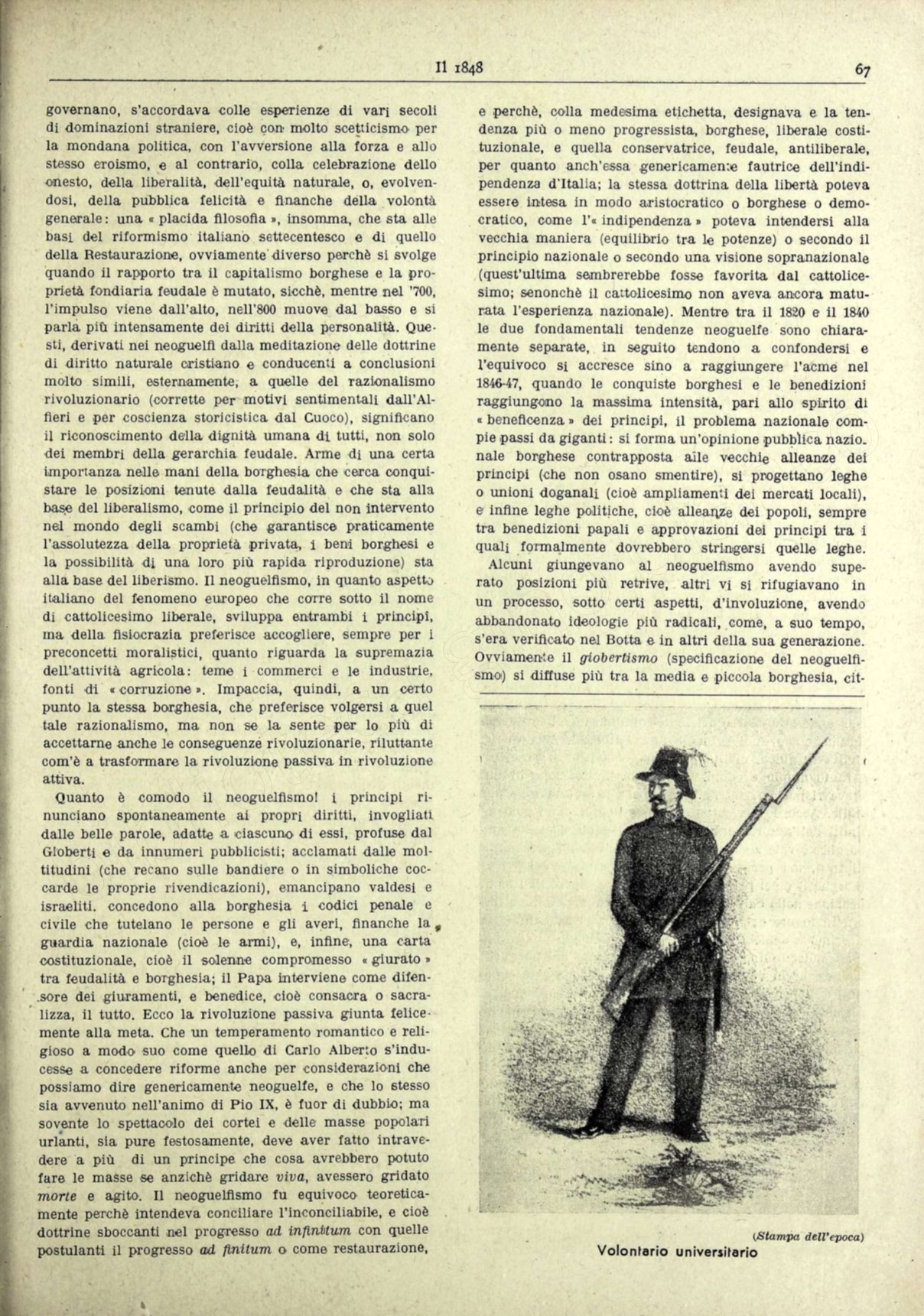
Il1848
6
7
governano,s'accordavacolleesperienze di vari secoli
didominazionistraniere,cioègonimoltoscetticismoper
lamondanapolitica, conl'avversionealla forzae allo
stessoeroismo, e al contrario, collacelebrazionedello
onesto,della liberalità., dell'equitànaturale, o,evolven-
dosi,della pubblica felicità. e financhedellavolontà
generale:una«placidafilosofia»,insomma,chestaalle
basidel riformismo italiani)setecentescoe di quello
delaRestaurazione,ovviamentediversoperchèsisvolge
quando il rapporto tra il capitalismoborghesee la pro-
prietàfondiariafeudaleèmutato,sicchè,mentrenel'700,
l'impulsovienedall'alto,nell'800muovedalbassoe si
parlapiúintensamentedei diritti dellapersonalità.Que-
sti,derivatineineoguelfidalameditazionedelledottrine
di diritto naturalecristianoeconducenti a conclusioni
moltosimili, esternamente, a quelle del razionalismo
rivoluzionario(corretteper'motivi sentimentali dall'Al-
fieriepercoscienzastoricisticadalCuoco),significano
il riconoscimentodelladignitàumanadi tutti, nonsolo
deimembridellagerarchiafeudale.Arme di unacerta
importanzanellemanidellaborghesiacheCercaconqui-
stare le posizioni tenutedalla feudalità echesta alla
basedel liberalismo,come il principiodelnonintervento
nelmondodegli scambi (chegarantiscepraticamente
l'assolutezzadellaproprietàprivata, i beni,borghesi e
lapossibilità, di una loro più rapidariproduzione) sta
allabasedelliberismo. Il neoguelfismo,inquantoaspetta
italianodel fenomenoeuropeochecorresotto il nome.
dicattolicesimoliberale, sviluppaentrambi i principi,
madella fisiocraziapreferisceaccogliere,sempreper i
preconcettimoralistici,quantoriguarda la supremazia
dell'attivitàagricola: teme i commerci e le industrie,
fonti ,di «corruzione».Impaccia, quindi, a un certo
puntolastessaborghesia,chepreferiscevolgersi aquel
talerazionalismo,ma nonse la senteper lo più di
accetarneancheleconseguenzerivoluzionarie, riluttante
com'èatrasformare la rivoluzionepassivainrivoluzione
attiva.
Quanto è comodo i l neoguelfismol i principi ri-
nuncianospontaneamente ai propri diritti, invogliati
dallebelleparole,adatteaciascunodi essi,profusedal
Giobertiedainnumeri pubblicisti;acclamatidallemol-
titudini (cherecanosullebandiereo insimbolichecoc-
cardele proprierivendicazioni),einancipanovaldesi e
israeliti.concedonoalla borghesia i codici penale e
civilechetutelano lepersonee gli averi, finanche la •
guardianazionale(cioè le armi), e, infine, unacarta*
costituzionale,cioè i l solennecompromesso«giurato»
trafeudalitàeborghesia; il Papaintervienecomedifen-
soredeigiuramenti, ebenedice,cioèconsacraosacra-
lizza, il tutto.Ecco la rivoluzionepassivagiuntafelice-
menteallameta.Cheuntemperamentoromanticoereli-
giosoamodasuocomequello di CarloAlbertos'indu-
cesseaconcedereriformeancheperconsiderazioniche
possiamodiregenericamenteneoguelfe, eche lostesso
siaavvenutonell'animodi Pio IX, è fuor di dubbio;ma
soventelo spettacolodei cortei e dellemassepopolari
urtanti, siapurefestosamente,deveaver fatto intrave-
derea più d i un principechecosaavrebberopotuto
fare lemasseseanzichègridareviva,avesserogridato
morte
e agito. I l neoguelfismo fu equivocoteoretica-
menteperchèintendevaconciliarel'inconciliabile, ecioè
dottrinesboccantinelprogressoad
inlinitum
conquelle
postulanti il progressoad
Annum
ocomerestaurazione,
h
eperchè,collamedesimaetichetta,designavae la ten-
denzapiù omenoprogressista,borghese,liberalecosti-
tuzionale, e quellaconservatrice, feudale, antiliberale,
perquantoanch'essagenericamemefautrice dell'indi-
pendenzad'Italia; lastessadottrinadella libertàpoteva
essereintesa inmodoaristocraticooborgheseodemo-
cratico,come l'« indipendenza»potevaintendersi alla
vecchiamaniera(equilibrio tra lepotenze)osecondo il
principionazionaleosecondounavisionesopranazionale
(quest'ultimasembrerebbefosse favorita dal cattolice-
simo;senonchè11cattolicesimononavevaancoramatu-
ratal'esperienzanazionale).Mentre tra il 1820e il 1840
ledue fondamentalitendenzeneoguelfesonochiara-
menteseparate, in seguitotendono a confondersi e
l'equivoco si accrescesino a raggiungerel'acme nel
1846-47,quando le conquisteborghesi e le benedizioni
raggiungono lamassimaintensità, pari allo spirito di
«beneficenza»dei principi, il problemanazionalecom-
piepassidagiganti: si formaun'opinionepubbilcanazio_
naleborghesecontrappostaalle vecchiealleanze dei
principi (chenonosanosmentire), si progettanoleghe
O imionidoganali(cioèampliamentideimercati locali),
einfineleghepolitiche,cioèalearìzedeipopoli,sempre
trabenedizionipapali eapprovazionidei principi tra i
quali.formalmentedovrebberostringersi quelle leghe.
Alcunigiungevano al neoguelfismoavendosupe-
ratoposizioni più retrive, altri vi Si rifugiavano in
unprocesso,sotto certi aspetti,d'involuzione,avendo
abbandonatoideologiepiù radicali,.come,asuotempo,
s'eraverificatonelBottae in altri dellasuagenerazione.
Ovviamente il
giobertismo
(specificazionedelneoguelfi-
smo)si diffusepiù tra lamediaepiccolaborghesia,cit-
........
,•••••n•-••••-•,,,,woc••••••••
(Stampadell'epoca)
Volontariouniversitario
















