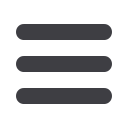
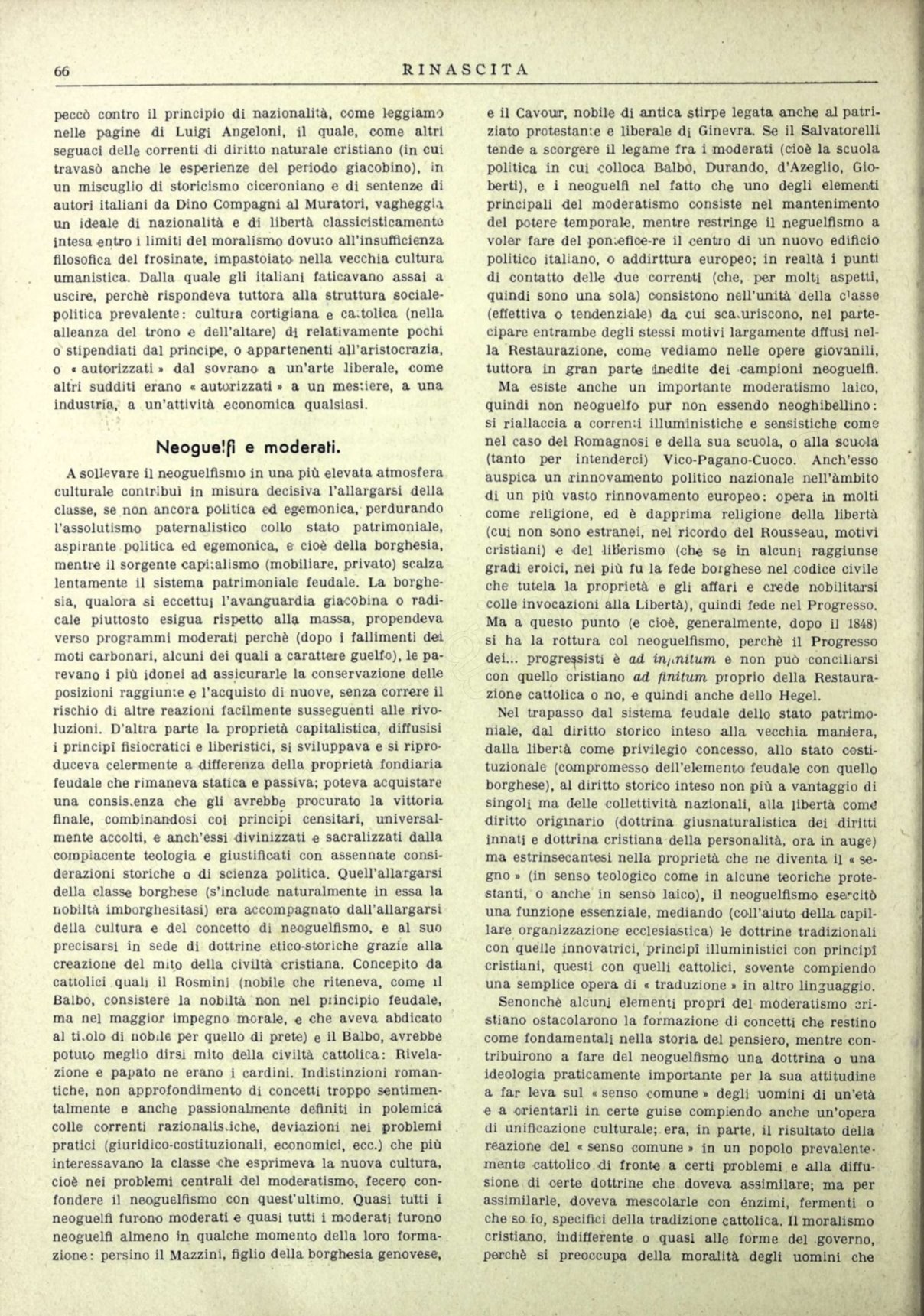
66
R I
N A S C I
T A
peccòcontro il principio di nazionalità.,comeleggiamg
nelepagine di LuigiAngeloni, i l quale,come altri
seguacidellecorrenti di dirittonaturalecristiano (in cui
travasòanche leesperienzedelperiod-ogiacobino), in
unmiscugliodi storicismociceronianoe di sentenzedi
autori italiani daDinaCompagnialMuratori,vagheggia
unideale di nazionalitàe di libertàclassicisticamente
intesaentro i limiti delmoralismodovutoall'insufficienza
filosoficadelfrosinate, impastoiatanellavecchiacultura
umanistica.Dallaquale gli italiani faticavanoassai a
uscire,perchèrispondevatuttora alla strutturasociale-
politicaprevalente: culturacortigianaeca,tolica(nella
aleanzadel tronoedell'altare) di relativamentepochi
ostipendiatidalprincipe,oappartenentiall'aristocrazia,
o«autorizzati»dal sovrano a un'arte liberale,come
altri sudditierano«autorizzati»a unmestiere, a una
industria, a un'attivitàeconomicaqualsiasi.
Neoguernemoderati.
Asolevare il neoguelfismoinunapiùelevataatmosfera
culturalecontribuì
in
misuradecisiva l'allargarsi della
classe,senonancorapoliticaedegemonica,perdurando
l'assolutismopaternalistico collo stato patrimoniale,
aspirantepoliticaedegemonica,ecioèdellaborghesia,
mentre il sorgentecapitalismo(mobiliare,privato)scalza
lentamente il sistemapatrimonialefeudale. Laborghe-
sia,qualora si eccettui l'avanguardiagiacobinao radi-
calepiuttostoesiguarispetto allamassa,propendeva
versoprogrammimoderatiperchè(dopo i fallimenti dei
moticarbonari,alcunideiquali acarattereguelfe), lepa-
revano i piùidoneiadassicurarle laconservazionedelle
posizioniraggiunteel'acquistodinuove,senzacorrere il
rischiodi altrereazioni facilmentesusseguentialle rivo-
luzioni.D'altraparte la proprietàcapitalistica, diffusisi
i principi fisiocraticieliberistici, si sviluppavaesi ripro-
ducevacelermenteadifferenzadellaproprietàfondiaria
feudalecherimanevastaticaepassiva;potevaacquistare
unaconsis.enzache gli avrebbeprocurato la vittoria
finale,combinandosi coi principi censitari, universal-
menteaccolti,eanch'essidivinizzati esacralizzati dalla
compiacenteteologiaegiustificati conassennateconsi-
derazionistoricheo di scienzapolitica.Quell'allargarsi
delaclasseborghese(s'includenaturalmente inessala
nobiltàimborghesitasi)eraaccompagnatodall'allargarsi
delacultura e del concetto di neoguelfismo,e al suo
precisarsi in sededi dottrineetico-storichegrazie alla
creazionedelmitodella civiltà cristiana.Concepitoda
cattolici quali il Rosmini (nobilecheriteneva,come il
Balbo,consistere la nobiltànon nel principio feudale,
manelmaggiorimpegnomorale, echeavevaabdicato
al ti,olo di nobileperquelodi prete)e il Balbo,avrebbe
potutomegliodirsi mitodella civiltà cattolica:Rivela-
zioneepapatoneerano i cardini. Indistinzioni roman-
tiche,nonapprofondimentodi concetti tropposentimen-
talmentee anchepassionalmentedefiniti in polemica
colecorrenti razionalis,iche, deviazioni nei problemi
pratici (giuridico-costituzionali,economici,ecc.)chepiù
interessavanolaclassecheesprimeva lanuovacultura,
cioèneiproblemi centrali delmoderatismo,fecerocon-
fondere il neoguelfismoconquest'ultimo.Quasi tutti i
neoguelfifuronomoderatiequasi tutti i moderatifurono
neoguelfialmenoinqualchemomentodella loroforma-
zione:persino il Mazzini, figliodellaborghesiagenovese,
eil Cavouir,nobiledi anticastirpelegataancheal patri-
ziatoprotestanteeliberale diGinevra.Se il Salvatorelli
tendeascorgere
il
legamefra i moderati(cioè lascuola
politica in cui colloca13albo,Durando,d'Azeglio,Gio-
berti), e i neoguelfi nel fatto cheuno degli elementi
principali delmoderatismoconsistenelmantenimento
delpoteretemporale,mentrerestringe il neguelfismoa
volerfaredelpontefice-re il centrodi unnuovoedificio
politico italiano, o addirtturaeuropeo; in realtà i punti
di contattodelleduecorrenti (che, per molti aspetti,
quindisanounasola)consistononell'unitàdellaclasse
(effettivao tendenziale)da cui sca.uriscono, nel parte-
cipareentrambedeglistessimotivi largamentedffusinel-
laRestaurazione,comevediamonelleoperegiovanili,
tuttora in gran parte 'inedite dei .campionineoguelfi.
Maesisteanche un importantemoderatismo laico,
quindinonneoguelfopur nonessendoneoghibellino:
si riallaccia acorrenti illuministicheesensistichecome
nelcasodelRomagnasiedellasuascuola,oallascuola
(tanto per intenderci) Vico-Pagano-Cuoco.Anch'esso
auspicaunrinnovamentopoliticonazionalenell'àmbito
di un piùvastorinnovamentoeuropeo;opera in molti
comereligione, ed è dapprimareligione della libertà
(cuinonsonoestranei,nel ricordodelRousseau,motivi
cristiani) e del lilierismo (chese in alcuni raggiunse
gradieroici, nei più fu lafedeborghesenelcodicecivile
chetutela la proprietà e gli affari e
erede
nobilitarsi
coleinvocazioniallaLibertà),quindifedenelProgresso.
Maaquestopunto (ecioè,generalmente,dopo il 1848)
si ha la rottura colneoguelfismo,perchè il Progresso
dei...prograristi è ad inpnitume nonpuòconciliarsi
conquellocristianoad
finitum
propriodellaRestaura-
zionecattolicaono,equindianchedelloHegel.
Neltrapassodal sistemafeudaledellostatopatrimo-
niale, dal diritto storico inteso alla vecchiamaniera,
dallalibertà,comeprivilegioconcesso,allo statocosti-
tuzionale(compromessodel'elementofeudaleconquello
borghese),al dirittostoricointesononpiùavantaggiodi
singolimadellecollettività,nazionali, alla libertàcome
dirittooriginario (dottrinagiusnaturalistica dei diritti
innatiedottrinacristianadellapersonalità,ora inauge)
maestrinsecantesinellaproprietàchenediventa il «se-
gno»(insensoteologicocomeinalcuneteoricheprote-
stanti, oanche insensolaico), il neoguelfismoesercitò
un,afunzioneessenziale,mediando(coll'aiutodellacapil-
lareorganizzazione'ecclesiastica) ledottrine tradizionali
conquelleinnovatrici, 'principi illuministiciconprincipi
cristiani,questiconquelli cattolici,soventecompiendo
unasempliceoperadi«traduzione»in altrolinguaggio.
Senonchèalcunielementipropri delmdderatismocri-
stianoostacolarono la formazionedi concetticherestino
comefondamentalinellastoriadelpensiero,mentrecon-
tribuirono a faredelneoguelfismounadottrina o una
ideologiapraticamenteimportanteper lasuaattitudine
afar levasul «sensocomune»degli uomini di un'età
ea orientarli in certeguisecompiendoancheun'opera
diunificazioneculturale;era, in parte, il risultatodella
reazionedel «sensocomune»in unpopoloprevalente-
mentecattolico di fronte a certi problemi e alla diffu-
sione.dicertedottrinechedovevaassimilare;maper
assimilarle,dovevamescolarleconénzimi, fermenti o
chesoio,specificidelatradizionecattolica. Il moralismo
cristiano, indifferente o quasi alle forme del .governo,
perchèsi preoccupadellamoralità degli uomini che
















