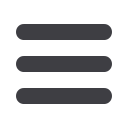
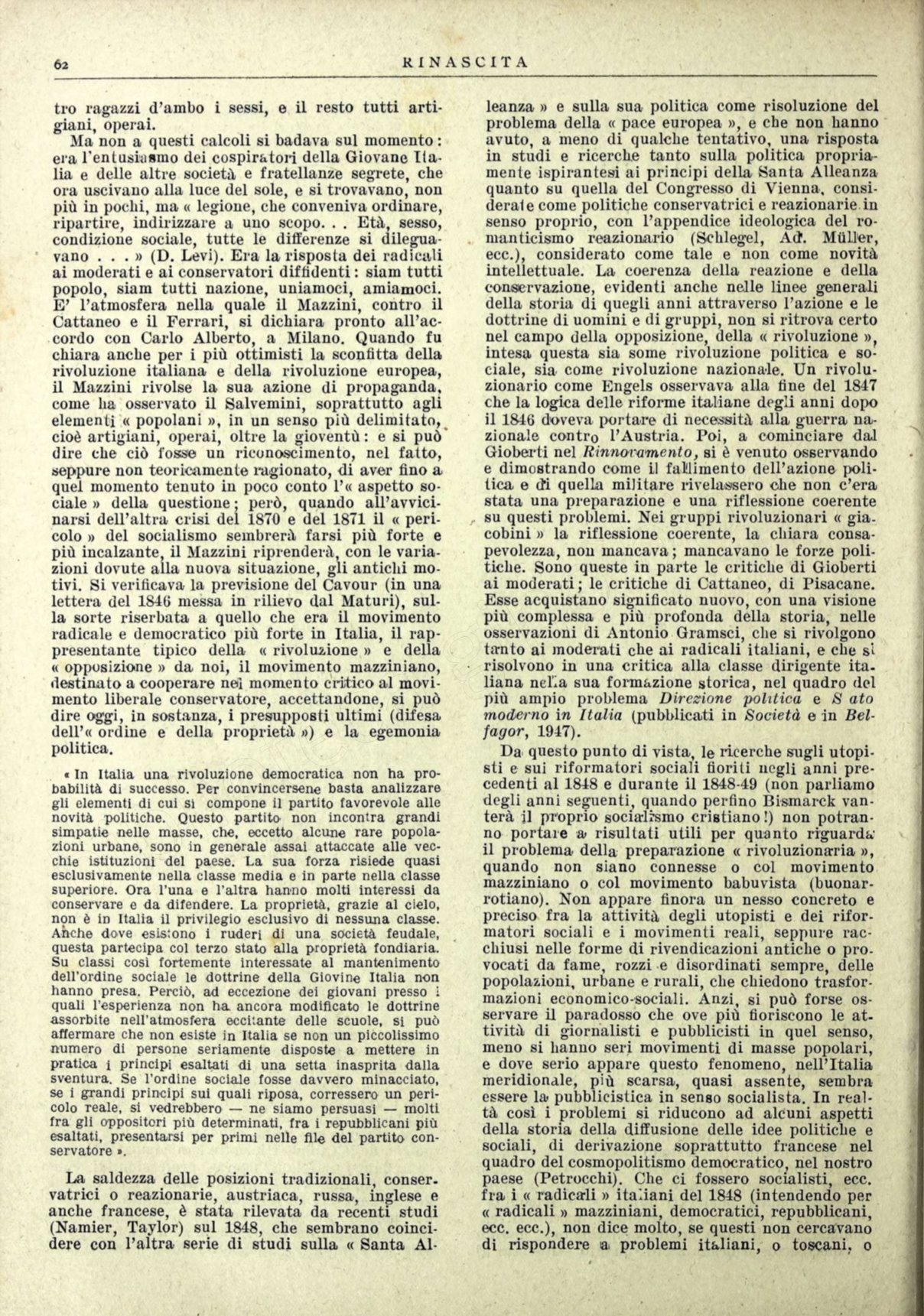
62 R I N A S C I T A
troragazzid'ambo i sessi,e il resto tutti arti-
giani,operai.
Manonaquesticalcoli sibadavasulmomento:
eral'entusiasmodeicospiratoiidellaGiovaneIta-
liaedellealtresocietù,efratellanzesegrete,che
orauscivanoallalucedelsole,esi trovavano,non
piùinpochi,ma«legione,checonvenivaordinare,
ripartire, indirizzareaunoscopo. . Età,sesso,
condizionesociale, tutte ledifferenze si dilegua-
vano. . . »
(D.
Levi).Era larispostadei radicali
aimoderatieaiconservatoridiffidenti:siamtutti
popolo,siam tutti nazione,uniamoci,amiamoci.
E' l'atmosferanellaquale il Mazzini,contro il
Cattaneoe il Ferrari, si dichiaraprontoall'ac-
cordoconCarloAlberto, a Milano.Quando fu
chiaraancheper i piùottimisti lasconfittadela
rivoluzioneitaliana e dellarivoluzioneeuropea,
il Mazzini rivolse la suaazione di propaganda,
comehaosservato il Salvemini,soprattutto agli
elementi«popolani», inunsensopiùdelimitato,
cioèartigiani,operai, oltre lagioventù: e sipuò"
direcheciòfosseunriconoscimento,nel fatto,
seppurenonteoricamenteragionato,diaverfinoa
quelmomentotenuto inpococontol'«aspettoso-
ciale»dellaquestione;però,quandoall'avvici-
narsidell'altra crisi del1870edel1871 il «peri-
colo»del socialismosembreràfarsi più forte e
piùincalzante, il Mazziniriprenderà,conlevaria-
zionidovuteallanuovasituazione, gli antichimo-
tivi. Si verificavalaprevisionedelCavour(inuna
letteradel1846messain rilievodalMaturi), sul-
lasorteriserbataaquellocheera il movimento
radicaleedemocraticopiù forte in Italia, il rap-
presentantetipico della « rivoluzione»e della
opposizione»danoi, il movimentomazziniano,
destinatoacooperareneimomentocriticoalmovi-
mentoliberaleconservatore,accetandone,si può
direoggi, insostanza, i presuppostiultimi (difesa
del'«ordinee dellaproprietà»)e laegemonia
politica.
« In Italiaunarivoluzionedemocraticanonhapro-
babilitàdisuccesso.Perconvincersenebastaanalizzare
glielementidicuisicomponeil partitofavorevolealle
novitàpolitiche.Questopartito.nonincontragrandi
simpatienellemasse,che,eccettoalcunerarepopola-
zioniurbane,sonoinge-neraleassaiattaccateallevec-
chieistituzionidelpaese.Lasuaforzarisiedequasi
esclusivamentenellaclassemediaeinpartenellaclasse
superiore.Oral'unae l'altrahannomoltiinteressida
conservareedadifendere.Laproprietà,graziealcielo,
nonè in Italia il privilegioesclusivodinessunaclasse.
Anchedoveesistono i ruderi di unasocietàfeudale,
questapartecipacolterzostatoallaproprietàfondiaria.
Suclassicosìfortementeinteressatealmantenimento
del'ordinesocialeledottrinedellaGiovineItalianon
hannopresa.Perciò,adeccezionedeigiovanipresso i
qualil'esperienzanonhaancoramodificatoledottrine
assorbitenell'atmosferaeccitantedellescuole, si può
afermarechenonesistein Italiasenonunpiccolissimo
numerodipersoneseriamentedisposte a mettere in
pratica j principiesaltati di unasettainaspritadalla
sventura.Sel'ordinesocialefossedavverominacciato,
sei grandiprincipisuiqualiriposa,corresserounperi-
coloreale,sivedrebbero—nesiamopersuasi—molti
fraglioppositoripiùdeterminati,fra i repubblicanipiù
esaltati,presentarsiperpriminellefiledelpartitocon-
servatore».
Lasaldezzadelleposizioni tradizionali,conser-
vatrici o reazionarie,austriaca,russa, inglesee
anchefrancese,èstatarilevatadarecenti studi
(Namier,Taylor) sul1848,chesembranocoinci-
derecon l'altra seriedi studi sulla«SantaAl-
leanza»esullasuapoliticacomerisoluzionedel
problemadella«paceeuropea»,echenonhanno
avuto,amenodi qualchetentativo,unarisposta
instudi ericerchetantosullapoliticapropria-
menteispirantesi ai principi dellaSantaAlleanza
quantosuquelladelCongressodi Vienna,consi- deralecomepoliticheconservatriciereazionarie.in sensoproprio,conl'appendiceideologicadel ro-manticismoreazionario ( Schlegel,Ad. MtiDer,
ecc.),consideratocometale enoncomenovità
intellettuale. Lacoerenzadellareazioneedella
conservazione,evidentianchenellelineegenerali
dellastoria di queglianniattraversol'azioneele
dottrinediuominiedigruppi,nonsi ritrovacerto
nelcampodellaopposizione,della«rivoluzione»,
intesa,questasiasomerivoluzionepolitica eso-
ciale,siacomerivoluzionenazionale.Un rivolu-
zionariocomeEngelsosservavaalla finedel1847
chelalogicadelleriformeitalianedegliannidopo
il1846dovevaportaredinecessitàallaguerrana-
zionalecontro l'Austria. Poi, a cominciaredal
Giobertinel
Rinnoromento
,
si
èvenutoosservando
edimostrandocome il fallimentodell'azionepoli-
ticaedi quelamilitarerivelasserochenonc'era
stataunapreparazioneeunariflessionecoerente
suquestiproblemi.Neigruppi rivoluzionari«gia-
cobini»la riflessionecoerente, la chiaraconsa-
pevolezza,nonmancava;mancavanoleforzepoli-
tiche.Sonoquesteinparte lecritichediGioberti
aimoderati; lecritiche diCattaneo, diPisacane.
Esseacquistanosignificatonuovo,conunavisione
piùcomplessae piùprofondadellastoria, nelle
osservazionidiAntonioGramsci,chesi rivolgono
tantoaimoderaticheai radicali italiani, echesi
•risolvono inunacritica allaclassedirigente ita.
liananeLasuaformazionestorica,nelquadrodel
piùampioproblemaDirezionepolitica e 8 ato
modernoin Italia (pubblicati inSocietàe inBel-
fagor,
1947).
Daquestopuntodi vista, lericerchesugliutopi-
sti esui riformatori sociali fioriti negliannipre-
cedential1848edurante il 1848-49(nonparliamo
deglianniseguenti,quandoperfinoBismarckvan-
terà il propriosocialismocristiano!)nonpotran-
noportarea, risultati utili perquantoriguarda:
il problemadellapreparazione«rivoluzionaria»,
quandonon sianoconnesse o col movimento
mazzinianoo colmovimentoba,buvista(buonar-
rotiano).Nonapparefinoraunnessoconcretoe
precisofra la attività degli utopisti edei rifor-
matorisociali e i movimenti reali,seppurerac-
chiusinelleformedi rivendicazionianticheopro-
vocatidafame,rozzi.edisordinatisempre,delle
popolazioni,urbaneerurali,chechiedonotrasfor-
mazionieconomico-sociali.Anzi, si puòforseos-
servare il paradossocheovepiùfiorisconoleat-
tività di giornalisti e pubblicisti in quelsenso,
menosihannoserimovimenti dimassepopolari,
edoveserioapparequestofenomeno,nell'Italia
meridionale, più scarsa,quasiassente,sembra
essere
la:
pubblicistica insensosocialista. In real-
tàcosì i problemi si riduconoadalcuni aspetti
delastoriadelladiffusionedelleideepolitichee
sociali, di derivazionesoprattuttofrancesenel
quadrodelcosmopolitismodemocratico,nelnostro
paese(Petrocchi).Che ci fosserosocialisti,ecc.
fra i «radicali» ita:iani del1848(intendendoper
( radicali))mazziniani,democratici,repubblicani,
ecc.ecc.),nondicemolto,sequestinoncercavano
dirispondereaiproblemi italiani, o toscani, o
















