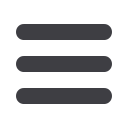
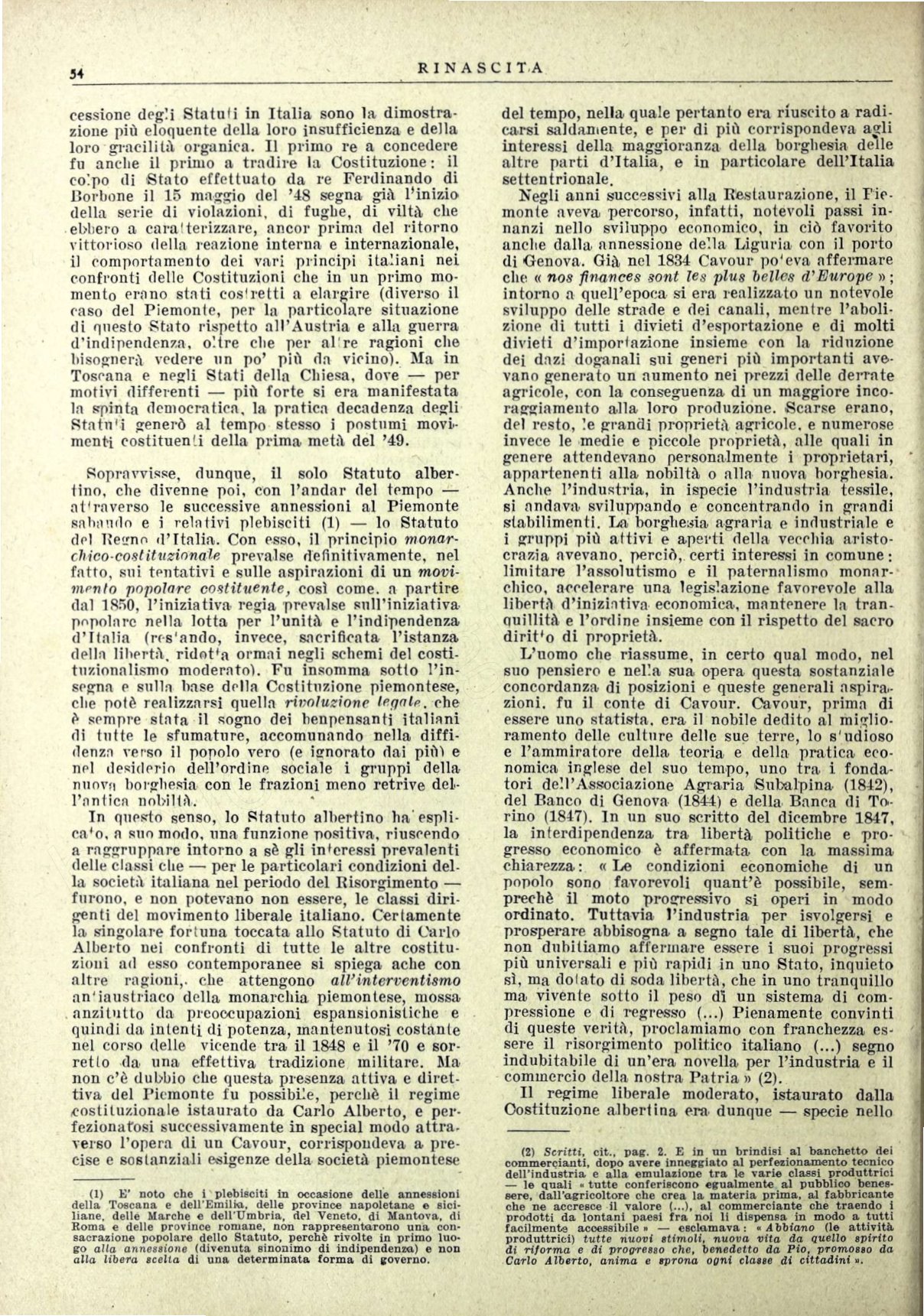
54
RINASCITA
cessionede.gliStatutiinItaliasonoladimostra-
zionepiùeloquentedelaloroinsufficienzaedella
lorogracilitàorganica. Il primo
re
aconcedere
fuancheil primoa tradire laCostituzione: il
co:podiStatoeffettuatodareFerdinandodi
13orboneil 15maggiodel '48segnagiàl'inizio
delaseriediviolazioni,di fughe,di viltàche
ebberoacara!terizzare,ancorprimadelritorno
vitoriosodellareazioneinternaeinternazionale,
ilcomportamentodeivariprincipi italianinei
confrontideleCostituzionicheinunprimomo-
mentoeranostaticosirettiaelargire(diversoil
casodelPiemonte,perlaparticolaresituazione
diquestoStatorispettoall'Austriaeallaguerra
d'indipendenza,&trecheperal'reragioniche
bisogneràvedereunpo'piùdavicino).Ma in
ToscanaenegliStatidellaChiesa,dove—per
motividifferenti—piùfortesieramanifestata
laspintademocratica,lapraticadecadenzadegli
Statu'igeneròaltempostessoipostumimovi-
menticostituentidellaprimametàdel'49.
Sopravvisse,dunque, il soloStatutoalber-
tino,chedivennepoi,conl'andardeltempo—
atiraversolesuccessiveannessionialPiemonte
sahandne i relativiplebisciti(1)—loStatuto
delRegno(l'Italia.Conesso,ilprincipio
monar-
chico-costituzionale
prevalsedefinitivamente,nel
fatto,suitentativiesuleaspirazionidiun
movi-
mentopopolarecostituente,cosìcome.apartire
dal1850,l'iniziativaregiaprevalsesull'iniziativa
pnpolarenellalottaperl'unitàel'indipendenza
d'Italia(restando,invece,sacrificata,l'istanza
delalibertà,ridottaormaineglischemidelcosti-
tuzionalismomoderato).Fuinsommasottol'in-
segnaesullabasedellaCostituzionepiemontese,
chepotèrealizzarsiquella
rivoluzionelegate.
che
èsemprestata ilsognodeibenpensantiitaliani
ditutte lesfumature,accomunandonelladiffi-
denzaversoilpopolovero(eignoratodaipiù)e
neldesideriodell'ordinesociale i gruppidella
nuovaborghesiaconlefrazionimenoretrivedel-
l'anticanobiltà.
Inquestosenso,loStatutoalbertinoha'espli-
ca4o,asuomodo,unafunzionepositiva,riuscendo
araggruppareintornoasègliinteressiprevalenti
deleclassiche—perleparticolaricondizionidel-
lasocietàitaliananelperiododelRisorgimento
furono,enonpotevanononessere,leclassidiri-
gentidelmovimentoliberaleitaliano.Certamente
lasingolarefortunatoccataalloStatutodiCarlo
Albertoneiconfrontidi tutte lealtrecostitu-
zioniadessocontemporaneesispiegaachecon
altreragioni,,cheattengono
all'interventismo
anliaustriacodellamonarchiapiemontese,mossa
anzituttodapreoccupazioniespansionistichee
quindidaintentidipotenza,mantenutosicostante
nelcorsodelevicendetra il1848e il '70esor-
retto‘daunaeffettivatradizionemilitare.Ma
nonc'èdubbiochequestapresenzaattivaediret-
tivadelPiemontefupossibile,perchèil regime
/costituzionaleistauratodaCarloAlberto,eper-
fezionatosisuccessivamenteinspecialmodoattra,
versol'operadiunCavour,corrispondevaapre-
ciseesostanzialiesigenzedelasocietàpiemontese
•
(1) E' notoche i ' plebisciti inoccasionedelleannessioni
delaToscanae dell'Emilio„delleprovincenapoletane e sici-
liane,delleMarcheedell'Umbria,delVeneto, diMantova, di
Romaedelleprovinceromane,nonrappresentaronounacon-
sacrazionepopolaredelloStatuto,perchérivolte inprimoluo-
go
allaannessione
(divenutasinonimodi indipendenza)enon
alla
libera
scelta
di unadeterminataformadigoverno.
deltempo,nellaqualepertantoerariuscitoaradi-
carsisaldamente,eperdipiùcorrispondevaagli
interessidellamaggioranzadellaborghesiadelle
altreparti d'Italia, e inparticolaredell'Italia
setentrionale.
NegliannisuccessiviallaRestaurazione,ilPie-
monteavevapercorso,infatti,notevolipassiin-
nanzinellosviluppoeconomico,inciòfavorito
anchedallaannessionedellaLiguriaconilporto
diGenova.Giànel1834Cavourpo4evaaffermare
che«nosfinancessontlesplusbellesd'Europe»;
intornoaquell'epocasierarealizzatounnotevole
sviluppodelestradeedeicanali,mentrel'aboli-
zionedi tutti i divietid'esportazioneedimolti
divietid'importazioneinsiemeconlariduzione
deidazidoganalisuigeneripiùimportantiave-
vanogeneratounaumentoneiprezzidelederrate
agricole,conlaconseguenzadiunmaggioreinco-
raggiamentoallaloroproduzione.Scarseerano,
delresto,:egrandiproprietàagricole,enumerose
invecele.medieepiccoleproprietà,allequali in
genereatendevanopersonalmente i proprietari,
appartenentiallanobiltàoallanuovaborghesia.
Anchel'industria, inispeeiel'industriatessile,
siandavasviluppandoeconcentrandoingrandi
stabilimenti.Laborghesiaagrariaeindustrialee
igruppipiùattivi eapertidellavecchiaaristo-
craziaavevano,perciò,certiinteressiincomune
limitarel'assolutismoe il paternalismomonar-
chico,accelerareunalegislazionefavorevolealla
libertàd'iniziativaeconomica,mantenerelatran-
quillitàel'ordineinsiemeconilrispettodelsacro
dirit'odiproprietà.
L'uomocheriassume,incertoqualmodo,nel
suopensieroenel:asuaoperaquestasostanziale
concordanzadiposizioniequestegeneraliaspirai-
zioni.fuil contediCavour.Cavour,primadi
essereunostatista,erailnobilededitoalmiglio-
ramentodelleculturedellesueterre, lostudioso
e l'ammiratoredellateoriaedella,praticaeco-
nomicainglesedelsuotempo,unotra i fonda-
toridell'AssociazioneAgrariaSubalpina(1842),
delBancodiGenova(1844)edellaBancadiTo-
rino(1847). Inunsuoscrittodeldicembre1847,
lainterdipendenzatra libertàpoliticheepro-
gressoeconomicoèaffermatacon lamassima
chiarezza,:«Lecondizionieconomichedi un
popolosonofavorevoliquant'èpossibile,sem-
preehèil motoprogressivosi operi inmodo
ordinato.Tuttavial'industriaperisvolgersie
prosperareabbisognaasegnotaledi libertà,che
nondubitiamoaffermareesserei suoiprogressi
piùuniversaliepiùrapidiinunoStato,inquieto
sì,madolatodisodalibertà,cheinunotranquilo
maviventesotto ilpesodiunsistema,dicom-
pressioneediregresso(...)Pienamenteconvinti
diquesteverità,proclamiamoconfranchezzaes-
sereil risorgimentopoliticoitaliano (...)segno
indubitabilediun'eranovelaperl'industriae il
commerciodelanostraPatria»(2).
Il regimeliberalemoderato,istauratodalla
Costituzione&berlinaeradunquespecienelo
(2)
Scritti, cit.,
pag. 2. E in unbrindisi al banchettodei
commercianti,dopoavereinneggiatoalperfezionamentotecnico
dell'industriae allaemulazionetra levarieclassiproduttrici
—le quali(4tutteconferisconoegualmenteal pubblicobenes-
sere,dall'agricoltorechecrea lamateriaprima, al fabbricante
cheneaccresce il valore (...), al commerciantechetraendo i
prodottida lontanipaesi fra noi li dispensainmodoa tutti
facilmenteacoessibile — esclamava: t,
Abbiano
(le attività
produttrici) tuttenuovistimoli,nuovavita daquellospirito
diriformae dipropressoche,benedettodaPio,promossoda
CarloAlberto,animaespronaogniclassedi cittadini».
















