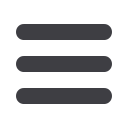
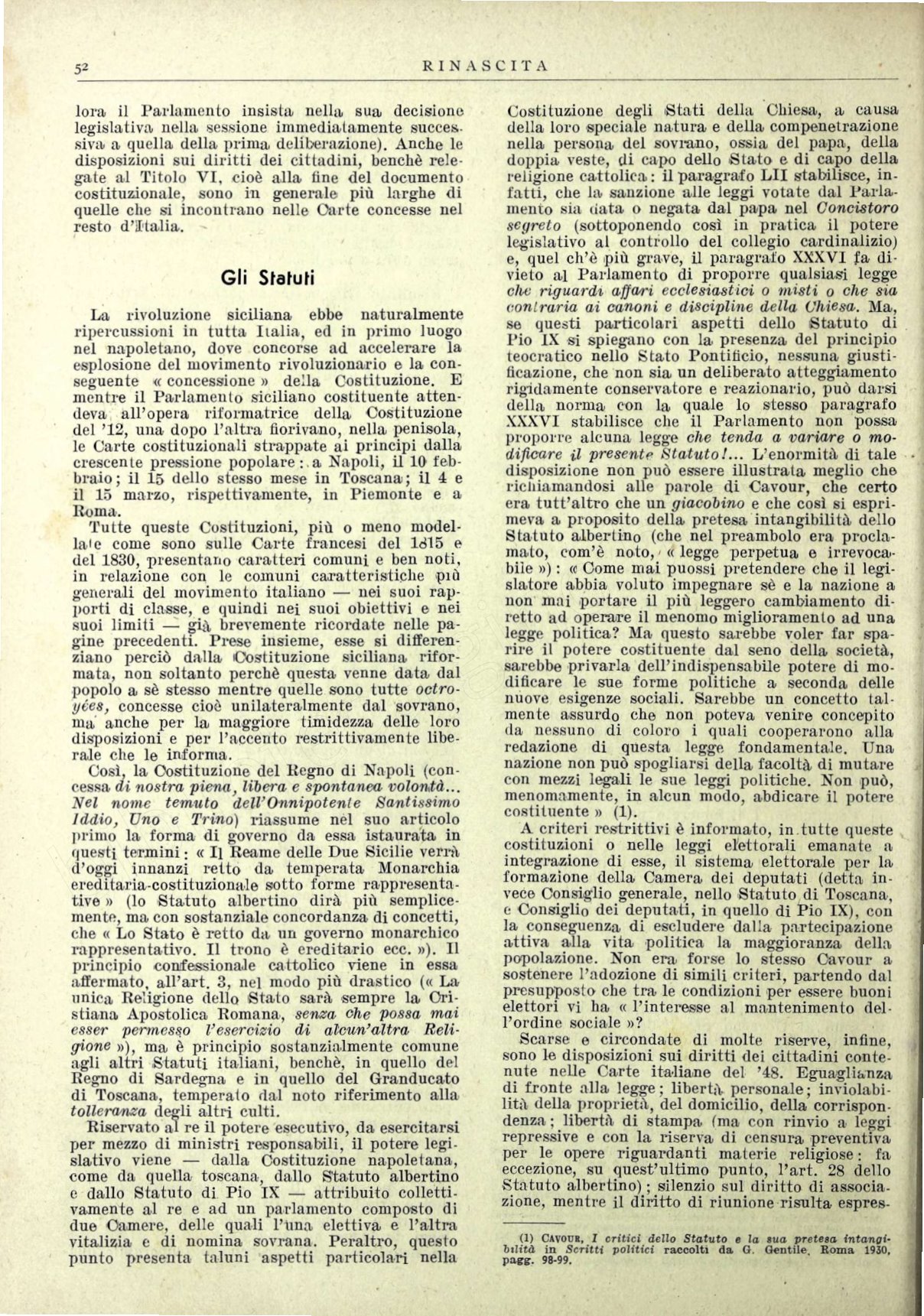
52
R I
N A S C I
T A
lora il Parlamentoinsistanellasuadecisione
legislativanellasessioneimmediatamentesucces-
sivaaqueladellaprimadeliberazione).Anchele
disposizionisui diritti dei cittadini,benchèrele-
gateal Titolo
VI, cioè
alla finedeldocumento
costituzionale,sono in generalepiù larghe di
quelechesi incontranonelleCarteconcessenel
restod'Italia,.
GliStatuti
Larivoluzionesicilianaebbenaturalmente
ripercussioni in tutta Italia, ed in primoluogo
nelnapoletano,doveconcorseadaccelerare la
esplosionedelmovimentorivoluzionarioe lacon-
seguente«concessione»dellaCostituzione. E
mentre il Parlamentosicilianocostituenteatten-
devaall'opera riformatrice dellaCostituzione
del'12,unadopol'altra fiorivano,nelapenisola,
leCartecostituzionalistrappateai principidalla
crescentepressionepopolare a Napoli, il 10,feb-
braio; il 15dellostessomeseinToscana; il 4e
il 15marzo,rispettivamente, inPiemontee a
Roma.TuttequesteCostituzioni, più omenomodel-
lalecomesonosulleCartefrancesi del1815e
del1830,presentanocaratteri
C0131131
ebennoti,
inrelazionecon le comunicaratteristichepiù
generalidelmovimentoitaliano—neisuoirap-
porti di classe,equindi neisuoiobiettivi enei
suoi limiti—già,brevementericordatenellepa-
gineprecedenti.Preseinsieme,essesi differen-
zianoperciòdalla'Costituzionesiciliana rifor-
mata,nonsoltantoperchèquestavennedatadal
popoloasèstesso
mentre
quelesonotutte
octro-
yées,
concessecioèunilateralmentedalsovrano,
ma:ancheper lamaggioretimidezzadelle loro
disposizionieperl'accentorestrittivamentelibe-
ralechele informa.
Così,laCostituzionedelRegnodiNapoli(con-
cessadinostrapiena,libera,espontaneavolontà...
Nelnometemutodel'OnnipotenteSantissimo
Iddio,Uno
e
Trino)
riassumenel suoarticolo
primola formadigovernodaessaistaurata in
quesititermini ((l i ReamedeleDueSicilieverrà,
d'oggiinnanzi retto da temperataMonarchia
ereditaria-costituzionalesottoformerappresenta-
tive» (lo Statutoalbertinodirà, piùsemplice-
mente,maconsostanzialeconcordanzadiconcetti,
che«LoStatoèrettoda,ungovernomonarchico
rappresentativo.
Il
tronoèereditarioecc.»).
Il
principioconfessionalecattolicoviene in essa
affermato,all'art. 3,nelmodopiùdrastico(«La
unicaReligionedelloStatosaràsemprela Cri-
stianaApostolicaRomana,
senzachepossamai
esserpermessol'esercizio di alcun'altraReli-
gione»),ma
èprincipiosostanzialmentecomune
agli altri 'Statuti italiani,benchè, in quellodel
RegnodiSardegnae in quellodelGranducato
diToscana,temperatodalnotoriferimentoalla
tolleranza
degli altri culti.
Riservatoalre il potereesecutivo,daesercitarsi
permezzodi ministri responsabili, il poterelegi-
slativoviene—dallaCostituzionenapoletana,
comedaquellatoscana,dalloStatutoalbertino
edalloStatuto di Pio IX—attribuitocolletti-
vamenteal reeadunparlamentocompostodi
dueCamere,dellequali l'unaelettivae l'altra
vitaliziae di nominasovrana.Peraltro,questo
puntopresentataluni aspetti particolari nella
Costituzionedegli Stati dellaChiesa, a causa
delaloro'specialenaturaedellacompenetrazione
nelapersonadelsovrano,ossiadelpapa,della
doppiaveste, dicapodelloStatoedicapodella
religionecattolica: il paragrafoLII stabilisce, in-
fatti,chelasanzionealleleggivotatedalParla-
mentosiadataonegatadalpapa
nel
Concistoro
segreto
(sotoponendocosì in pratica il potere
legislativoal controllodelcolegiocardinalizio)
e,quelch'èpiùgrave, il paragrafoX.XXVIfadi-
vietoal Parlamentodi proporrequalsiasilegge
cheriguardia,ffariecclesiasticiomisti ochesia
contrariaaicanoniedisciplinedellaChiesa,.Ma,
sequesti particolari aspetti delloStatuto di
PioIX sispieganocon lapresenzadelprincipio
teocraticonelloStatoPontificio,nessunagiusti-
ficazione,chenonsiaundeliberatoatteggiamento
rigidamenteconservatoreereazionario,puòdarsi
delanormacon la quale lo stessoparagrafo
XXXVIstabilisceche il Parlamentononpossa
proporrealcunaleggechetendaavariareomo-
dificare ilpresentestatuto!...L'enormitàdi tale
disposizionenonpuòessereillustratameglioche
richiamandosialleparole di Cavour,che
certo
eratutt'altrocheun
giacobino
echecosìsiespri-
mevaapropositodellapretesaintangibilitàdello
Statutoalbertino(chenelpreamboloeraprocla-
mato,com'ènoto,'«leggeperpetuaeirrevoca.-
bile»):
cc
Comemaipuossipretendereche il legi-
slatoreabbiavolutoimpegnaresèe lanazionea
nonmaiportare il piùleggerocambiamentodi-
rettoadoperare ilmenomomiglioramentoaduna
leggepolitica?Maquestosarebbevoler farspa-
rire il poterecostituentedalsenodellasocietà,
sarebbeprivarladel'indispensabilepoteredimo-
dificarelesueformepolitiche asecondadelle
nuoveesigenzesociali.Sarebbeunconcettotal-
menteassurdochenonpotevavenireconcepito
danessunodi coloro i qualicooperaronoalla
redazione di questa,leggefondamentale.Una
nazionenonpuòspogliarsidellafacoltàdimutare
conmezzilegali lesueleggipolitiche.Nonpuò,
menomamente,inalcunmodo,abdicare il potere
costituente»(1).
Acriteri restrittivièinformato, in .tuttequeste
costituzioni o nelle leggi elettoraliemanatea
integrazionediesse, il sistemaelettoraleper la
formazionedellaCameradeideputati (detta in-
veceConsigliogeneralenelloStatutodiToscana,
eConsigliodeideputati, inquellodiPioIX),con
laconseguenzadiescluderedallapartecipazione
attivaalla vita 'politica lamaggioranzadella
popolazione.Noneraforse lostessoCavour a
sostenerel'adozionedi simili criteri,partendodal
presuppostachetralecondizioniperesserebuoni
elettori vi ha,«l'interessealmantenimentodel-
l'ordinesociale»?
Scarseecircondate di molteriserve, infine,
sonoledisposizionisui diritti deicittadiniconte-
nutenelleCarte italianedel '48.Eguagliamza
di fronteallalegge;libertà_personale;inviolabi-
litàdelaproprietà,deldomicilio,dellacorrispon-
denza;libertà distampa,(maconrinvio a leggi
repressiveeconlariserva,dicensurapreventiva
per leopereriguardantimateriereligiose: fa
eccezione,suquest'ultimopunto, l'art. 28dello
Statutoalbertino);silenziosul diritto diassocia-
zione,mentre il diritto di riunionerisultaespres-
(1)CAVOUR,
I critici dello Statuto e la suapretesa
intangi-
bz/itd in Scritti
politici
raccolti da G. Gentile,Roma1930,
pagg.
98-99.
















