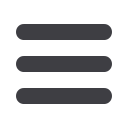
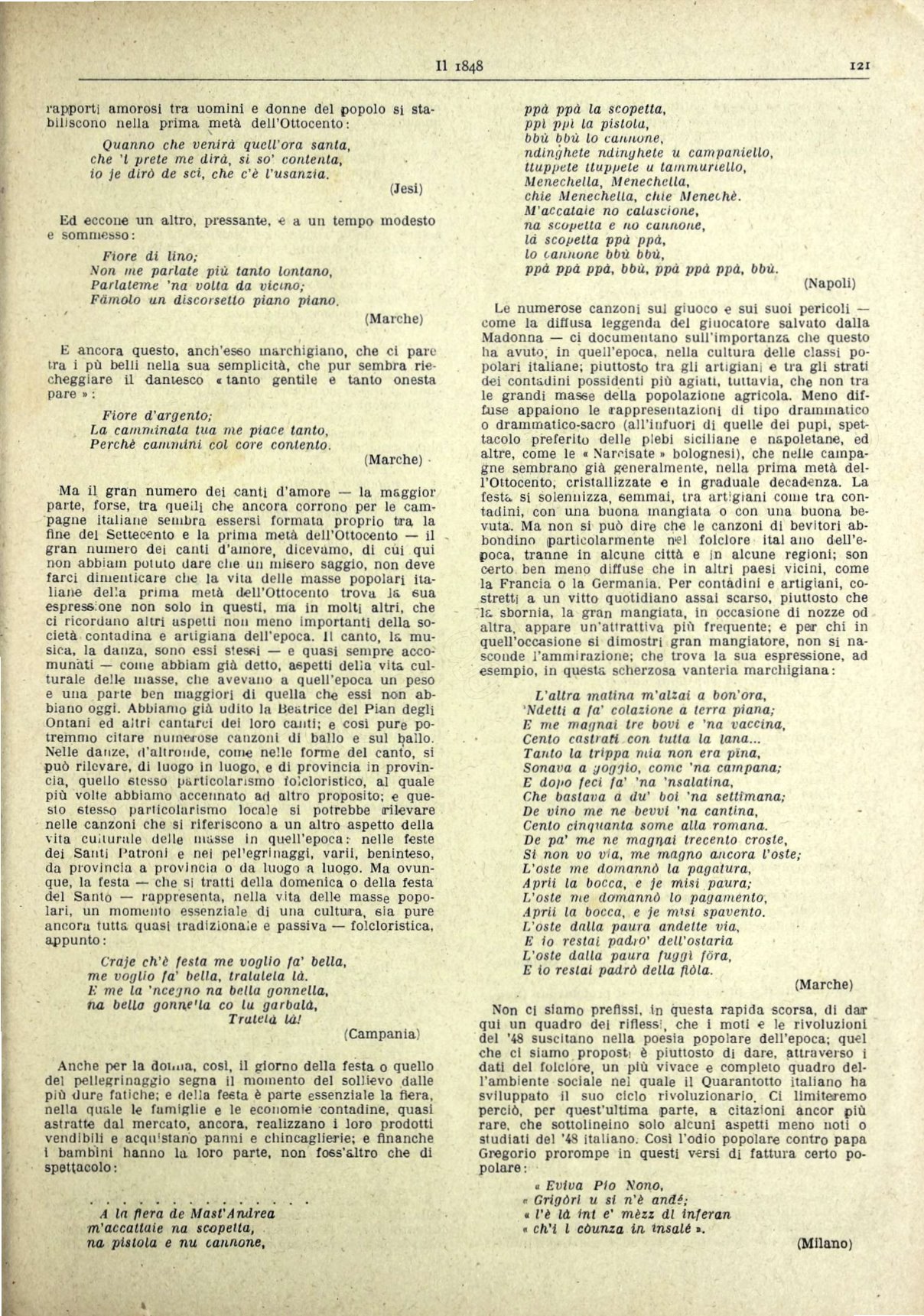
Il 1848
121
rapportiamorosi tra uomini edonnedel popoloSi sta-
biliscononella primametàdell'Ottocento:
Quannocheveniràquell'orasanta,
che't pretemedirà, si so' contenta,
io le diròdesci,chec'è l'usanzia.
(Jesi)
Edecconeun altro,pressante,.ea un tempomodesto
esommesso:
Fiore di lino;
Nonineparlate più tanto lontano,
Parlateine 'na voltadavicino;
Feinioloundiscorsettopianopiano.
(Marche)
Eancoraquesto,anch'essotnarchigiano, che ci pare
tra i pù belli nellasuasemplicità,chepursembrarie-
cheggiare i l dantesco « tantogentile e tanto onesta
pare»:
Fiored'argento;
Lacamminatatuamepiacetanto,
Perchècammini col corecontento.
(Marche)•
Ma il grannumerodei canti d'amore— lamaggior
parte, forse, tra quelli cheancoracorronoper lecam-
pagneitalianesembraessersi formata proprio tra la
finedeiSettecentoe la primametàdell'Ottocento— il
grannumerodei canti d'amore,dicevamo, di ciii qui
nonabbi= potutodarecheunmiserosaggio,nondeve
farci dimenticareche la vita dellemassepopolari ita-
liane della prima metàdell'Ottocento trova18. sua
espress:onenon solo in questi,ma in molti altri, che
ci ricordano altri aspetti nonmenoimportanti dellaso-
cietàcontadinaeartigianadell'epoca. Il canto, la mu-
sica, la danza,sonoessistessi—equasisempreacco-
munati—comeabbiamgiàdetto,aspetti della vita cul-
turaledellemasse,cheavevano a quell'epocaunpeso
euna partebenmaggiori di quella cheessi non ab-
bianooggi.Abbiamogiàudito laBeatricedelPiandegli
Ontanied altri cantarci dei loro canti; e cosìpurepo-
tremmocitarenumerosecanzoni di ballo e sul ballo.
Neledanze,d'altronde,comenelle formedel canto, si
puòrilevare, di luogo in luogo,edi provincia in provin-
cia,quellostessoparticolarismo folcloristico, al quale
piùvolteabbiamoaccennatoad altroproposito; eque-
stostessoparticolarismo locale si potrebbeallevare
nelecanzonichesi riferiscono a un altroaspettodella
vitacuiturale dellemasse in quell'epoca: nelle feste
deiSanti Patroni e nei pellegrinaggi, vani, beninteso,
daprovincia a provincia o da luogoa luogo.
Ma
ovun-
que, la festa—cheSi tratti delladomenicaodellafesta
delSanto—rappresenta, nella vita dellemassepopo-
lari, unmomenloessenziale di una cultura, sia pure
ancoratuttaquasi tradizionaleepassiva—folcloristica,
appunto:
Crajech'èfestamevoglio fa' bella,
mevoglio fa' bella, tratalela là.
Eme la 'ncegnonabellagonnella,
114bello
gonn,e'laco tu garbata,
Trateld ki!
(Campania)
Ancheper ladoboa,cosi, il giornodellafestaoquello
delpellegrinaggiosegna il momentodel sollievodalle
piùdurefatiche;edellafestaèparteessenziale la fiera,
nellaquale le famiglie e leeconomie'contadine,quasi
astrattedalmercato,ancora, realizzano i loro prodotti
vendibili eacqu;stanbpanni echincaglierie; e finanche
i bambini hanno la loro parte, non foss'altro che di
spettacolo:
Ala fieradeMast'Aruirea
m'accattaienascopetta,
napistolaenucannone,
ppàppà la scopata,
pptppi la pistola,
bbùbbù locannone,
ndinihetendinghete u campaniello,
ttuppetettuppeteu tainniuriello,
Menechela,Menechelta,
chieMenechela,chieMenechè.
lifaccataienocalascione,
nascopettaenocannone,
lascopettappàppà,
locannonebbù
ppàppàppà,bbù,ppàppappà,bbù.
(Napoli)
Lenumerosecanzoni sul giuocoesui suoi pericoli—
comela diffusa leggendadel giuocatoresalvato dalla
Madonna—ci documentanosull'importanzachequesto
haavuto, in quell'epoca, nella cultura delleclassi po-
polari italiane; piuttosto tra gli artigiani e tra gli strati
deicontadinipossidenti più agiati, tuttavia,chenon tra
legrandimassedellapopolazioneagricola.Meno dif-
fuseappaiono le trappresentazioni di tipo drammatico
odrammatico-sacro(all'infuori di quelledei pupi, spet-
tacolopreferito delle plebi siciliane e napoletane, ed
altre,come le«Nareisate»bolognesi),chenellecampa-
gnesembranogiàgeneralmente,nella primametàdel-
l'Ottocento,cristallizzate e in gradualedecadenza. La
festasi solennizza,semmai, tra aftgiani cometra con-
tadini, conunabuonamangiata o conunabuonabe-
vuta.Manon si puòdireche lecanzoni di bevitori ab-
bondinoparticolarmente nel folclore ital anodell'e-
poca,tranne in alcune città e in alcune regioni; son
certobenmenodiffuseche in altri paesi vicini, come
laFranciao laGermania.Per contadini eartigiani, co-
stretti a un vitto quotidianoassaiscarso,piuttostoche
-l&sbornia, la granmangiata, inoccasionedi nozzeod
altra,appareun'attrattiva più frequente; epeci' chi in
quel'occasionesi dimostri granmangiatore,nonSi na-
scondel'ammirazione;che trova la suaespressione,ad
esempio, inquestascherzosavanteriamarchigiana:
L'altramatinam'alzai abon'ora,
'Ndetti a fa' colazionea terrapiana;
Emernagnai tre bovi e 'na vaccina,
Centocastrati con tutta la lana_
Tanto la trippamianonerapina,
Sonavaagoggio,come'nacampana;
Edopofeci fa' na insalatina,
Chebastavaa du' boi 'na settimana;
Devinomenebevvi 'na cantina,
Centocinquantasomealla romana.
Depa'menemagnai trecentocroste,
Sinonvo via,memagnoancoral'oste;
L'ostemedornannò la pagatura,
Aprii la bocca, e le misi paura;
L'ostemedom_annò lo pagamento,
Aprii labocca, e le misi spavento.
L'ostedalla pauraandettevia,
Eio restai padro' dell'ostaria
L'ostedallapaura fuggi fóra,
Eio restaipadròdella fiòla.
(Marche)
Nonci siamoprefissi, inquestarapidascorsa, di dar
qui unquadrodei riflessi, che i moti e le rivoluzioni
del'48suscitanonellapoesiapopolaredell'epoca; quel
checi siamopropostd è piuttosto di dare, attraverso i
dati del folclore, un più vivaceecompletoquadrodel-
l'ambientesocialenel quale il Quarantotto italiano ha
sviluppato i l suo ciclo rivoluzionarlo, Ci limiteremo
perciò, per quest'ultima parte, a citazioni ancor più
rare,chesottolineinosolo alcuni aspettimenonoti o
studiatidel '48italiano.Così l'odiopopolarecontropapa
Gregorioprorompe in questi versi di fattura certopo-
polare:
«EvivaPioNono,
Grigòri u si n'èandts;
« l'è la int e'mèzzdl inferan
ch'i I còunzain lnsalé
(Milano)
















