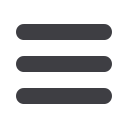
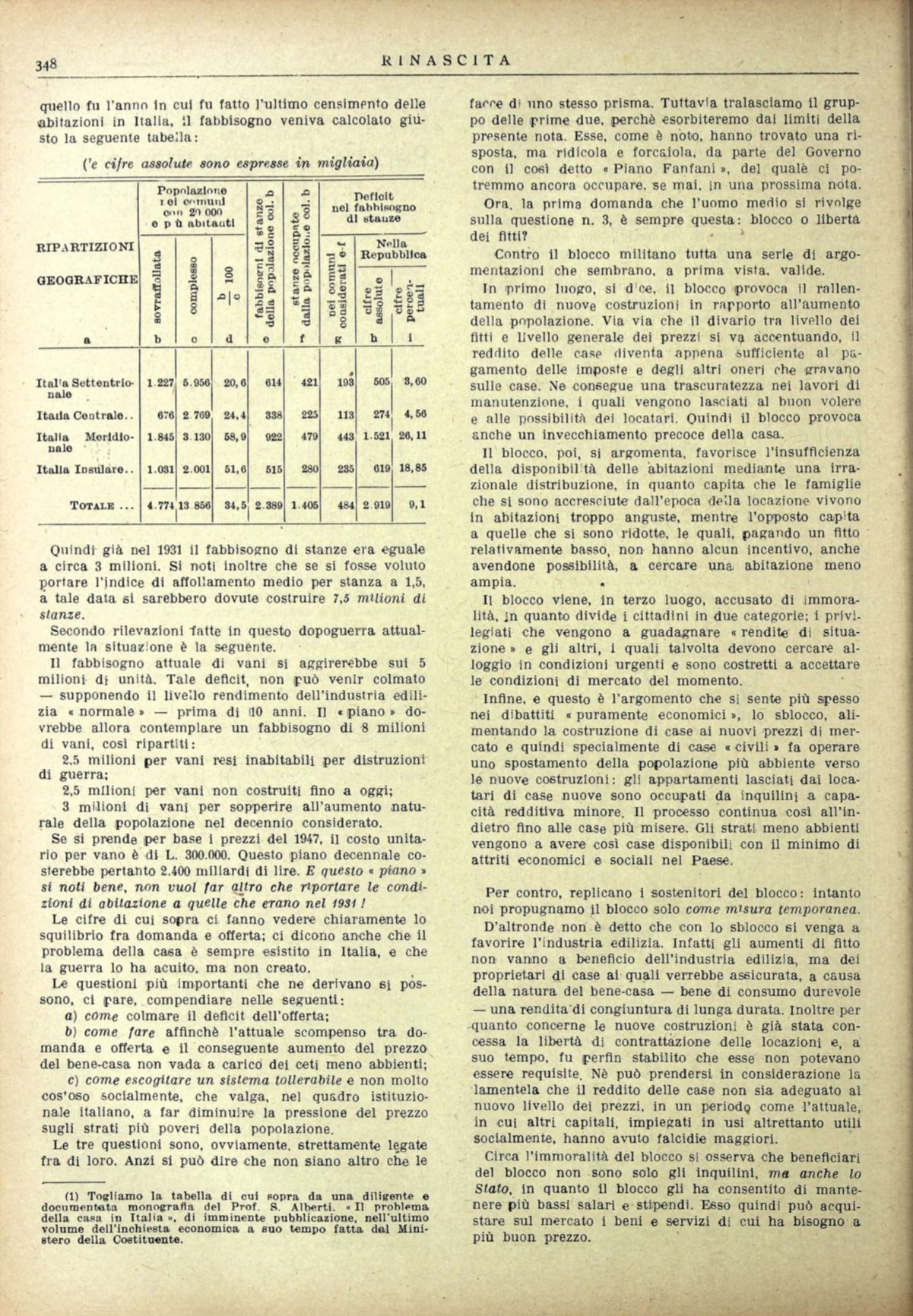
348
RIPARTIZIONT
GEOGRAFICHE
a
POPni aZinne
felcomuni
con20000
ep tt abitatiti
•Ci
c.)•
2-3.
Cd
re2,91.2
._,3
b2a
,22.'
:=1
.0 CI3
:20
nd
A2
,-à.
2.
0,41
ti ,
rdg
InF-.1
.%a.
+.
,02
§
Ti
f
Deficit
nelfabbisogno dlstauze
03
4.2
ce
75
e
o
M
b
O
2
.7.c-'
p
g
o
2
Pio
d e
,-,
7o
54cA
SO
rCS
.-.-4 )
o d
8
g
Nella Repubblica
o
r.. •
:tig
••.0
2
b i t
I
L. 41) qg
igie
rtalTaSettentrio-
nale .
ItailaCentrale..
EtaliaMeridlo-
nale
Italia Insulare..
TOTALE . . .
1.227
676
1.845
1.031
6.956
2769
3.130
2.001
20,6
24,4
58,9
61,6
014
338
922
515
421
225
479
280
,
193
13
443
235
505
274
1.521
019
3,00
4,56
26,11
18,86
4.77413866 34,6 2.389
1.405
484 2.919 9,1
R I N A S C I T A
.1•1•.••••
•
quello fu l'anno in cui fu fatto l'ultimo censimento delle
abitazioni in Italia, i l fabbisogno veniva calcolato giù-
sto la seguente tabella:
recifreassolutesonoespressein migliaia)
Quindi già nel 1931 i l fabbisogno di stanze era eguale
a
circa
3 milioni. Si noti inoltre che se si fosse voluto
portare l'Indice di affollamento medio per stanza a 1,5,
a. tale data si sarebbero dovute costruire 7,5
milioni di
stanze.
Secondo rilevazioni latte in questo dopoguerra attual-
mente la situazione è la seguente.
Il
fabbisogno attuale d i vani Si aggirerebbe sui 5
milioni d i unità. Tale deficit, non può venir colmato
—supponendo i l livello rendimento dell'industria edili-
zia « normale» — prima di
110
anni. I l « piano» do-
vrebbe allora contemplare
un
fabbisogno di 8 milioni
di vani, così ripartiti:
2,5milioni per vani resi inabitabili per distruzioni
di guerra;
2,5milioni per vani non costruiti fino a
oggi;
3milioni di vani per sopperire all'aumento natu-
rale della popolazione nel decennio considerato.
Sesi prende per base i prezzi del 1947, i l costo unita-
rio per vano è di L. 300.000.Questo piano decennale co-
sterebbe pertanto2.400miliardi di lire. E
questa
«
piano
»
sinotibene,nonvuoi far altrocheriportare lecondi-
zioni di abitazioneaquelecheeranonel1931!
Le cifre di cui sopra ci fanno vedere chiaramente lo
squilibrio fra domanda e offerta; ci dicano anche che il
problema della casa è sempre esistito in Italia, e che
la guerra lo ha acuito, ma non creato.
Lequestioni più importanti che ne derivano si pos-
sono, r a r e , compendiare nelle seguenti:
a)
carne
colmare i l deficit dell'offerta;
b)come fare
affinchè l'attuale scompenso t ra do-
manda e offerta e i l conseguente aumento del prezzo
del bene-casa non vada a carico dei ceti meno abbienti;
c)comeescogitareunsistematollerabileenonmolto
costoso socialmente, che valga, nel quadro istituzio-
nale italiano, a far diminuire la pressione del prezzo
sugli strati più poveri della popolazione.
Le tre questioni sono, ovviamente, strettamente legate
fra di loro. Anzi si può dire che non siano altro che le
(1)Togliamo la tabella di cui eopra da unadiligente e
documentatamonografiadel Prof. S. Alberti. « Jproblema
dellacasa in Italia », di imminentepubblicazione,nell'ultimo
volumedell'inchiestaeconomica a suotempo fatta dal Mini-
sterodellaCostituente.
facre di uno stesso prisma. Tuttavia tralasciamo i l grup-
podelle prime due, perchè esorbiteremo dai limiti della
presente nota. Esse, come è nat,o, hanno trovato una ri-
sposta, ma ridicola e forcaiola, da parte del Governo
con i l
Così
detto « Piano Fanfani », del quale ci po-
tremmo ancora occupare. se mai, in una prossima nota.
Ora, la prima domanda che l'uomo medio si rivolge
sulla questione n. 3, è sempre questa: blocco o libertà
dei fitti?
Contro i l blocco militano tutta una serie di argo-
mentazioni che sembrano, a prima vista, valide.
In primo luogo, si d'ce, i l blocco provoca
i l
rallen-
tamento di nuove costruzioni i n rapporto all'aumento
della popolazione. Via via che i l divario tra livello dei
fitti e livello generale dei prezzi si va accentuando, i l
reddito delle
case
diventa appena sufficiente a l pa-
gamento delle imposte e degli altri oneri che .gravano
sulle case. Ne consegue una trascuratezza nei lavori di
manutenzione, i quali vengono lasciati al buon volere
ealle possibilità dei locatari. Quindi i l blocco provoca
anche un invecchiamento precoce della casa.
Il blocco, poi, si argomenta, favorisce l'insufficienza
della disponibilità delle 'abitazioni mediante una irra-
zionale distribuzione, in quanto capita che le famiglie
che si sono accresciute dall'epoca della locazione vivono
in abitazioni troppo anguste, mentre l'opposto capita
aquelle che si sono ridotte, le quali, pagando un fitto •
relativamente basso, non hanno alcun incentivo, anche
avendone possibilità, a
cercare una,
abitazione meno
ampia.
Il blocco viene, i n terzo luogo, accusato di •immora-
lità, jn quanto divide i cittadini in due categorie; i privi-
legiati che vengono a guadagnare « rendite d i situa-
zione» e gl i altri, i quali talvolta devano cercare al-
loggio in condizioni urgenti e sono costretti a accettare
le condizioni di mercato del momento.
Infine, e questo è l'argomento che si sente più spesso
nei dibattiti puramente economici », l o sblocco, al i-
mentando la costruzione di case ai nuovi prezzi di mer-
cato e quindi specialmente di case « civili » fa operare
uno spostamento della popolazione più abbiente verso
le nuove costruzioni: gl i appartamenti lasciati dai loca-
tari di case nuove sono occupati da inquilini a capa-
cità redditiva minore. I l processo "continua così all'in-
dietro fino alle case più misere. Gli strati meno abbienti
vengono a avere così case disponibili con i l minimo di
attriti economici e sociali nel Paese.
Per contro, replicano i sostenitori del blocco: intanto
noi propugnamo i l blocco solo
come misura temporanea.
D'altronde non è detto che con Io sblocco si venga a
favorire l'industria edilizia. Infatti gl i aumenti di fitto
non vanno a beneficio dell'industria edilizia, ma dei
proprietari di case ai quali verrebbe assicurata, a causa
della natura del bene-casa—bene di consumo durevole
una rendita'di congiuntura di lunga durata. Inoltre per
-quanto concerne le nuove costruzioni è già stata con-
cessa la libertà di contrattazione delle locazioni e, a
suo tempo, f u perfin stabilito che esse non potevano
essere requisite. Nè può prendersi in considerazione la
lamentela che i l reddito delle case non sia adeguato al
nuovo livello dei prezzi, in un periodQ come l'attuale,
in .cui al tr i capitali, impiegati i n usi altrettanto ut i l i
socialmente, hanno avuto falcidie maggiori.
Circa l'immoralità del bloccoSi osserva che beneficiari
del blocco non -sono solo gl i inquilini, ma
anche l o
Stato,
in quanto i l blocco gl i ha consentito di mante-
nere più bassi salari e stipendi. Esso quindi può acqui-
stare sul mercato i beni e servizi di cui ha bisogno a
più buon prezzo.
















