
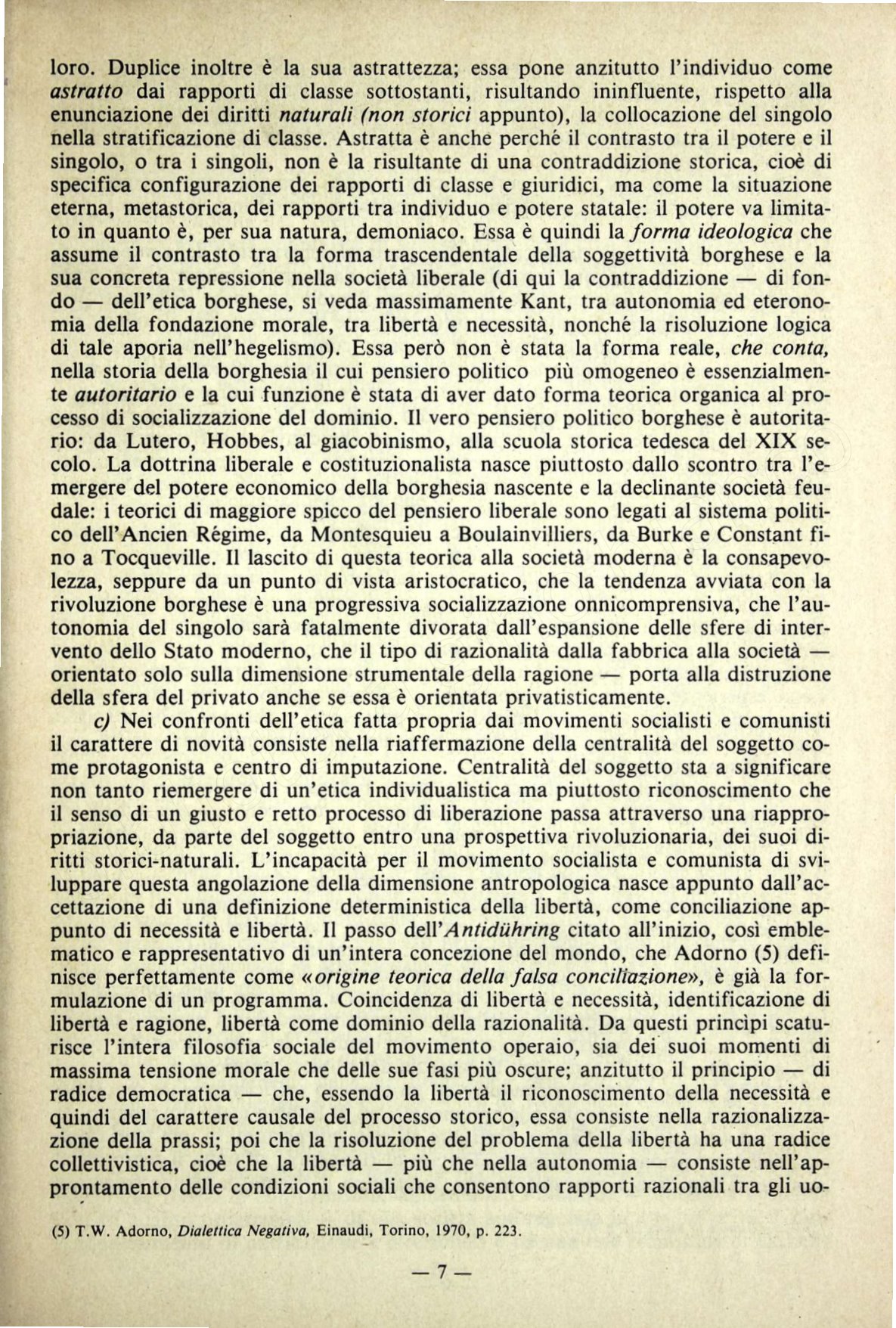
loro. Duplice inoltre è la sua astrattezza; essa pone anzitutto l'individuo come
astratto
dai rapporti di classe sottostanti, risultando ininfluente, rispetto alla
enunciazione dei diritti
naturali (non storici
appunto), la collocazione del singolo
nella stratificazione di classe. Astratta è anche perché il contrasto tra il potere e il
singolo, o tra i singoli, non è la risultante di una contraddizione storica, cioè di
specifica configurazione dei rapporti di classe e giuridici, ma come la situazione
eterna, metastorica, dei rapporti tra individuo e potere statale: il potere va limita-
to in quanto è, per sua natura, demoniaco. Essa è quindi la
forma ideologica
che
assume i l contrasto tra la forma trascendentale della soggettività borghese e la
suaconcreta repressione nella società liberale (di qui la contraddizione — di fon-
do — dell'etica borghese, si vedamassimamente Kant, tra autonomia ed eterono-
mia della fondazione morale, tra libertà e necessità, nonché la risoluzione logica
di tale aporia nell'hegelismo). Essa però non è stata la forma reale,
che conta,
nella storia della borghesia il cui pensiero politico più omogeneo è essenzialmen-
te
autoritario
e
la
cui funzione è stata di aver dato forma teorica organica al pro-
cessodi socializzazione del dominio. I l vero pensiero politico borghese è autorita-
rio: da Lutero, Hobbes, al giacobinismo, alla scuola storica tedesca del XIX se-
colo. La dottrina liberale e costituzionalista nasce piuttosto dallo scontro tra l'e-
mergere del potere economico della borghesia nascente e la declinante società feu-
dale: i teorici di maggiore spicco del pensiero liberale sono legati al sistema politi-
co dell'Ancien Régime, da Montesquieu a Boulainvilliers, da Burke e Constant fi-
no a Tocqueville. I l lascito di questa teorica alla società moderna è la consapevo-
lezza, seppure da un punto di vista aristocratico, che la tendenza avviata con la
rivoluzione borghese è una progressiva socializzazione onnicomprensiva, che l'au-
tonomia del singolo sarà fatalmente divorata dall'espansione delle sfere di inter-
vento dello Stato moderno, che il tipo di razionalità dalla fabbrica alla società
orientato solo sulla dimensione strumentale della ragione — porta alla distruzione
della sfera del privato anche seessa è orientata privatisticamente.
c)
Nei confronti dell'etica fatta propria dai movimenti socialisti e comunisti
il carattere di novità consiste nella riaffermazione della centralità del soggetto co-
meprotagonista e centro di imputazione. Centralità del soggetto sta a significare
non tanto riemergere di un'etica individualistica ma piuttosto riconoscimento che
il senso di un giusto e retto processo di liberazione passa attraverso una riappro-
priazione, da parte del soggetto entro una prospettiva rivoluzionaria, dei suoi di-
ritti storici-naturali. L'incapacità per il movimento socialista e comunista di svi-
luppare questa angolazione della dimensione antropologica nasce appunto dall'ac-
cettazione di una definizione deterministica della libertà, come conciliazione ap-
punto di necessità e libertà. I l passo dell'A
ntidiihring
citato all'inizio, così emble-
matico e rappresentativo di un'intera concezione del mondo, che Adorno (5) defi-
nisce perfettamente come «origine teorica della falsa conciliazione», è già la for-
mulazione di un programma. Coincidenza di libertà e necessità, identificazione di
libertà e ragione, libertà come dominio della razionalità. Da questi principi scatu-
risce l'intera filosofia sociale del movimento operaio, sia dei suoi momenti di
massima tensione morale che delle sue fasi più oscure; anzitutto il principio — di
radice democratica — che, essendo la libertà il riconoscimento della necessità e
quindi del carattere causale del processo storico, essa consiste nella razionalizza-
zione della prassi; poi che la risoluzione del problema della libertà ha una radice
collettivistica, cioè che la libertà — più che nella autonomia — consiste nell'ap-
prontamento delle condizioni sociali che consentono rapporti razionali tra gli uo-
(5) T.W. Adorno,
Dialettica Negativa,
Einaudi, Torino, 1970, p. 223.
7
















