
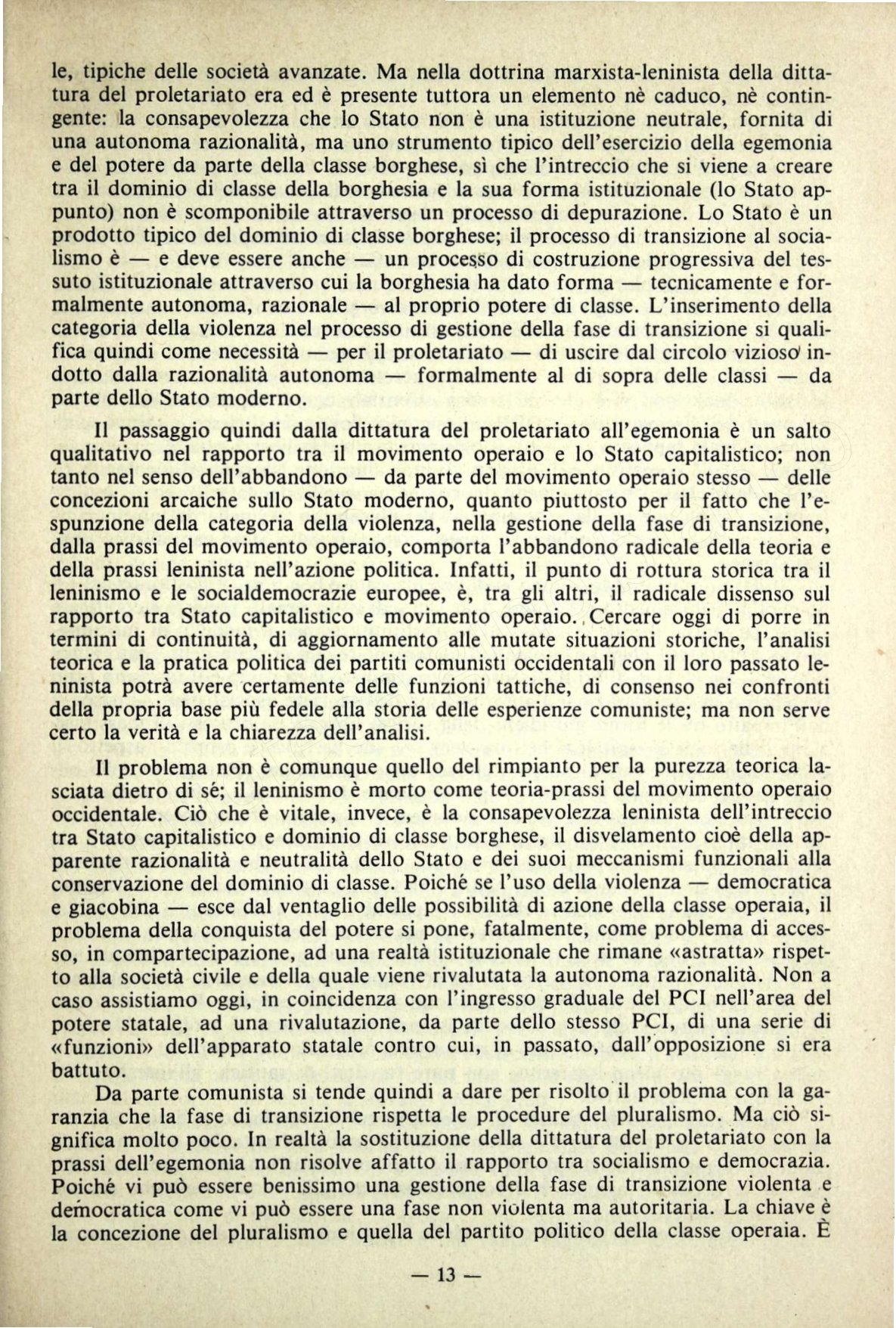
le, tipiche delle società avanzate. Ma nella dottrina marxista-leninista della ditta-
tura del proletariato era ed è presente tuttora un elemento nè caduco, nè contin-
gente: la consapevolezza che lo Stato non è una istituzione neutrale, fornita di
una autonoma razionalità, ma uno strumento tipico dell'esercizio della egemonia
edel potere da parte della classe borghese, sì che l'intreccio che si viene a creare
tra il dominio di classe della borghesia e la sua forma istituzionale (lo Stato ap-
punto) non è scomponibile attraverso un processo di depurazione. Lo Stato è un
prodotto tipico del dominio di classe borghese; il processo di transizione al socia-
lismo è — e deve essere anche — un processo di costruzione progressiva del tes-
suto istituzionale attraverso cui la borghesia ha dato forma — tecnicamente e for-
malmente autonoma, razionale — al proprio potere di classe. L'inserimento della
categoria della violenza nel processo di gestione della fase di transizione si quali-
fica quindi come necessità — per il proletariato — di uscire dal circolo viziosd in-
dotto dalla razionalità autonoma formalmente al di sopra delle classi — da
parte dello Stato moderno.
Il passaggio quindi dalla dittatura del proletariato all'egemonia è un salto
qualitativo nel rapporto tra il movimento operaio e lo Stato capitalistico; non
tanto nel senso dell'abbandono — da parte del movimento operaio stesso — delle
concezioni arcaiche sullo Stato moderno, quanto piuttosto per il fatto che l'e-
spunzione della categoria della violenza, nella gestione della fase di transizione,
dalla prassi del movimento operaio, comporta l'abbandono radicale della teoria e
della prassi leninista nell'azione politica. Infatti, il punto di rottura storica tra il
leninismo e le socialdemocrazie europee, è, tra gli altri, i l radicale dissenso sul
rapporto tra Stato capitalistico e movimento operaio., Cercare oggi di porre in
termini di continuità, di aggiornamento alle mutate situazioni storiche, l'analisi
teorica e la pratica politica dei partiti comunisti occidentali con il loro passato le-
ninista potrà avere certamente delle funzioni tattiche, di consenso nei confronti
della propria base più fedele alla storia delle esperienze comuniste; ma non serve
certo la verità e la chiarezza dell'analisi.
Il problema non è comunque quello del rimpianto per la purezza teorica la-
sciata dietro di sé; il leninismo è morto come teoria-prassi del movimento operaio
occidentale. Ciò che è vitale, invece, è la consapevolezza leninista dell'intreccio
tra Stato capitalistico e dominio di classe borghese, il disvelamento cioè della ap-
parente razionalità e neutralità dello Stato e dei suoi meccanismi funzionali alla
conservazione del dominio di classe. Poiché se l'uso della violenza — democratica
egiacobina — esce dal ventaglio delle possibilità di azione della classe operaia, il
problema della conquista del potere si pone, fatalmente, come problema di acces-
so, in compartecipazione, ad una realtà istituzionale che rimane «astratta» rispet-
to alla società civile e della quale viene rivalutata la autonoma razionalità. Non a
casoassistiamo oggi, in coincidenza con l'ingresso graduale del PCI nell'area del
potere statale, ad una rivalutazione, da parte dello stesso PCI, di una serie di
«funzioni» dell'apparato statale contro cui, in passato, dall'opposizione si era
battuto.
Da parte comunista si tende quindi a dare per risolto il problema con la ga-
ranzia che la fase di transizione rispetta le procedure del pluralismo. Ma ciò si-
gnifica molto poco. In realtà la sostituzione della dittatura del proletariato con la
prassi dell'egemonia non risolve affatto il rapporto tra socialismo e democrazia.
Poiché vi può essere benissimo una gestione della fase di transizione violenta e
deínocratica come vi può essere una fase non violenta ma autoritaria. La chiave è
la concezione del pluralismo e quella del partito politico della classe operaia. È
- 13 -
















