
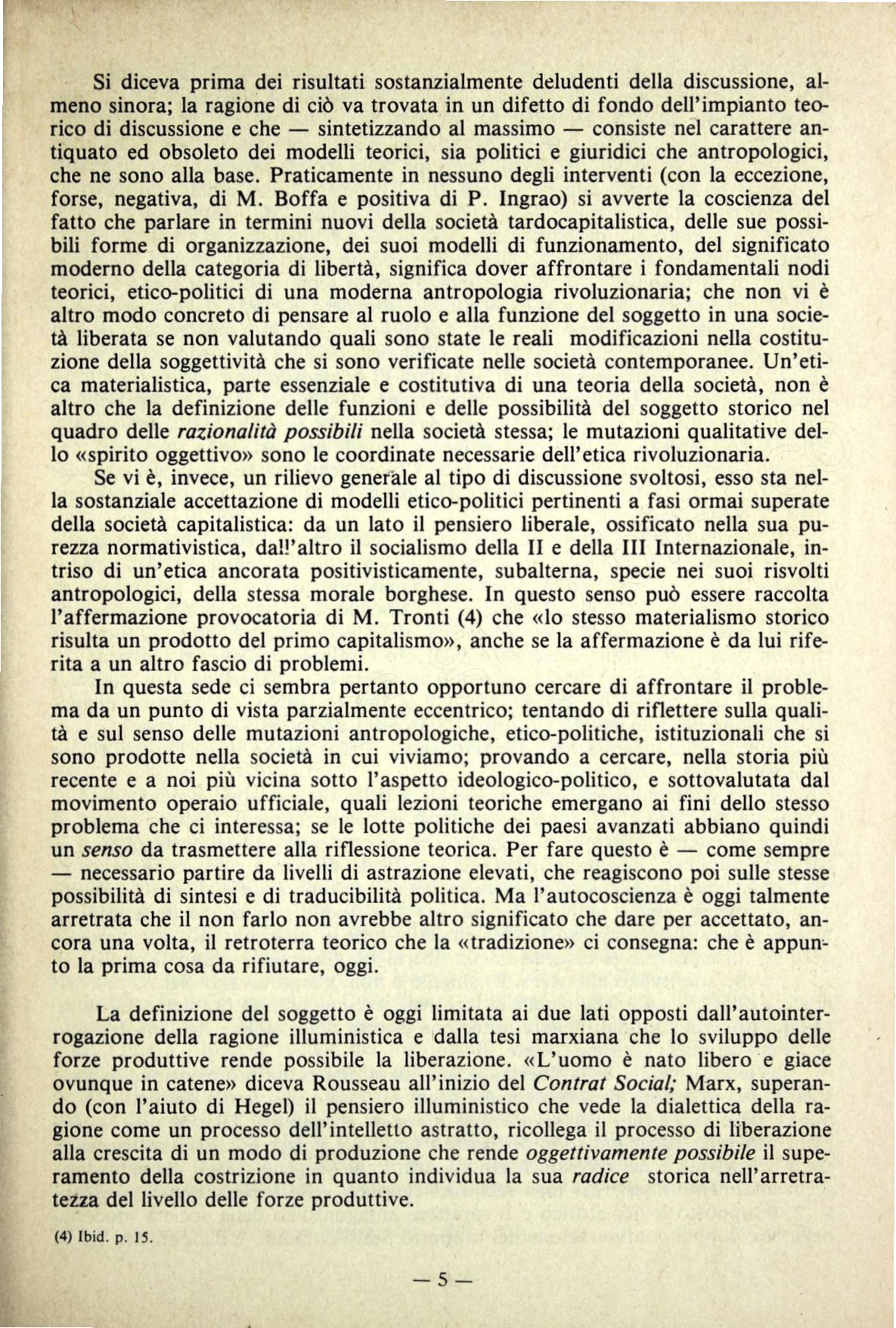
Si diceva prima dei risultati sostanzialmente deludenti della discussione, al-
meno sinora; la ragione di ciò va trovata in un difetto di fondo dell'impianto teo-
rico di discussione e che — sintetizzando al massimo — consiste nel carattere an-
tiquato ed obsoleto dei modelli teorici, sia politici e giuridici che antropologici,
che ne sono alla base. Praticamente in nessuno degli interventi (con la eccezione,
forse, negativa, di M. Boffa e positiva di P. Ingrao) si avverte la coscienza del
fatto che parlare in termini nuovi della società tardocapitalistica, delle sue possi-
bili forme di organizzazione, dei suoi modelli di funzionamento, del significato
moderno della categoria di libertà, significa dover affrontare i fondamentali nodi
teorici, etico-politici di una moderna antropologia rivoluzionaria; che non vi è
altro modo concreto di pensare al ruolo e alla funzione del soggetto in una socie-
tà liberata se non valutando quali sono state le reali modificazioni nella costitu-
zione della soggettività che si sono verificate nelle società contemporanee. Un'eti-
camaterialistica, parte essenziale e costitutiva di una teoria della società, non è
altro che la definizione delle funzioni e delle possibilità del soggetto storico nel
quadro delle
razionalità possibili
nella società stessa; le mutazioni qualitative del-
lo «spirito oggettivo» sono le coordinate necessarie dell'etica rivoluzionaria.
Sevi è, invece, un rilievo generale al tipo di discussione svoltosi, esso sta nel-
la sostanziale accettazione di modelli etico-politici pertinenti a fasi ormai superate
della società capitalistica: da un lato il pensiero liberale, ossificato nella sua pu-
rezza normativistica, dall'altro il socialismo della I I e della I I I Internazionale, in-
triso di un'etica ancorata positivisticamente, subalterna, specie nei suoi risvolti
antropologici, della stessa morale borghese. In questo senso può essere raccolta
l'affermazione provocatoria di M. Tronti (4) che «lo stessomaterialismo storico
risulta un prodotto del primo capitalismo», anche se la affermazione è da lui rife-
rita a un altro fascio di problemi.
In questa sede ci sembra pertanto opportuno cercare di affrontare il proble-
ma da un punto di vista parzialmente eccentrico; tentando di riflettere sulla quali-
tà e sul senso delle mutazioni antropologiche, etico-politiche, istituzionali che si
sono prodotte nella società in cui viviamo; provando a cercare, nella storia più
recente e a noi più vicina sotto l'aspetto ideologico-politico, e sottovalutata dal
movimento operaio ufficiale, quali lezioni teoriche emergano ai fini dello stesso
problema che ci interessa; se le lotte politiche dei paesi avanzati abbiano quindi
un
senso
da trasmettere alla riflessione teorica. Per fare questo è — come sempre
necessario partire da livelli di astrazione elevati, che reagiscono poi sulle stesse
possibilità di sintesi e di traducibilità politica. Ma l'autocoscienza è oggi talmente
arretrata che il non farlo non avrebbe altro significato che dare per accettato, an-
cora una volta, il retroterra teorico che la «tradizione» ci consegna: che è appun-
to la prima cosa da rifiutare, oggi.
La definizione del soggetto è oggi limitata ai due lati opposti dall'autointer-
rogazione della ragione illuministica e dalla tesi marxiana che lo sviluppo delle
forze produttive rende possibile la liberazione. «L'uomo è nato libero e giace
ovunque in catene» diceva Rousseau all'inizio del
Contrat Social;
Marx, superan-
do (con l'aiuto di Hegel) il pensiero illuministico che vede la dialettica della ra-
gione come un processo dell'intelletto astratto, ricollega il processo di liberazione
alla crescita di un modo di produzione che rende
oggettivamente possibile
il supe-
ramento della costrizione in quanto individua la sua
radice
storica nell'arretra-
tezza del livello delle forze produttive.
(4) Ibid. p. 15.
5
















