
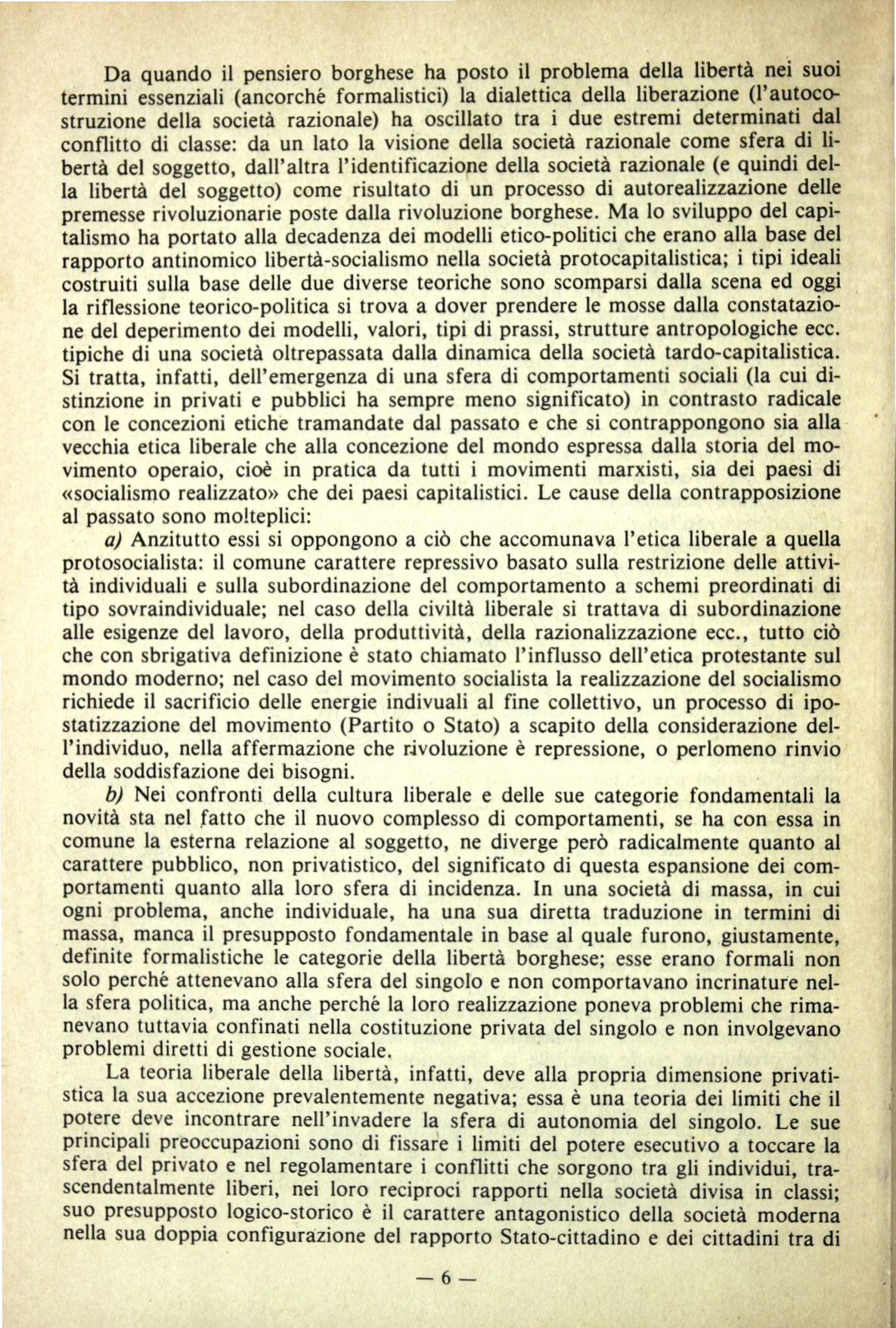
Da quando il pensiero borghese ha posto il problema della libertà nei suoi
termini essenziali (ancorché formalistici) la dialettica della liberazione (l'autoco-
struzione della società razionale) ha oscillato tra i due estremi determinati dal
conflitto di classe: da un lato la visione della società razionale come sfera di li-
bertà del soggetto, dall'altra l'identificazione della società razionale (e quindi del-
la libertà del soggetto) come risultato di un processo di autorealizzazione delle
premesse rivoluzionarie poste dalla rivoluzione borghese. Ma lo sviluppo del capi-
talismo ha portato alla decadenza dei modelli etico-politici che erano alla base del
rapporto antinomico libertà-socialismo nella società protocapitalistica; i tipi ideali
costruiti sulla base delle due diverse teoriche sono scomparsi dalla scena ed oggi
la riflessione teorico-politica si trova a dover prendere le mosse dalla constatazio-
nedel deperimento dei modelli, valori, tipi di prassi, strutture antropologiche ecc.
tipiche di una società oltrepassata dalla dinamica della società tardo-capitalistica.
Si tratta, infatti, dell'emergenza di una sfera di comportamenti sociali (la cui di-
stinzione in privati e pubblici ha sempre meno significato) in contrasto radicale
con le concezioni etiche tramandate dal passato e che si contrappongono sia alla
vecchia etica liberale che alla concezione del mondo espressa dalla storia del mo-
vimento operaio, cioè in pratica da tutti i movimenti marxisti, sia dei paesi di
«socialismo realizzato» che dei paesi capitalistici. Le cause della contrapposizione
al passato sonomolteplici:
a) Anzitutto essi si oppongono a ciò che accomunava l'etica liberale a quella
protosocialista: il comune carattere repressivo basato sulla restrizione delle attivi-
tà individuali e sulla subordinazione del comportamento a schemi preordinati di
tipo sovraindividuale; nel caso della civiltà liberale si trattava di subordinazione
alle esigenze del lavoro, della produttività, della razionalizzazione ecc., tutto ciò
checon sbrigativa definizione è stato chiamato l'influsso dell'etica protestante sul
mondomoderno; nel caso del movimento socialista la realizzazione del socialismo
richiede il sacrificio delle energie indivuali al fine collettivo, un processo di ipo-
statizzazione del movimento (Partito o Stato) a scapito della considerazione del-
l'individuo, nella affermazione che rivoluzione è repressione, o perlomeno rinvio
della soddisfazione dei bisogni.
b)
Nei confronti della cultura liberale e delle sue categorie fondamentali la
novità sta nel fatto che il nuovo complesso di comportamenti, se ha con essa in
comune la esterna relazione al soggetto, ne diverge però radicalmente quanto al
carattere pubblico, non privatistico, del significato di questa espansione dei com-
portamenti quanto alla loro sfera di incidenza. In una società di massa, in cui
ogni problema, anche individuale, ha una sua diretta traduzione in termini di
massa,manca il presupposto fondamentale in base al quale furono, giustamente,
definite formalistiche le categorie della libertà borghese; esse erano formali non
soloperché attenevano alla sfera del singolo e non comportavano incrinature nel-
la sfera politica, ma anche perché la loro realizzazione poneva problemi che rima-
nevano tuttavia confinati nella costituzione privata del singolo e non involgevano
problemi diretti di gestione sociale.
La teoria liberale della libertà, infatti, deve alla propria dimensione privati-
stica la sua accezione prevalentemente negativa; essa è una teoria dei limiti che il
potere deve incontrare nell'invadere la sfera di autonomia del singolo. Le sue
principali preoccupazioni sono di fissare i limiti del potere esecutivo a toccare la
sfera del privato e nel regolamentare i conflitti che sorgono tra gli individui, tra-
scendentalmente liberi, nei loro reciproci rapporti nella società divisa in classi;
suopresupposto logico-storico è il carattere antagonistico della società moderna
nella sua doppia configurazione del rapporto Stato-cittadino e dei cittadini tra di
6
















