
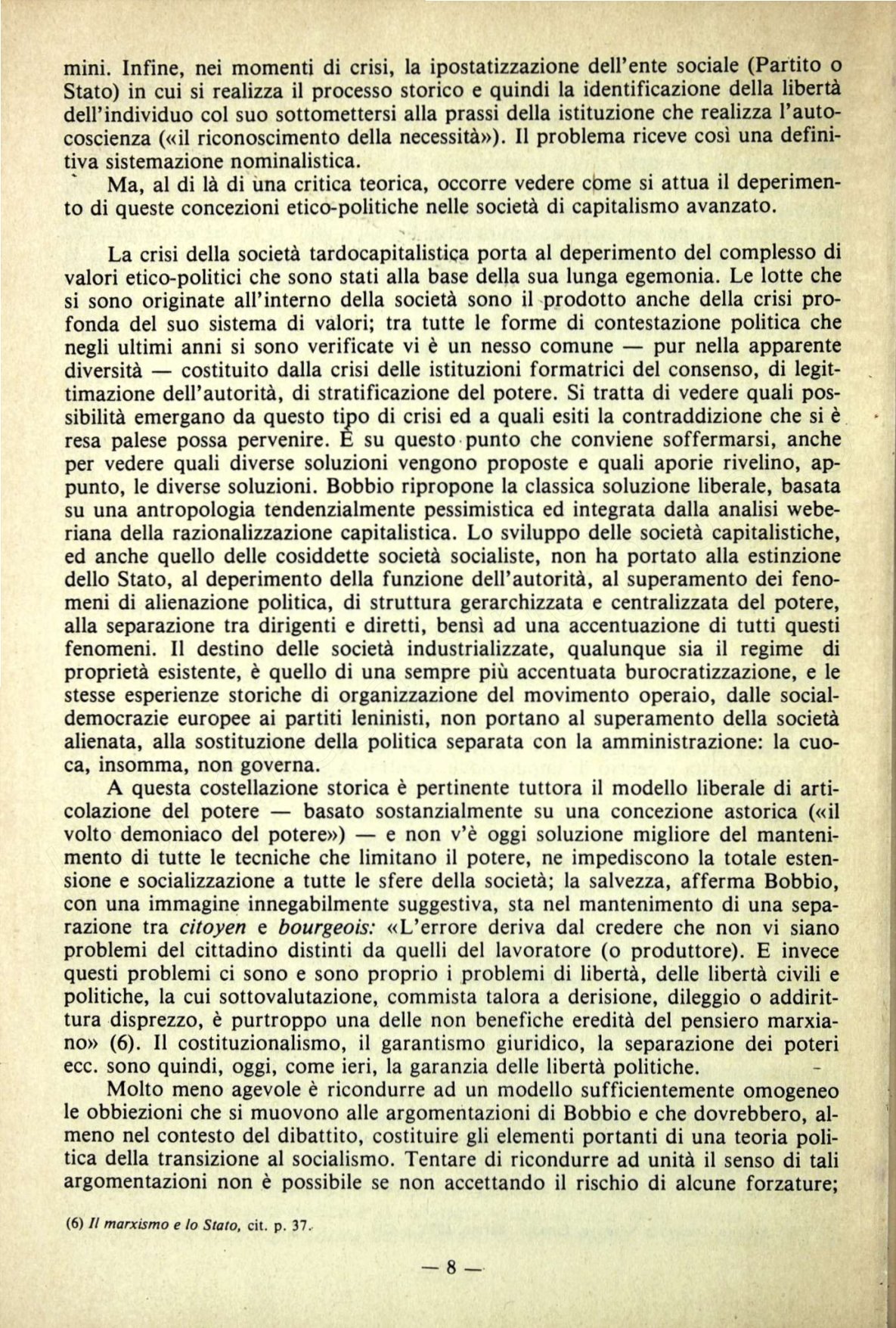
mini. Infine, nei momenti di crisi, la ipostatizzazione dell'ente sociale (Partito o
Stato) in cui si realizza il processostorico e quindi la identificazione della libertà
dell'individuo col suosottomettersi alla prassi della istituzione che realizza l'auto-
coscienza («il riconoscimento della necessità»). I l problema riceve così una defini-
tiva sistemazionenominalistica.
t M a , al di là di una critica teorica, occorre vederecbme si attua il deperimen-
to di questeconcezioni etico-politiche nelle società di capitalismo avanzato.
La crisi della società tardocapitalistica porta al deperimento del complesso di
valori etico-politici che sono stati alla base della sua lunga egemonia. Le lotte che
sisono originate all'interno della società sono il prodotto anche della crisi pro-
fonda del suo sistema di valori; tra tutte le forme di contestazione politica che
negli ultimi anni si sono verificate vi è un nessocomune — pur nella apparente
diversità — costituito dalla crisi delle istituzioni formatrici del consenso, di legit-
timazione dell'autorità, di stratificazione del potere. Si tratta di vedere quali pos-
sibilità emergano da questo tipo di crisi ed a quali esiti la contraddizione che si è
resapalesepossa pervenire. E su questo•punto che conviene soffermarsi, anche
per vedere quali diverse soluzioni vengono proposte e quali aporie rivelino, ap-
punto, le diverse soluzioni. Bobbio ripropone la classicasoluzione liberale, basata
suuna antropologia tendenzialmentepessimistica ed integrata dalla analisi webe-
riana della razionalizzazione capitalistica. Lo sviluppo delle società capitalistiche,
edanche quello delle cosiddette società socialiste, non ha portato alla estinzione
delloStato, al deperimento della funzione dell'autorità, al superamento dei feno-
meni di alienazione politica, di struttura gerarchizzata e centralizzata del potere,
alla separazione tra dirigenti e diretti, bensì ad una accentuazione di tutti questi
fenomeni. I l destino delle società industrializzate, qualunque sia i l regime d i
proprietàesistente, è quello di una sempre più accentuata burocratizzazione, e le
stesseesperienze storiche di organizzazione del movimento operaio, dalle social-
democrazieeuropee ai partiti leninisti, non portano al superamento della società
alienata, alla sostituzione della politica separata con la amministrazione: la cuo-
ca, insomma, non governa.
A questa costellazione storica è pertinente tuttora il modello liberale di arti-
colazione del potere — basato sostanzialmente su una concezione astorica («il
voltodemoniaco del potere») — e non v'è oggi soluzione migliore del manteni-
mento di tutte le tecniche che limitano il potere, ne impediscono la totale esten-
sione e socializzazione a tutte le sfere della società; la salvezza, afferma Bobbio,
conuna immagine innegabilmentesuggestiva, sta nel mantenimento di una sepa-
razione tra
citoyen
e
bourgeois:
«L'errore deriva dal credere che non vi siano
problemi del cittadino distinti da quelli del lavoratore (o produttore). E invece
questi problemi ci sono e sono proprio i problemi di libertà, delle libertà civili e
politiche, la cui sottovalutazione, commista talora a derisione, dileggio o addirit-
tura disprezzo, è purtroppo una delle non benefiche eredità del pensieromarxia-
no» (6). I l costituzionalismo, i l garantismo giuridico, la separazione dei poteri
ecc.sono quindi, oggi, come ieri, la garanzia delle libertà politiche.
Moltomeno agevole è ricondurre ad un modello sufficientementeomogeneo
leobbiezioni che si muovono alle argomentazioni di Bobbio e che dovrebbero, al-
menonel contesto del dibattito, costituire gli elementi portanti di una teoria poli-
tica della transizione al socialismo. Tentare di ricondurre ad unità il senso di tali
argomentazioni non è possibile se non accettando il rischio di alcune forzature;
(6)11marxismo e Io Stato, cit. p. 37.
8
















