
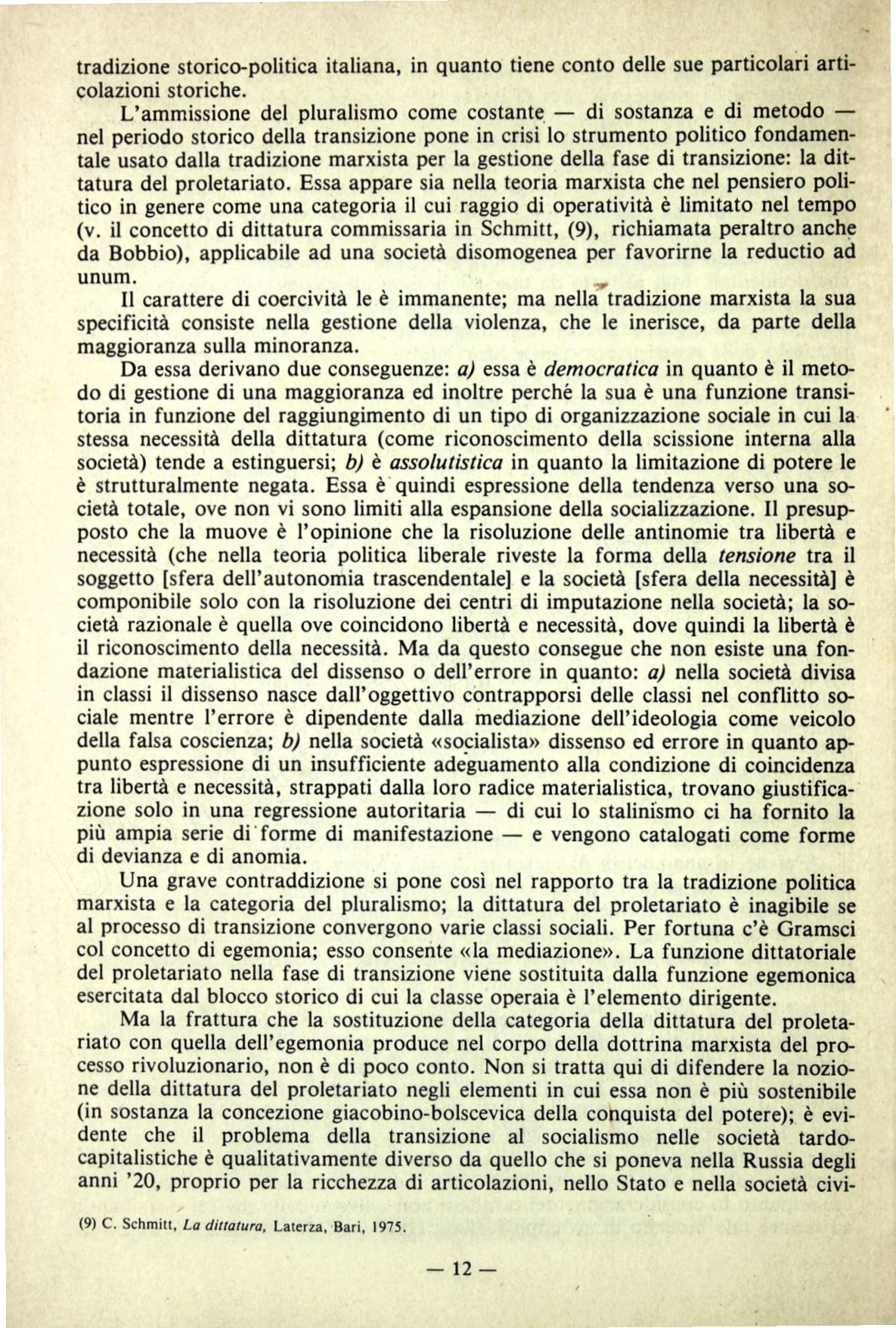
tradizione storico-politica italiana, in quanto tiene conto delle sue particolari arti-
colazioni storiche.
L'ammissione del pluralismo come costante — di sostanza e di metodo
nel periodo storico della transizione pone in crisi lo strumento politico fondamen-
tale usato dalla tradizione marxista per la gestione della fase di transizione: la dit-
tatura del proletariato. Essa appare sia nella teoria marxista che nel pensiero poli-
tico in genere come una categoria il cui raggio di operatività è limitato nel tempo
(v. il concetto di dittatura commissaria in Schmitt, (9), richiamata peraltro anche
da Bobbio), applicabile ad una società disomogenea per favorirne la reductio ad
unum.
Il carattere di coercività le è immanente; ma nella tradizione marxista la sua
specificità consiste nella gestione della violenza, che le inerisce, da parte della
maggioranza sulla minoranza.
Da essa derivano due conseguenze: a) essa è
democratica
in quanto è il meto-
do di gestione di una maggioranza ed inoltre perché la sua è una funzione transi-
toria in funzione del raggiungimento di un tipo di organizzazione sociale in cui la
stessanecessità della dittatura (come riconoscimento della scissione interna alla
società) tende a estinguersi;
b)
è
assolutistica
in quanto la limitazione di potere le
èstrutturalmente negata. Essa è quindi espressione della tendenza verso una so-
cietà totale, ove non vi sono limiti alla espansione della socializzazione. I l presup-
posto che la muove è l'opinione che la risoluzione delle antinomie tra libertà e
necessità (che nella teoria politica liberale riveste la forma della
tensione tra
il
soggetto [sfera dell'autonomia trascendentale] e la società [sfera della necessità] è
componibile solo con la risoluzione dei centri di imputazione nella società; la so-
cietà razionale è quella ove coincidono libertà e necessità, dove quindi la libertà è
il riconoscimento della necessità. Ma da questo consegue che non esiste una fon-
dazionematerialistica del dissenso o dell'errore in quanto:
a)
nella società divisa
in classi il dissensonasce dall'oggettivo contrapporsi delle classi nel conflitto so-
ciale mentre l'errore è dipendente dalla mediazione dell'ideologia come veicolo
della falsa coscienza;
b)
nella società «socialista» dissenso ed errore in quanto ap-
puntoespressione di un insufficiente adeguamento alla condizione di coincidenza
tra libertà e necessità, strappati dalla loro radice materialistica, trovano giustifica-
zione solo in una regressione autoritaria — di cui lo stalinismo ci ha fornito la
più ampia serie di forme di manifestazione — e vengono catalogati come forme
di devianza e di anomia.
Una grave contraddizione si pone così nel rapporto tra la tradizione politica
marxista e la categoria del pluralismo; la dittatura del proletariato è inagibile se
al processo di transizione convergono varie classi sociali. Per fortuna c'è Gramsci
col concetto di egemonia; essoconsente «la mediazione». La funzione dittatoriale
del proletariato nella fase di transizione viene sostituita dalla funzione egemonica
esercitata dal blocco storico di cui la classe operaia è l'elemento dirigente.
Ma la frattura che la sostituzione della categoria della dittatura del proleta-
riato con quella dell'egemonia produce nel corpo della dottrina marxista del pro-
cessorivoluzionario, non è di poco conto. Non si tratta qui di difendere la nozio-
nedella dittatura del proletariato negli elementi in cui essa non è più sostenibile
(in sostanza la concezione giacobino-bolscevica della conquista del potere); è evi-
dente che i l problema della transizione a l socialismo nelle società tardo-
capitalistiche è qualitativamente diverso da quello che si poneva nella Russia degli
anni '20, proprio per la ricchezza di articolazioni, nello Stato e nella società civi-
(9) C. Schmitt,
La dittatura,
Laterza, Bari, 1975.
12—
















