
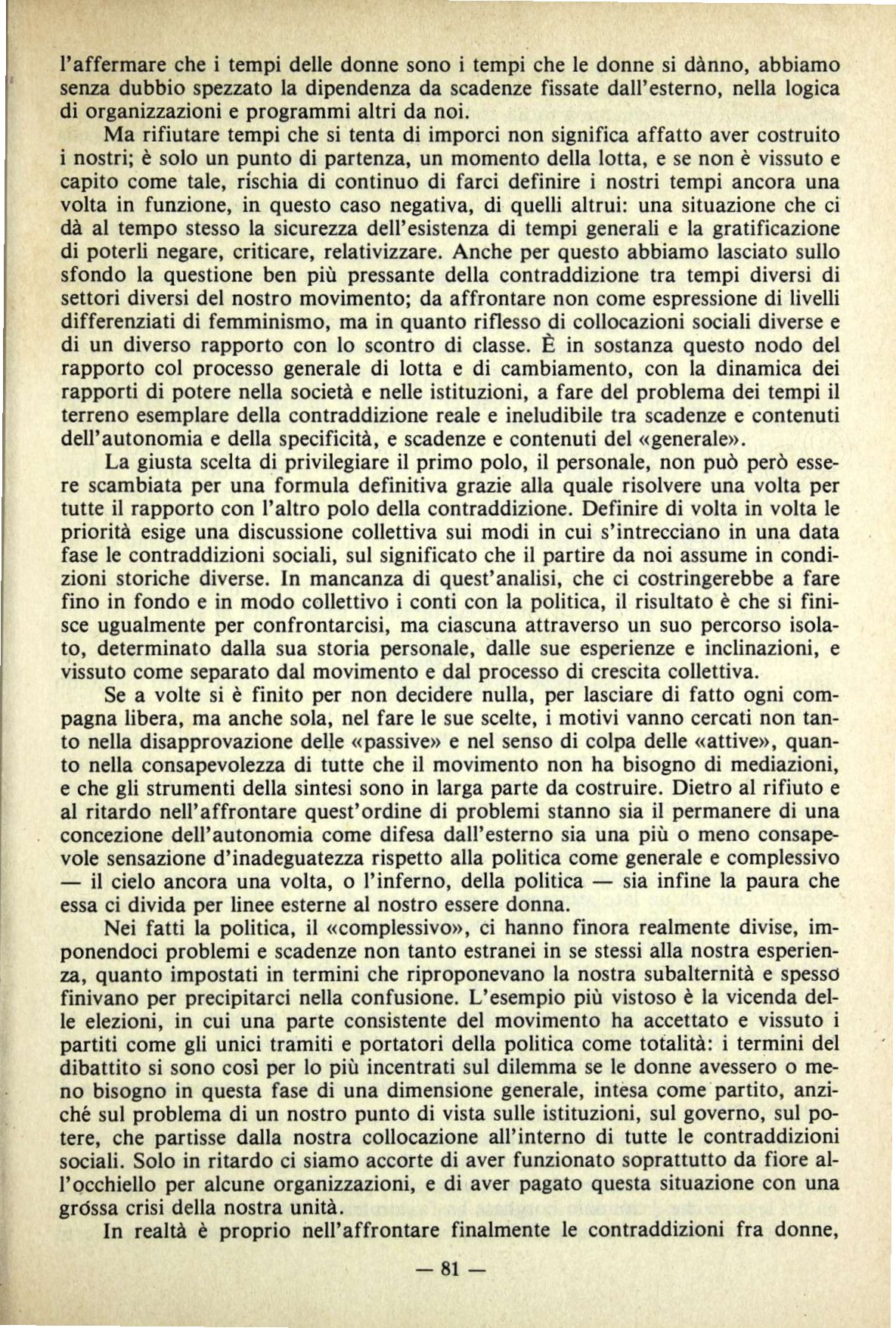
l'affermare che i tempi delle donne sono i tempi che le donne si dànno, abbiamo
senzadubbio spezzato la dipendenza da scadenze fissate dall'esterno, nella logica
di organizzazioni e programmi altri da noi.
Ma rifiutare tempi che si tenta di imporci non significa affatto aver costruito
i nostri; è solo un punto di partenza, un momento della lotta, e senon è vissuto e
capito come tale, rischia di continuo di farci definire i nostri tempi ancora una
volta in funzione, in questo caso negativa, di quelli altrui: una situazione che ci
dà al tempostesso la sicurezza dell'esistenza di tempi generali e la gratificazione
di poterli negare, criticare, relativizzare. Anche per questo abbiamo lasciato sullo
sfondo la questione ben più pressante della contraddizione tra tempi diversi di
settori diversi del nostromovimento; da affrontare non comeespressione di livelli
differenziati di femminismo, ma in quanto riflesso di collocazioni sociali diverse e
di un diverso rapporto con lo scontro di classe. È in sostanza questo nodo del
rapporto col processogenerale di lotta e di cambiamento, con la dinamica dei
rapporti di potere nella società e nelle istituzioni, a fare del problema dei tempi il
terrenoesemplare della contraddizione reale e ineludibile tra scadenze e contenuti
dell'autonomia e della specificità, e scadenzee contenuti del «generale».
La giusta scelta di privilegiare il primo polo, il personale, non può peròesse-
rescambiata per una formula definitiva grazie alla quale risolvere una volta per
tutte il rapporto con l'altro polo della contraddizione. Definire di volta in volta le
priorità esige una discussione collettiva sui modi in cui s'intrecciano in una data
fase le contraddizioni sociali, sul significatoche il partire da noi assume in condi-
zioni storiche diverse. In mancanza di quest'analisi, che ci costringerebbe a fare
fino in fondo e in modo collettivo i conti con la politica, il risultato è che si fini-
sceugualmente per confrontarcisi, ma ciascuna attraverso un suo percorso isola-
to, determinato dalla sua storia personale, dalle sue esperienze e inclinazioni, e
vissutocomeseparato dal movimento e dal processo di crescita collettiva.
Se a volte si è finito per non decidere nulla, per lasciare di fatto ogni com-
pagna libera, ma anche sola, nel fare le suescelte, i motivi vanno cercati non tan-
to nella disapprovazione delle «passive» e nel senso di colpa delle «attive», quan-
to nella consapevolezza di tutte che il movimento non ha bisogno di mediazioni,
eche gli strumenti della sintesi sono in larga parte da costruire. Dietro al rifiuto e
al ritardo nell'affrontare quest'ordine di problemi stanno sia il permanere di una
concezionedell'autonomia come difesa dall'esterno sia una più o meno consape-
volesensazioned'inadeguatezza rispetto alla politica comegenerale e complessivo
il cielo ancora una volta, o l'inferno, della politica — sia infine la paura che
essaci divida per linee esterne al nostroesseredonna.
Nei fatti la politica, il «complessivo», ci hanno finora realmente divise, im-
ponendoci problemi e scadenzenon tanto estranei in sestessi alla nostra esperien-
za, quanto impostati in termini che riproponevano la nostra subalternità e spesso
finivano per precipitarci nella confusione. L'esempio più vistoso è la vicenda del-
le elezioni, in cui una parte consistente del movimento ha accettato e vissuto i
partiti come gli unici tramiti e portatori della politica come totalità: i termini del
dibattito si sonocosì per lo più incentrati sul dilemmase le donneavessero o me-
nobisogno in questa fase di una dimensione generale, intesa come partito, anzi-
chésul problema di un nostro punto di vista sulle istituzioni, sul governo, sul po-
tere, che partisse dalla nostra collocazione all'interno di tutte le contraddizioni
sociali. Solo in ritardo ci siamo accorte di aver funzionato soprattutto da fiore al-
l'occhiello per alcune organizzazioni, e di aver pagato questa situazione con una
grdssacrisi della nostra unità.
In realtà è proprio nell'affrontare finalmente le contraddizioni fra donne,
- 8 1
















