
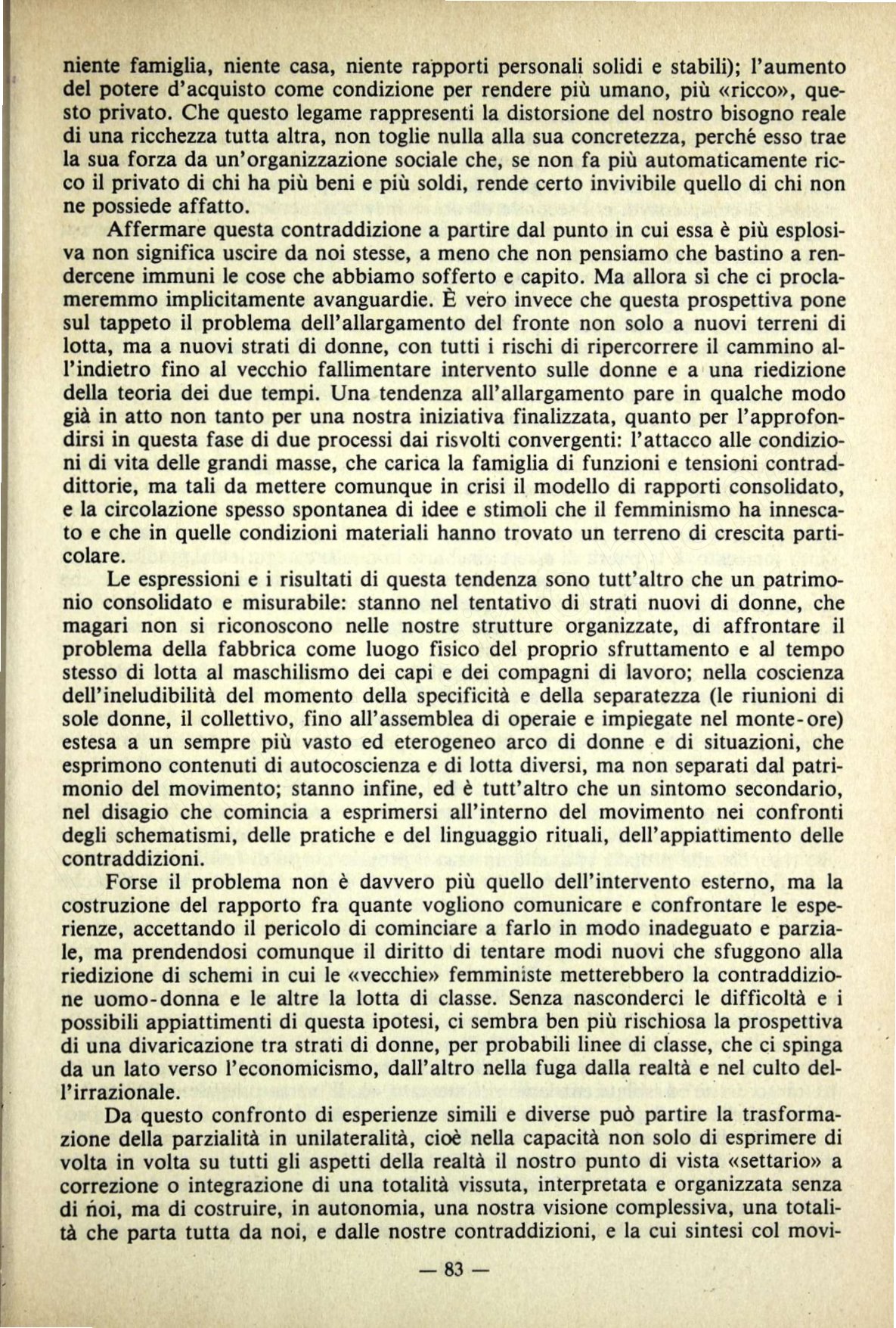
niente famiglia, niente casa, niente rapporti personali solidi e stabili); l'aumento
del potere d'acquisto come condizione per rendere più umano, più «ricco», que-
stoprivato. Che questo legame rappresenti la distorsione del nostro bisogno reale
di una ricchezza tutta altra, non toglie nulla alla sua concretezza, perchéesso trae
la sua forza da un'organizzazione sociale che, se non fa più automaticamente ric-
co il privato di chi ha più beni e più soldi, rende certo invivibile quello di chi non
nepossiede affatto.
Affermare questa contraddizione a partire dal punto in cui essaè più esplosi-
va non significa uscire da noi stesse, a meno che non pensiamoche bastino a ren-
dercene immuni le coseche abbiamo sofferto e capito. Ma allora si che ci procla-
meremmo implicitamente avanguardie. È vero invece che questa prospettiva pone
sul tappeto il problema dell'allargamento del fronte non solo a nuovi terreni di
lotta, ma a nuovi strati di donne, con tutti i rischi di ripercorrere il cammino al-
l'indietro fino al vecchio fallimentare intervento sulle donne e a una riedizione
della teoria dei due tempi. Una tendenza all'allargamento pare in qualche modo
già in atto non tanto per una nostra iniziativa finalizzata, quanto per l'approfon-
dirsi in questa fase di dueprocessi dai risvolti convergenti: l'attacco alle condizio-
ni di vita delle grandimasse, che carica la famiglia di funzioni e tensioni contrad-
dittorie, ma tali da mettere comunque in crisi il modello di rapporti consolidato,
e la circolazionespessospontanea di idee e stimoli che il femminismo ha innesca-
to e che in quelle condizioni materiali hanno trovato un terreno di crescita parti-
colare.
Leespressioni e i risultati di questa tendenza sono tutt'altro che un patrimo-
nio consolidato e misurabile: stanno nel tentativo di strati nuovi di donne, che
magari non si riconoscono nelle nostre strutture organizzate, di affrontare i l
problema della fabbrica come luogo fisico del proprio sfruttamento e al tempo
stesso di lotta al maschilismo dei capi e dei compagni di lavoro; nella coscienza
dell'ineludibilità del momento della specificità e della separatezza (le riunioni di
soledonne, il collettivo, fino all'assemblea di operaie e impiegate nel monte- ore)
estesa a un sempre più vasto ed eterogeneo arco di donne e di situazioni, che
esprimonocontenuti di autocoscienza e di lotta diversi, ma non separati dal patri-
monio del movimento; stanno infine, ed è tutt'altro che un sintomo secondario,
nel disagio che comincia a esprimersi all'interno del movimento nei confronti
degli schematismi, delle pratiche e del linguaggio rituali, dell'appiattimento delle
contraddizioni.
Forse il problema non è davvero più quello dell'intervento esterno, ma la
costruzione del rapporto fra quante vogliono comunicare e confrontare le espe-
rienze, accettando il pericolo di cominciare a farlo in modo inadeguato e parzia-
le, ma prendendosi comunque il diritto di tentare modi nuovi che sfuggono alla
riedizione di schemi in cui le «vecchie» femministemetterebbero la contraddizio-
neuomo-donna e le altre la lotta di classe. Senza nasconderci le difficoltà e i
possibili appiattimenti di questa ipotesi, ci sembraben più rischiosa la prospettiva
di una divaricazione tra strati di donne, per probabili linee di classe, che ci spinga
da un lato verso l'economicismo, dall'altro nella fuga dalla realtà e nel culto del-
l'irrazionale.
Da questo confronto di esperienze simili e diverse può partire la trasforma-
zione della parzialità in unilateralità, cioè nella capacità non solo di esprimere di
volta in volta su tutti gli aspetti della realtà il nostro punto di vista «settario» a
correzione o integrazione di una totalità vissuta, interpretata e organizzata senza
di tioi, ma di costruire, in autonomia, una nostra visione complessiva, una totali-
tà che parta tutta da noi, e dalle nostre contraddizioni, e la cui sintesi col movi-
83
















