
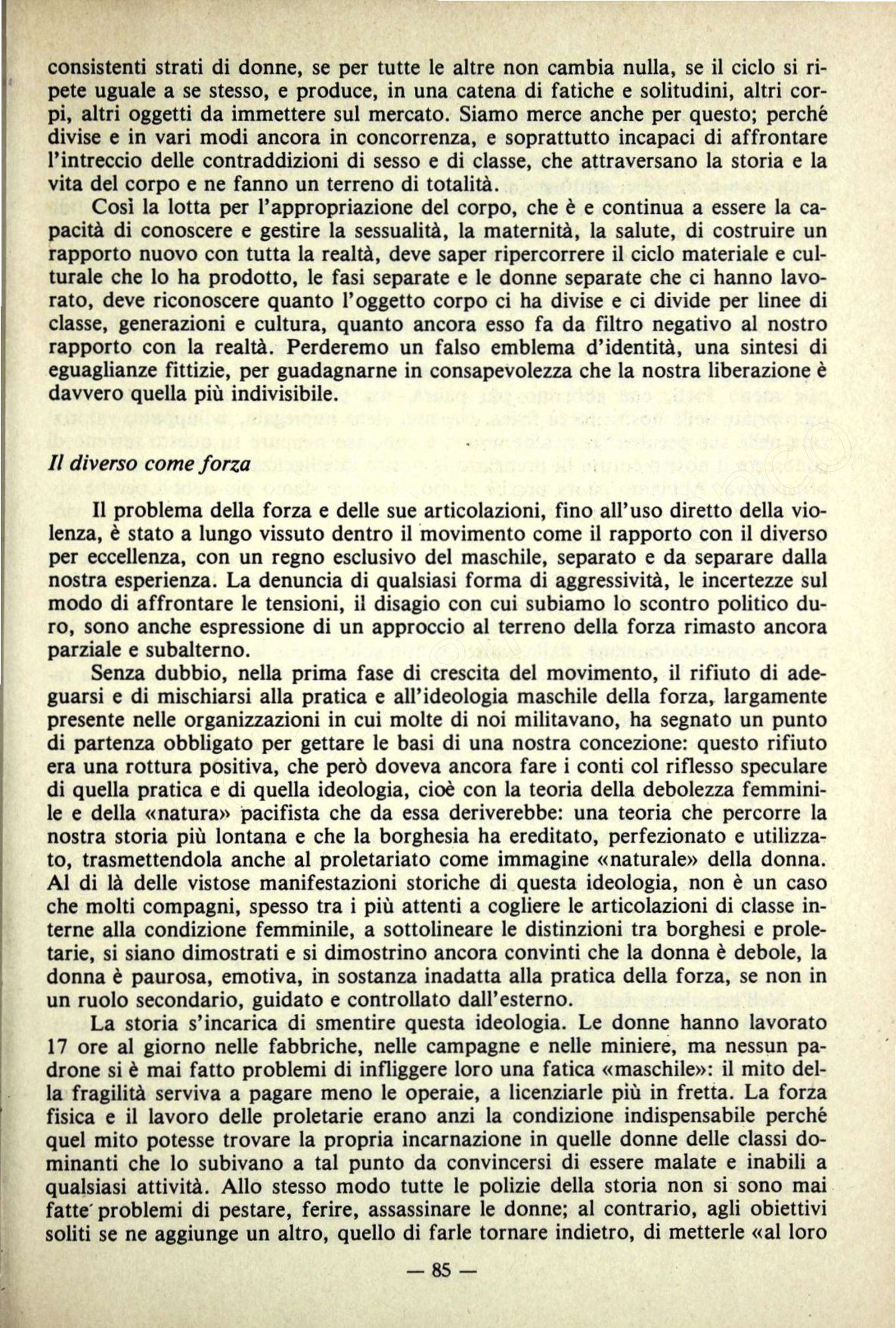
consistenti strati di donne, se per tutte le altre non cambia nulla, se il ciclo si ri-
peteuguale a sestesso, e produce, in una catena di fatiche e solitudini, altri cor-
pi, altri oggetti da immettere sul mercato. Siamomerce anche per questo; perché
divise e in vari modi ancora in concorrenza, e soprattutto incapaci di affrontare
l'intreccio delle contraddizioni di sesso e di classe, che attraversano la storia e la
vita del corpo e ne fanno un terreno di totalità.
Così la lotta per l'appropriazione del corpo, che è e continua a essere la ca-
pacità di conoscere e gestire la sessualità, la maternità, la salute, di costruire un
rapporto nuovo con tutta la realtà, deve saper ripercorrere il ciclomateriale e cul-
turale che lo ha prodotto, le fasi separate e le donne separate che ci hanno lavo-
rato, deve riconoscere quanto l'oggetto corpo ci ha divise e ci divide per linee di
classe, generazioni e cultura, quanto ancora esso fa da filtro negativo al nostro
rapporto con la realtà. Perderemo un falso emblema d'identità, una sintesi di
eguaglianze fittizie, per guadagnarne in consapevolezzache la nostra liberazione è
davvero quella più indivisibile.
Il diversocome forza
Il problema della forza e delle sue articolazioni, fino all'uso diretto della vio-
lenza, è stato a lungo vissuto dentro il movimento come il rapporto con il diverso
per eccellenza, con un regno esclusivo del maschile, separato e da separare dalla
nostraesperienza. La denuncia di qualsiasi forma di aggressività, le incertezze sul
modo di affrontare le tensioni, il disagio con cui subiamo lo scontro politico du-
ro, sono ancheespressione di un approccio al terreno della forza rimasto ancora
parziale e subalterno.
Senzadubbio, nella prima fase di crescita del movimento, il rifiuto di ade-
guarsi e di mischiarsi alla pratica e all'ideologiamaschile della forza, largamente
presentenelle organizzazioni in cui molte di noi militavano, ha segnato un punto
di partenza obbligato per gettare le basi di una nostra concezione: questo rifiuto
era una rottura positiva, che però doveva ancora fare i conti col riflessospeculare
di quella pratica e di quella ideologia, cioè con la teoria della debolezza femmini-
le e della «natura» pacifista che da essaderiverebbe: una teoria che percorre la
nostra storia più lontana e che la borghesia ha ereditato, perfezionato e utilizza-
to, trasmettendola anche al proletariato come immagine «naturale» della donna.
Al di là delle vistosemanifestazioni storiche di questa ideologia, non è un caso
chemolti compagni, spesso tra i più attenti a cogliere le articolazioni di classe in-
terne alla condizione femminile, a sottolineare le distinzioni tra borghesi e prole-
tarie, si siano dimostrati e si dimostrino ancora convinti che la donna è debole, la
donna è paurosa, emotiva, in sostanza inadatta alla pratica della forza, se non in
un ruolo secondario, guidato e controllato dall'esterno.
La storia s'incarica di smentire questa ideologia. Le donne hanno lavorato
17ore al giorno nelle fabbriche, nelle campagne e nelle miniere, ma nessun pa-
drone si è mai fatto problemi di infliggere loro una fatica «maschile»: il mito del-
la fragilità serviva a pagaremeno le operaie, a licenziarle più in fretta. La forza
fisica e il lavoro delle proletarie erano anzi la condizione indispensabile perché
quel mito potesse trovare la propria incarnazione in quelle donne delle classi do-
minanti che lo subivano a tal punto da convincersi di esseremalate e inabili a
qualsiasi attività. Allo stessomodo tutte le polizie della storia non si sono mai
fatte problemi di pestare, ferire, assassinare le donne; al contrario, agli obiettivi
soliti se ne aggiunge un altro, quello di farle tornare indietro, di metterle «al loro
—85
















