
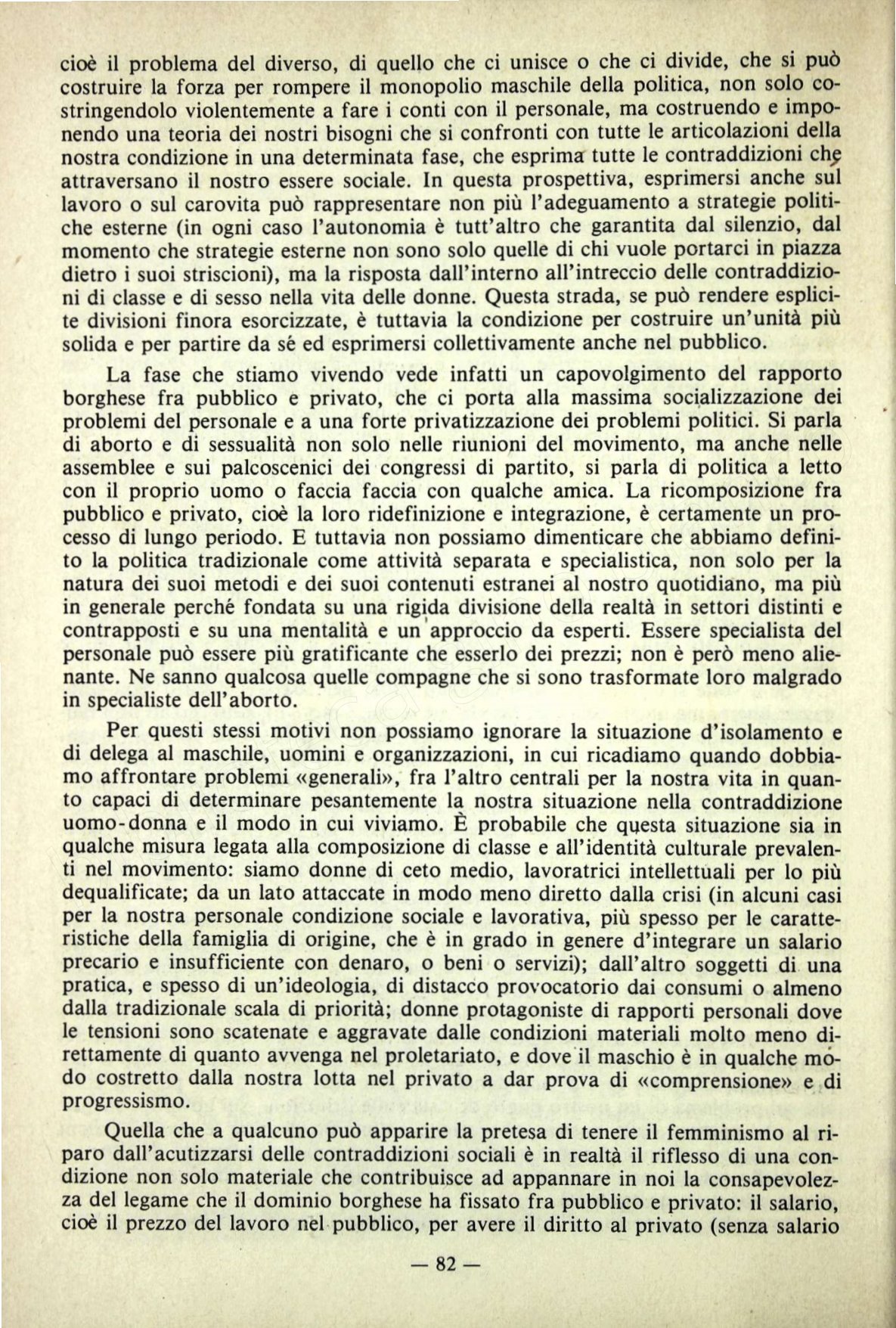
cioè il problema del diverso, di quello che ci unisce o che ci divide, che si può
costruire la forza per rompere il monopolio maschile della politica, non solo co-
stringendolo violentemente a fare i conti con il personale, ma costruendo e impo-
nendo una teoria dei nostri bisogni che si confronti con tutte le articolazioni della
nostra condizione in una determinata fase, che esprima tutte le contraddizioni chs
attraversano il nostro essere sociale. In questa prospettiva, esprimersi anche sul
lavoro o sul carovita può rappresentare non più l'adeguamento a strategie politi-
cheesterne (in ogni caso l'autonomia è tutt'altro che garantita dal silenzio, dal
momento che strategie esterne non sono solo quelle di chi vuole portarci in piazza
dietro i suoi striscioni), ma la risposta dall'interno all'intreccio delle contraddizio-
ni di classe e di sessonella vita delle donne. Questa strada, se può rendere esplici-
te divisioni finora esorcizzate, è tuttavia la condizione per costruire un'unità più
solida e per partire da sé ed esprimersi collettivamente anche nel pubblico.
La fase che stiamo vivendo vede infatti un capovolgimento del rapporto
borghese fra pubblico e privato, che ci porta alla massima socializzazione dei
problemi del personale e a una forte privatizzazione dei problemi politici. Si parla
di aborto e di sessualità non solo nelle riunioni del movimento, ma anche nelle
assemblee e sui palcoscenici dei congressi di partito, si parla di politica a letto
con il proprio uomo o faccia faccia con qualche amica. La ricomposizione fra
pubblico e privato, cioè la loro ridefinizione e integrazione, è certamente un pro-
cessodi lungo periodo. E tuttavia non possiamo dimenticare che abbiamo defini-
to la politica tradizionale come attività separata e specialistica, non solo per la
natura dei suoi metodi e dei suoi contenuti estranei al nostro quotidiano, ma più
in generale perché fondata su una rigida divisione della realtà in settori distinti e
contrapposti e su una mentalità e un 'approccio da esperti. Essere specialista del
personale può essere più gratificante che esserlo dei prezzi; non è però meno alie-
nante. Ne sanno qualcosa quelle compagne che si sono trasformate loro malgrado
in specialiste dell'aborto.
Per questi stessi motivi non possiamo ignorare la situazione d'isolamento e
di delega al maschile, uomini e organizzazioni, in cui ricadiamo quando dobbia-
mo affrontare problemi «generali», fra l'altro centrali per la nostra vita in quan-
to capaci di determinare pesantemente la nostra situazione nella contraddizione
uomo-donna e il modo in cui viviamo. È probabile che questa situazione sia in
qualchemisura legata alla composizione di classe e all'identità culturale prevalen-
ti nel movimento: siamo donne di ceto medio, lavoratrici intellettuali per lo più
dequalificate; da un lato attaccate in modo meno diretto dalla crisi (in alcuni casi
per la nostra personale condizione sociale e lavorativa, più spesso per le caratte-
ristiche della famiglia di origine, che è in grado in genere d'integrare un salario
precario e insufficiente con denaro, o beni o servizi); dall'altro soggetti di una
pratica, e spesso di un'ideologia, di distacco provocatorio dai consumi o almeno
dalla tradizionale scala di priorità; donne protagoniste di rapporti personali dove
le tensioni sono scatenate e aggravate dalle condizioni materiali molto meno di-
rettamente di quanto avvenga nel proletariato, e dove il maschio è in qualche mó-
do costretto dalla nostra lotta nel privato a dar prova di «comprensione» e di
progressismo.
Quella che a qualcuno può apparire la pretesa di tenere il femminismo al ri-
paro dall'acutizzarsi delle contraddizioni sociali è in realtà il riflesso di una con-
dizione non solo materiale che contribuisce ad appannare in noi la consapevolez-
za del legame che il dominio borghese ha fissato fra pubblico e privato: il salario,
cioè il prezzo del lavoro nel pubblico, per avere il diritto al privato (senza salario
—82
















