
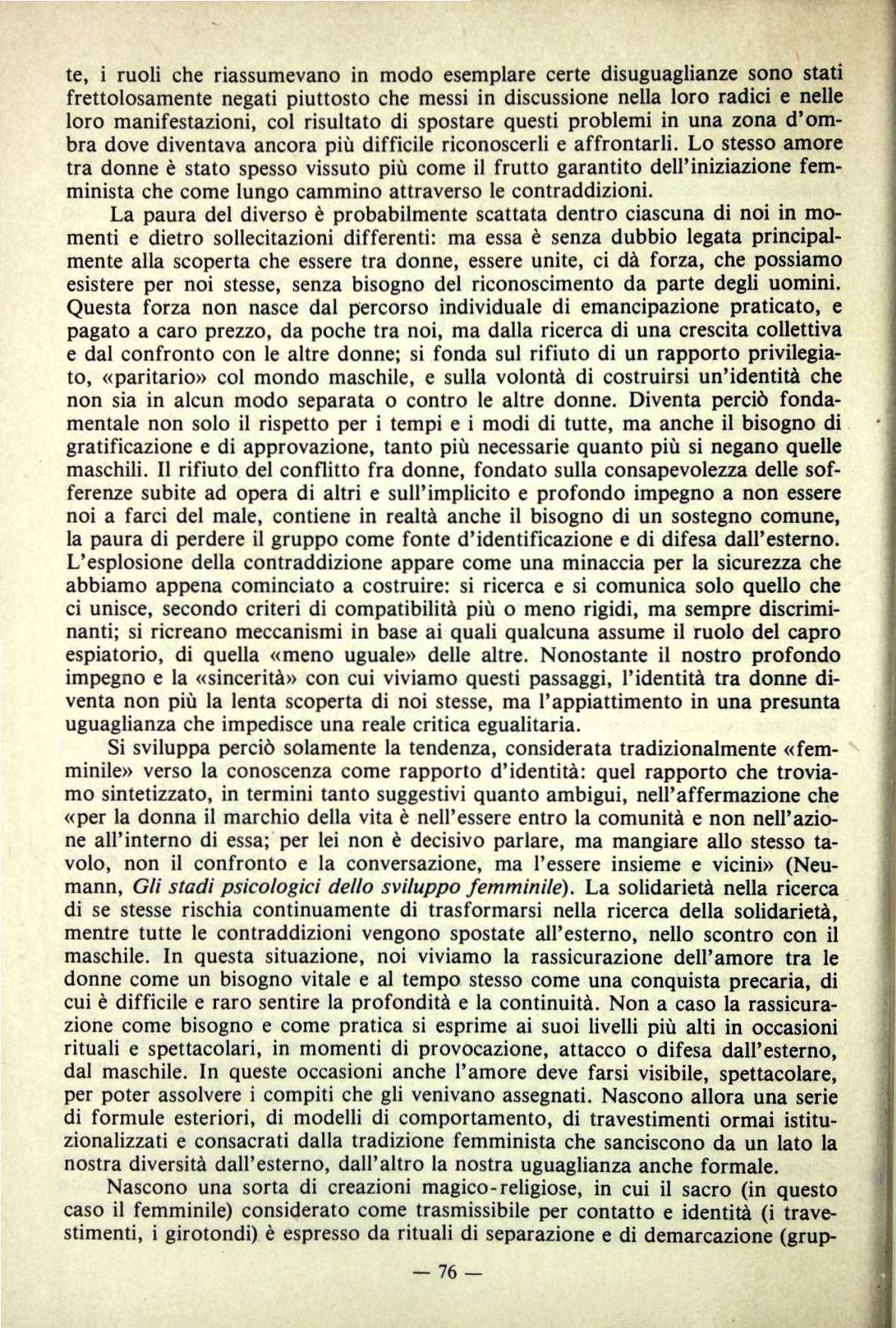
te, i ruoli che riassumevano in modo esemplare certe disuguaglianze sono stati
frettolosamente negati piuttosto chemessi in discussione nella loro radici e nelle
loro manifestazioni, col risultato di spostare questi problemi in una zona d'om-
bra dove diventava ancora più difficile riconoscerli e affrontarli. Lo stesso amore
tra donne è stato spessovissuto più come il frutto garantito dell'iniziazione fem-
minista che come lungo cammino attraverso le contraddizioni.
La paura del diverso è probabilmente scattata dentro ciascuna di noi in mo-
menti e dietro sollecitazioni differenti: ma essa è senza dubbio legata principal-
mente alla scoperta che essere tra donne, essere unite, ci dà forza, che possiamo
esistere per noi stesse, senza bisogno del riconoscimento da parte degli uomini.
Questa forza non nasce dal percorso individuale di emancipazione praticato, e
pagato a caro prezzo, da poche tra noi, ma dalla ricerca di una crescita collettiva
edal confronto con le altre donne; si fonda sul rifiuto di un rapporto privilegia-
to, «paritario» col mondo maschile, e sulla volontà di costruirsi un'identità che
non sia in alcun modo separata o contro le altre donne. Diventa perciò fonda-
mentale non solo il rispetto per i tempi e i modi di tutte, ma anche il bisogno di
gratificazione e di approvazione, tanto più necessarie quanto più si negano quelle
maschili. I l rifiuto del conflitto fra donne, fondato sulla consapevolezza delle sof-
ferenze subite ad opera di altri e sull'implicito e profondo impegno a non essere
noi a farci del male, contiene in realtà anche il bisogno di un sostegno comune,
la paura di perdere il gruppo come fonte d'identificazione e di difesa dall'esterno.
L'esplosione della contraddizione appare come una minaccia per la sicurezza che
abbiamo appena cominciato a costruire: si ricerca e si comunica solo quello che
ci unisce, secondo criteri di compatibilità più o meno rigidi, ma sempre discrimi-
nanti; si ricreanomeccanismi in base ai quali qualcuna assume il ruolo del capro
espiatorio, di quella «meno uguale» delle altre. Nonostante il nostro profondo
impegno e la «sincerità» con cui viviamo questi passaggi, l'identità tra donne di-
venta non più la lenta scoperta di noi stesse, ma l'appiattimento in una presunta
uguaglianza che impedisce una reale critica egualitaria.
Si sviluppa perciò solamente la tendenza, considerata tradizionalmente «fem-
minile» verso la conoscenza come rapporto d'identità: quel rapporto che trovia-
mo sintetizzato, in termini tanto suggestivi quanto ambigui, nell'affermazione che
«per la donna il marchio della vita è nell'essere entro la comunità e non nell'azio-
ne all'interno di essa; per lei non è decisivo parlare, ma mangiare allo stesso ta-
volo, non il confronto e la conversazione, ma l'essere insieme e vicini» (Neu-
mann, Gli stadi psicologici dello sviluppo femminile). La solidarietà nella ricerca
di se stesse rischia continuamente di trasformarsi nella ricerca della solidarietà,
mentre tutte le contraddizioni vengono spostate all'esterno, nello scontro con il
maschile. I n questa situazione, noi viviamo la rassicurazione dell'amore tra le
donne come un bisogno vitale e al tempo stesso come una conquista precaria, di
cui è difficile e raro sentire la profondità e la continuità. Non a caso la rassicura-
zione come bisogno e come pratica si esprime ai suoi livelli più alti in occasioni
rituali e spettacolari, in momenti di provocazione, attacco o difesa dall'esterno,
dal maschile. In queste occasioni anche l'amore deve farsi visibile, spettacolare,
per poter assolvere i compiti che gli venivano assegnati. Nascono allora una serie
di formule esteriori, di modelli di comportamento, di travestimenti ormai istitu-
zionalizzati e consacrati dalla tradizione femminista che sanciscono da un lato la
nostra diversità dall'esterno, dall'altro la nostra uguaglianza anche formale.
Nascono una sorta di creazioni magico-religiose, in cui i l sacro (in questo
caso il femminile) considerato come trasmissibile per contatto e identità (i trave-
stimenti, i girotondi) è espresso da rituali di separazione e di demarcazione (grup-
- 76 -
















