
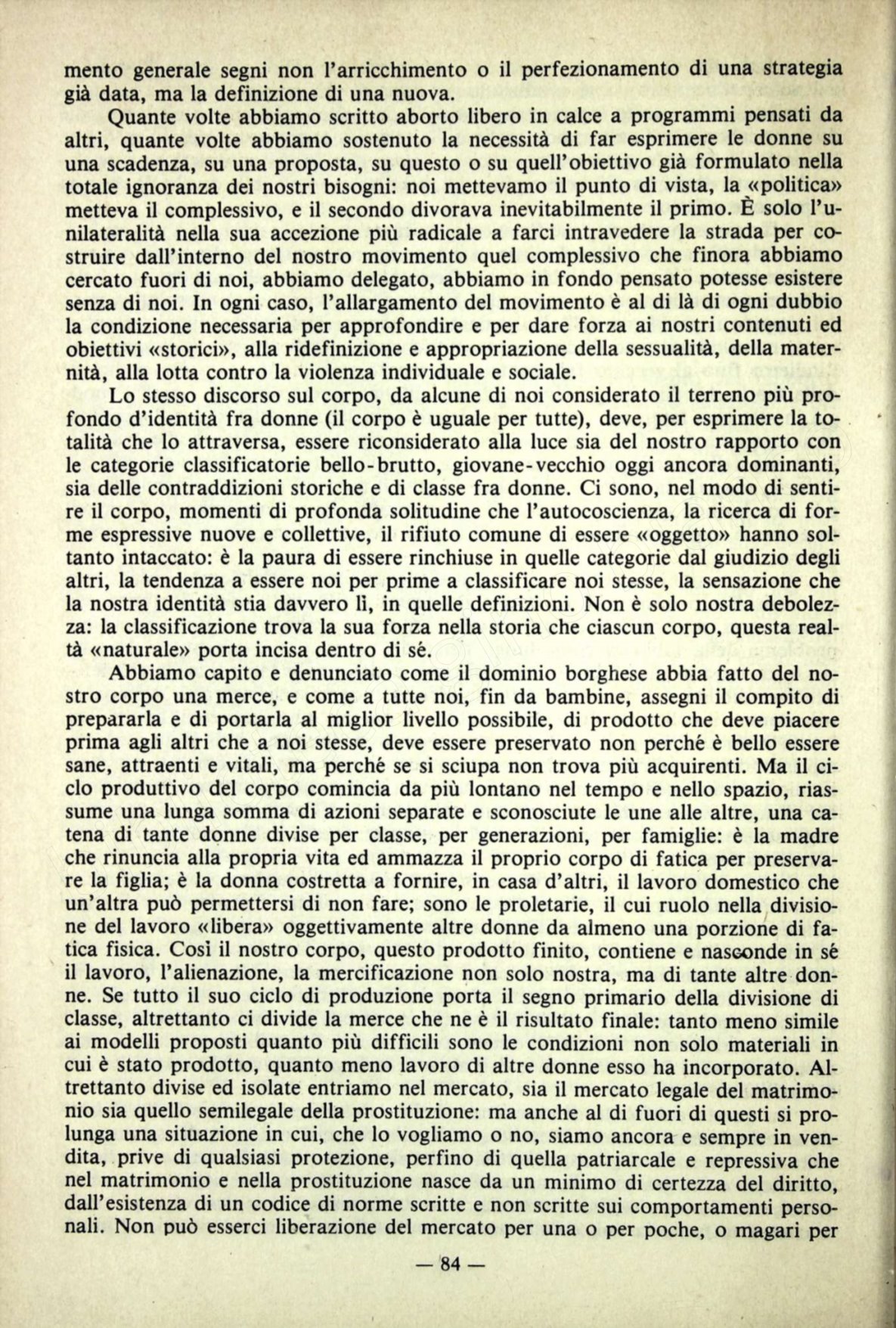
mento generale segni non l'arricchimento o il perfezionamento di una strategia
già data, ma la definizione di una nuova.
Quante volte abbiamo scritto aborto libero in calce a programmi pensati da
altri, quante volte abbiamo sostenuto la necessità di far esprimere le donne su
una scadenza, su una proposta, su questo o su quell'obiettivo già formulato nella
totale ignoranza dei nostri bisogni: noi mettevamo il punto di vista, la «politica»
metteva il complessivo, e il secondo divorava inevitabilmente il primo. È solo l'u-
nilateralità nella sua accezione più radicale a farci intravedere la strada per co-
struire dall'interno del nostro movimento quel complessivo che finora abbiamo
cercato fuori di noi, abbiamo delegato, abbiamo in fondo pensato potesse esistere
senza di noi. In ogni caso, l'allargamento del movimento è al di là di ogni dubbio
la condizione necessaria per approfondire e per dare forza ai nostri contenuti ed
obiettivi «storici», alla ridefinizione e appropriazione della sessualità, della mater-
nità, alla lotta contro la violenza individuale e sociale.
Lo stessodiscorso sul corpo, da alcune di noi considerato il terreno più pro-
fondo d'identità fra donne (il corpo è uguale per tutte), deve, per esprimere la to-
talità che lo attraversa, essere riconsiderato alla luce sia del nostro rapporto con
le categorie classificatorie bello-brutto, giovane-vecchio oggi ancora dominanti,
siadelle contraddizioni storiche e di classe fra donne. Ci sono, nel modo di senti-
re il corpo, momenti di profonda solitudine che l'autocoscienza, la ricerca di for-
meespressive nuove e collettive, il rifiuto comune di essere «oggetto» hanno sol-
tanto intaccato: è la paura di essere rinchiuse in quelle categorie dal giudizio degli
altri, la tendenza a essere noi per prime a classificare noi stesse, la sensazione che
la nostra identità stia davvero li, in quelle definizioni. Non è solo nostra debolez-
za: la classificazione trova la sua forza nella storia che ciascun corpo, questa real-
tà «naturale» porta incisa dentro di sé.
Abbiamo capito e denunciato come il dominio borghese abbia fatto del no-
stro corpo una merce, e come a tutte noi, fin da bambine, assegni il compito di
prepararla e di portarla al miglior livello possibile, di prodotto che deve piacere
prima agli altri che a noi stesse, deve essere preservato non perché è bello essere
sane, attraenti e vitali, ma perché se si sciupa non trova più acquirenti. Ma il ci-
clo produttivo del corpo comincia da più lontano nel tempo e nello spazio, rias-
sumeuna lunga somma di azioni separate e sconosciute le une alle altre, una ca-
tena di tante donne divise per classe, per generazioni, per famiglie: è la madre
che rinuncia alla propria vita ed ammazza il proprio corpo di fatica per preserva-
re la figlia; è la donna costretta a fornire, in casa d'altri, il lavoro domestico che
un'altra può permettersi di non fare; sono le proletarie, il cui ruolo nella divisio-
ne del lavoro «libera» oggettivamente altre donne da almeno una porzione di fa-
tica fisica. Così il nostro corpo, questo prodotto finito, contiene e nasconde in sé
il lavoro, l'alienazione, la mercificazione non solo nostra, ma di tante altre don-
ne. Se tutto il suo ciclo di produzione porta il segno primario della divisione di
classe, altrettanto ci divide la merce che ne è il risultato finale: tanto meno simile
ai modelli proposti quanto più difficili sono le condizioni non solo materiali in
cui è stato prodotto, quanto meno lavoro di altre donne esso ha incorporato. Al-
trettanto divise ed isolate entriamo nel mercato, sia il mercato legale del matrimo-
nio sia quello semilegale della prostituzione: ma anche al di fuori di questi si pro-
lunga una situazione in cui, che lo vogliamo o no, siamo ancora e sempre in ven-
dita, prive di qualsiasi protezione, perfino di quella patriarcale e repressiva che
nel matrimonio e nella prostituzione nasce da un minimo di certezza del diritto,
dall'esistenza di un codice di norme scritte e non scritte sui comportamenti perso-
nali. Non può esserci liberazione del mercato per una o per poche, o magari per
—84
















