
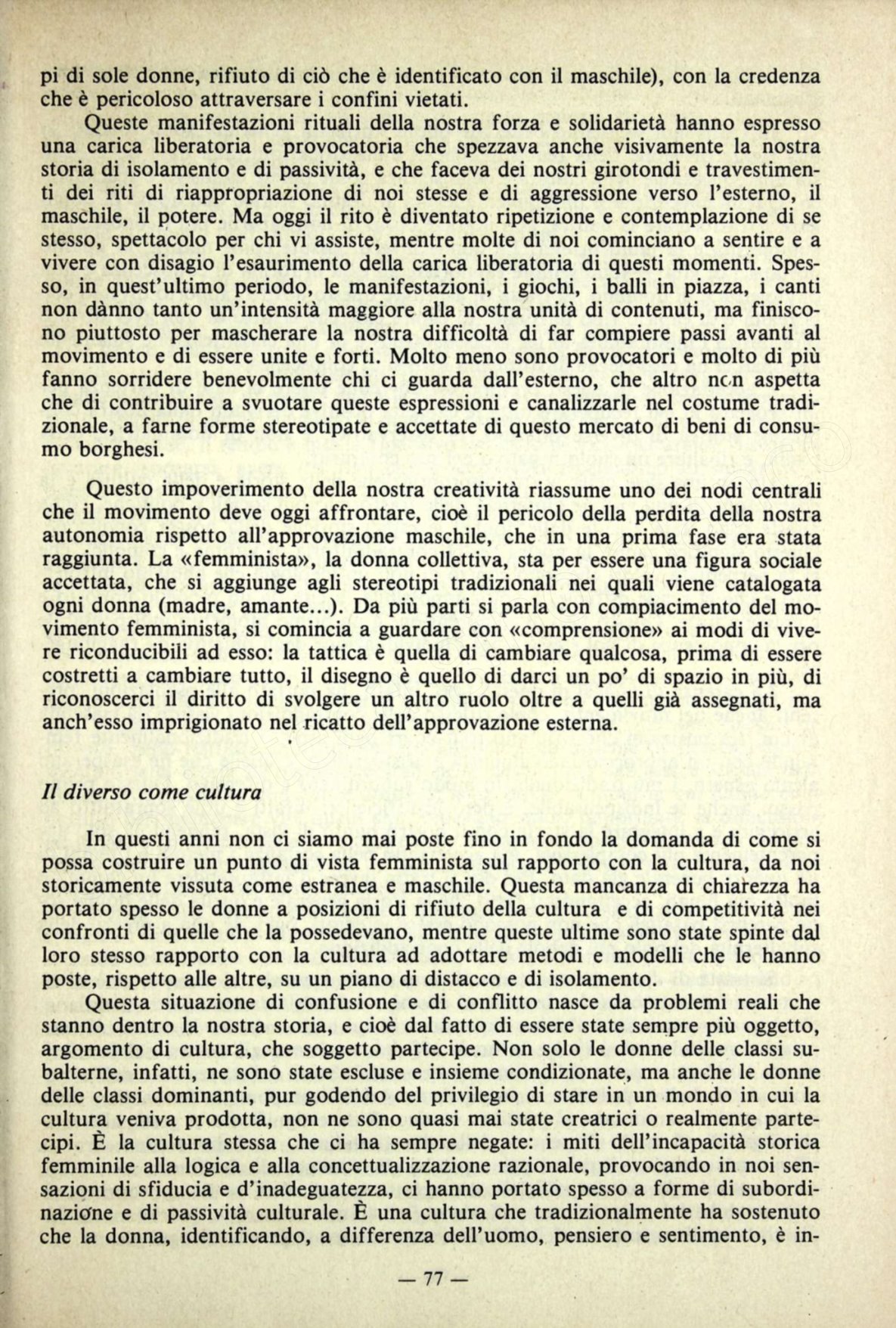
pi di sole donne, rifiuto di ciò che è identificato con il maschile), con la credenza
cheèpericoloso attraversare i confini vietati.
Questemanifestazioni rituali della nostra forza e solidarietà hanno espresso
una carica liberatoria e provocatoria che spezzava anche visivamente la nostra
storia di isolamento e di passività, e che faceva dei nostri girotondi e travestimen-
ti dei riti di riappropriazione di noi stesse e di aggressione verso l'esterno, i l
maschile, il potere. Ma oggi il rito è diventato ripetizione e contemplazione di se
stesso, spettacolo per chi vi assiste, mentre molte di noi cominciano a sentire e a
vivere con disagio l'esaurimento della carica liberatoria di questi momenti. Spes-
so, in quest'ultimo periodo, le manifestazioni, i giochi, i balli in piazza, i canti
nondànno tanto un'intensitàmaggiore alla nostra unità di contenuti, ma finisco-
no piuttosto per mascherare la nostra difficoltà di far compiere passi avanti al
movimento e di essereunite e forti. Molto menosono provocatori e molto di più
fanno sorridere benevolmente chi ci guarda dall'esterno, che altro nen aspetta
che di contribuire a svuotare questeespressioni e canalizzarle nel costume tradi-
zionale, a farne forme stereotipate e accettate di questomercato di beni di consu-
moborghesi.
Questo impoverimento della nostra creatività riassume uno dei nodi centrali
che il movimento deve oggi affrontare, cioè il pericolo della perdita della nostra
autonomia rispetto all'approvazione maschile, che in una prima fase era stata
raggiunta. La «femminista», la donna collettiva, sta per essereuna figura sociale
accettata, che si aggiunge agli stereotipi tradizionali nei quali viene catalogata
ogni donna (madre, amante...). Da più parti si parla con compiacimento del mo-
vimento femminista, si comincia a guardare con «comprensione» ai modi di vive-
re riconducibili ad esso: la tattica è quella di cambiare qualcosa, prima di essere
costretti a cambiare tutto, il disegno è quello di darci un po' di spazio in più, di
riconoscerci il diritto di svolgere un altro ruolo oltre a quelli già assegnati, ma
anch'esso imprigionato nel ricatto dell'approvazione esterna.
Il diverso come cultura
In questi anni non ci siamo mai poste fino in fondo la domanda di come si
possacostruire un punto di vista femminista sul rapporto con la cultura, da noi
storicamentevissuta come estranea e maschile. Questamancanza di chiarezza ha
portatospesso le donne a posizioni di rifiuto della cultura e di competitività nei
confronti di quelle che la possedevano, mentre queste ultime sonostate spinte dal
lorostesso rapporto con la cultura ad adottare metodi e modelli che le hanno
poste, rispetto alle altre, su un piano di distacco e di isolamento.
Questa situazione di confusione e di conflitto nasce da problemi reali che
stannodentro la nostra storia, e cioè dal fatto di esserestatesempre più oggetto,
argomento di cultura, che soggetto partecipe. Non solo le donne delle classi su-
balterne, infatti, ne sono stateescluse e insieme condizionate, ma anche le donne
delleclassi dominanti, pur godendo del privilegio di stare in un mondo in cui la
cultura veniva prodotta, non ne sono quasi mai state creatrici o realmente parte-
cipi. È la cultura stessa che ci ha sempre negate: i miti dell'incapacità storica
femminile alla logica e alla concettualizzazione razionale, provocando in noi sen-
sazioni di sfiducia e d'inadeguatezza, ci hanno portatospesso a forme di subordi-
naziane e di passività culturale. È una cultura che tradizionalmente ha sostenuto
che la donna, identificando, a differenza dell'uomo, pensiero e sentimento, è in-
77
















