
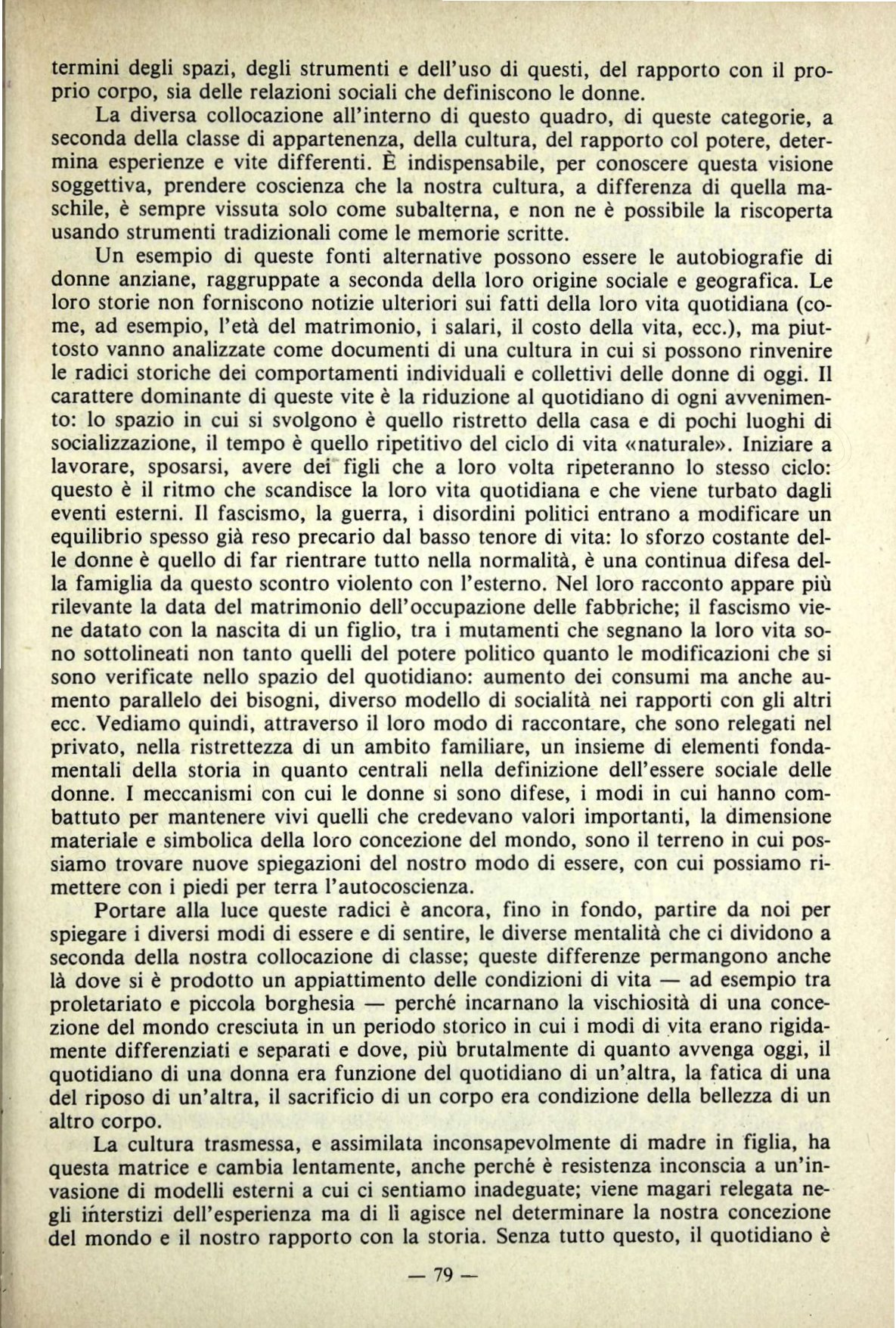
termini degli spazi, degli strumenti e dell'uso di questi, del rapporto con il pro-
prio corpo, sia delle relazioni sociali che definiscono le donne.
La diversa collocazione all'interno di questo quadro, di queste categorie, a
seconda della classe di appartenenza, della cultura, del rapporto col potere, deter-
mina esperienze e vite differenti. È indispensabile, per conoscere questa visione
soggettiva, prendere coscienza che la nostra cultura, a differenza di quella ma-
schile, è sempre vissuta solo come subalterna, e non ne è possibile la riscoperta
usando strumenti tradizionali come le memorie scritte.
Un esempio di queste fonti alternative possono essere le autobiografie di
donne anziane, raggruppate a seconda della loro origine sociale e geografica. Le
loro storie non forniscono notizie ulteriori sui fatti della loro vita quotidiana (co-
me, ad esempio, l'età del matrimonio, i salari, il costo della vita, ecc.), ma piut-
tosto vanno analizzate come documenti di una cultura in cui si possono rinvenire
le radici storiche dei comportamenti individuali e collettivi delle donne di oggi. I l
carattere dominante di queste vite è la riduzione al quotidiano di ogni avvenimen-
to: lo spazio in cui si svolgono è quello ristretto della casa e di pochi luoghi di
socializzazione, il tempo è quello ripetitivo del ciclo di vita «naturale». Iniziare a
lavorare, sposarsi, avere dei figli che a loro volta ripeteranno lo stesso ciclo:
questo è il ritmo che scandisce la loro vita quotidiana e che viene turbato dagli
eventi esterni. I l fascismo, la guerra, i disordini politici entrano a modificare un
equilibrio spesso già reso precario dal basso tenore di vita: lo sforzo costante del-
le donne è quello di far rientrare tutto nella normalità, è una continua difesa del-
la famiglia da questo scontro violento con l'esterno. Nel loro racconto appare più
rilevante la data del matrimonio dell'occupazione delle fabbriche; il fascismo vie-
ne datato con la nascita di un figlio, tra i mutamenti che segnano la loro vita so-
no sottolineati non tanto quelli del potere politico quanto le modificazioni che si
sono verificate nello spazio del quotidiano: aumento dei consumi ma anche au-
mento parallelo dei bisogni, diverso modello di socialità nei rapporti con gli altri
ecc. Vediamo quindi, attraverso il loro modo di raccontare, che sono relegati nel
privato, nella ristrettezza di un ambito familiare, un insieme di elementi fonda-
mentali della storia in quanto centrali nella definizione dell'essere sociale delle
donne. I meccanismi con cui le donne si sono difese, i modi in cui hanno com-
battuto per mantenere vivi quelli che credevano valori importanti, la dimensione
materiale e simbolica della loro concezione del mondo, sono il terreno in cui pos-
siamo trovare nuove spiegazioni del nostro modo di essere, con cui possiamo ri-
mettere con i piedi per terra l'autocoscienza.
Portare alla luce queste radici è ancora, fino in fondo, partire da noi per
spiegare i diversi modi di essere e di sentire, le diverse mentalità che ci dividono a
seconda della nostra collocazione di classe; queste differenze permangono anche
là dove si è prodotto un appiattimento delle condizioni di vita — ad esempio tra
proletariato e piccola borghesia — perché incarnano la vischiosità di una conce-
zione del mondo cresciuta in un periodo storico in cui i modi di vita erano rigida-
mente differenziati e separati e dove, più brutalmente di quanto avvenga oggi, il
quotidiano di una donna era funzione del quotidiano di un'altra, la fatica di una
del riposo di un'altra, il sacrificio di un corpo era condizione della bellezza di un
altro corpo.
La cultura trasmessa, e assimilata inconsapevolmente di madre in figlia, ha
questa matrice e cambia lentamente, anche perché è resistenza inconscia a un'in-
vasione di modelli esterni a cui ci sentiamo inadeguate; viene magari relegata ne-
gli interstizi dell'esperienza ma di li agisce nel determinare la nostra concezione
del mondo e il nostro rapporto con la storia. Senza tutto questo, il quotidiano è
—79
















