
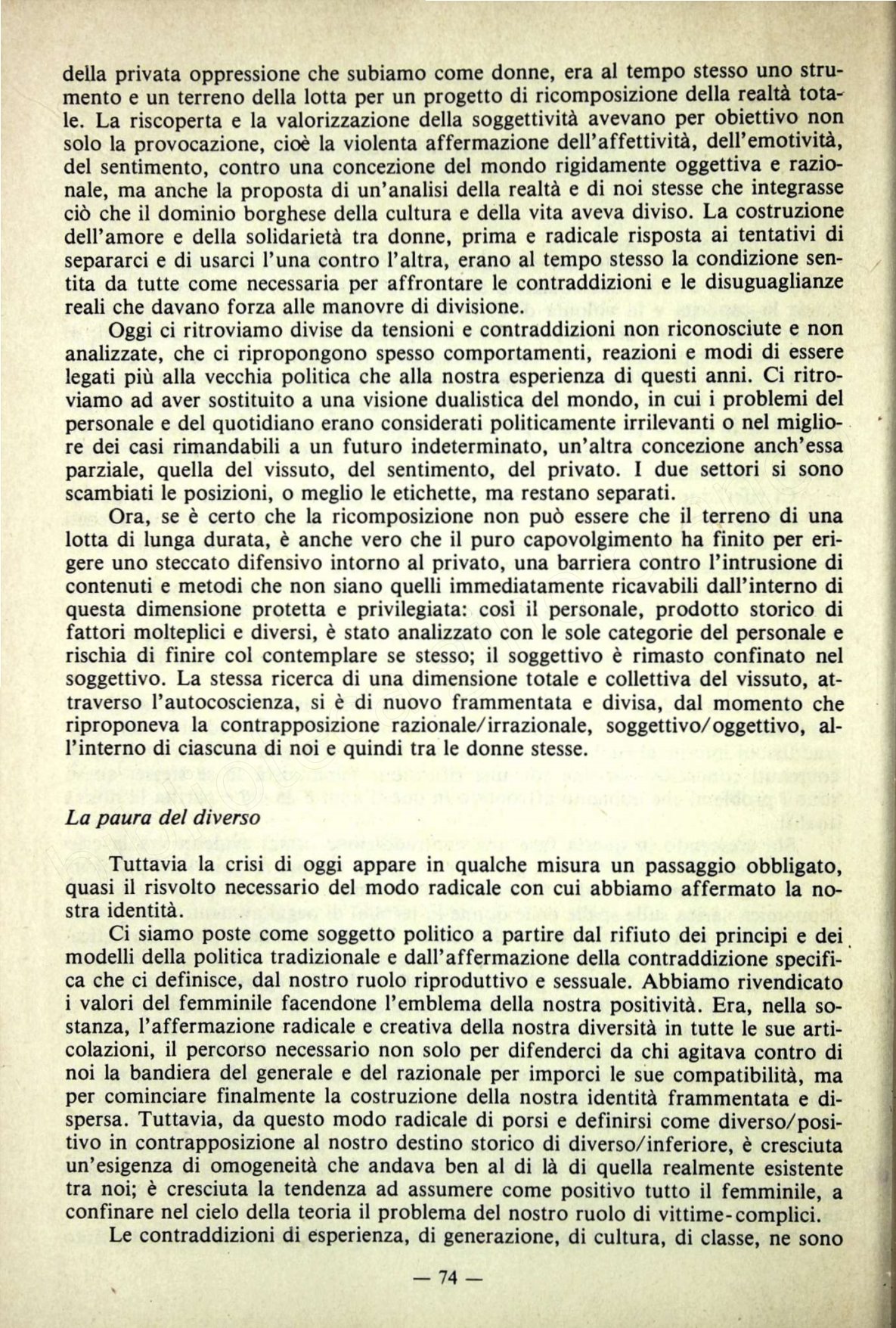
della privata oppressione che subiamo come donne, era al tempo stesso uno stru-
mento e un terreno della lotta per un progetto di ricomposizione della realtà tota-
le. La riscoperta e la valorizzazione della soggettività avevano per obiettivo non
solo la provocazione, cioè la violenta affermazione dell'affettività, dell'emotività,
del sentimento, contro una concezione del mondo rigidamente oggettiva e razio-
nale, ma anche la proposta di un'analisi della realtà e di noi stesse che integrasse
ciò che il dominio borghese della cultura e della vita aveva diviso. La costruzione
dell'amore e della solidarietà tra donne, prima e radicale risposta ai tentativi di
separarci e di usarci l'una contro l'altra, erano al tempo stesso la condizione sen-
tita da tutte come necessaria per affrontare le contraddizioni e le disuguaglianze
reali che davano forza alle manovre di divisione.
Oggi ci ritroviamo divise da tensioni e contraddizioni non riconosciute e non
analizzate, che ci ripropongono spesso comportamenti, reazioni e modi di essere
legati più alla vecchia politica che alla nostra esperienza di questi anni. Ci ritro-
viamo ad aver sostituito a una visione dualistica del mondo, in cui i problemi del
personale e del quotidiano erano considerati politicamente irrilevanti o nel miglio-
re dei casi rimandabili a un futuro indeterminato, un'altra concezione anch'essa
parziale, quella del vissuto, del sentimento, del privato. I due settori si sono
scambiati le posizioni, o meglio le etichette, ma restano separati.
Ora, se è certo che la ricomposizione non può essere che il terreno di una
lotta di lunga durata, è anche vero che il puro capovolgimento ha finito per eri-
gere uno steccato difensivo intorno al privato, una barriera contro l'intrusione di
contenuti e metodi che non siano quelli immediatamente ricavabili dall'interno di
questa dimensione protetta e privilegiata: cosi il personale, prodotto storico di
fattori molteplici e diversi, è stato analizzato con le sole categorie del personale e
rischia di finire col contemplare se stesso; i l soggettivo è rimasto confinato nel
soggettivo. La stessa ricerca di una dimensione totale e collettiva del vissuto, at-
traverso l'autocoscienza, si è di nuovo frammentata e divisa, dal momento che
riproponeva la contrapposizione razionale/irrazionale, soggettivo/oggettivo, al-
l'interno di ciascuna di noi e quindi tra le donne stesse.
La paura del diverso
Tuttavia la crisi di oggi appare in qualche misura un passaggio obbligato,
quasi il risvolto necessario del modo radicale con cui abbiamo affermato la no-
stra identità.
Ci siamo poste come soggetto politico a partire dal rifiuto dei principi e dei i
modelli della politica tradizionale e dall'affermazione della contraddizione specifi-
cache ci definisce, dal nostro ruolo riproduttivo e sessuale. Abbiamo rivendicato
i valori del femminile facendone l'emblema della nostra positività. Era, nella so-
stanza, l'affermazione radicale e creativa della nostra diversità in tutte le sue arti-
colazioni, il percorso necessario non solo per difenderci da chi agitava contro di
noi la bandiera del generale e del razionale per imporci le sue compatibilità, ma
per cominciare finalmente la costruzione della nostra identità frammentata e di-
spersa. Tuttavia, da questo modo radicale di porsi e definirsi come diverso/posi-
tivo in contrapposizione al nostro destino storico di diverso/inferiore, è cresciuta
un'esigenza di omogeneità che andava ben al di là di quella realmente esistente
tra noi; è cresciuta la tendenza ad assumere come positivo tutto il femminile, a
confinare nel cielo della teoria il problema del nostro ruolo di vittime-complici.
Le contraddizioni di esperienza, di generazione, di cultura, di classe, ne sono
















