
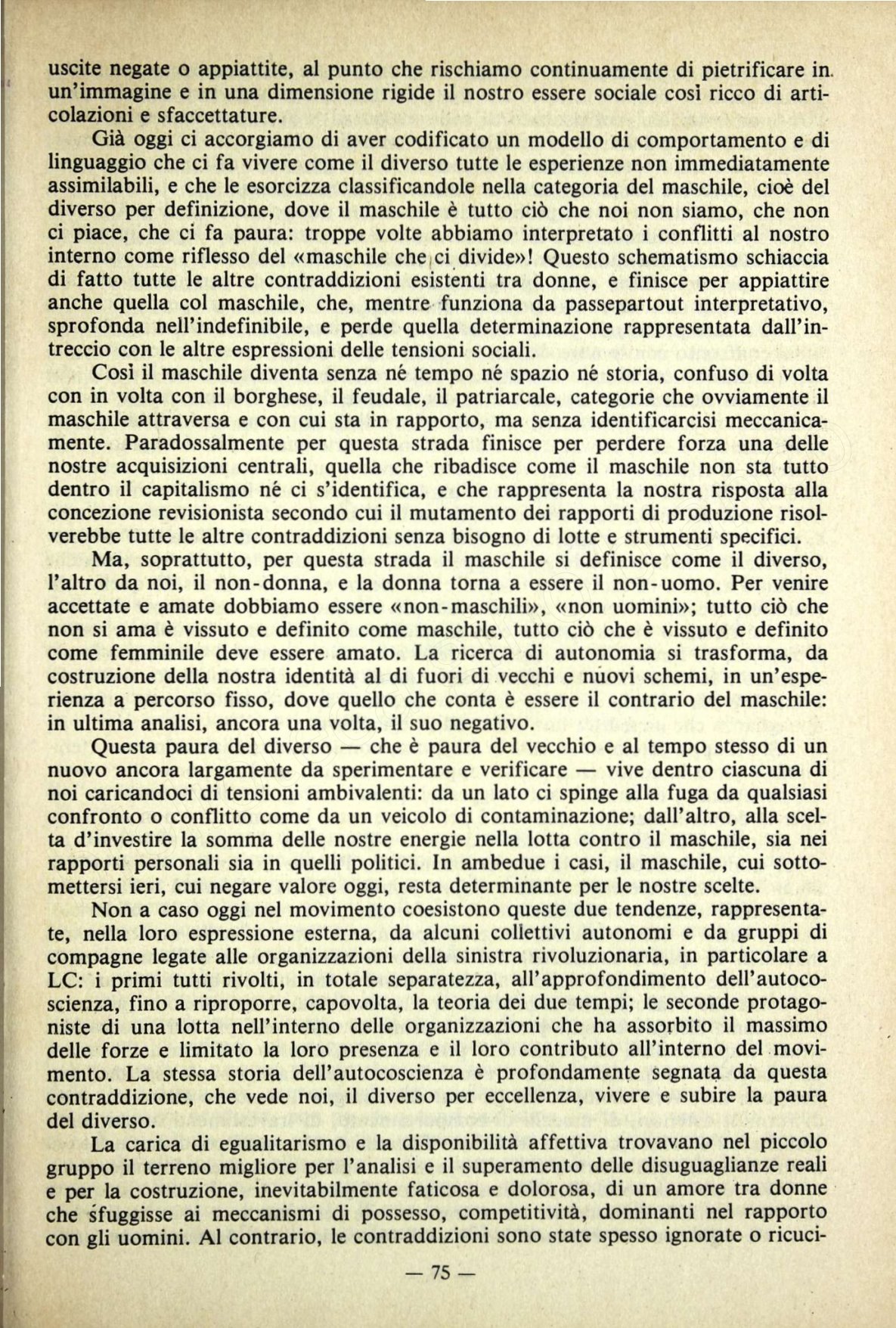
4
uscitenegate o appiattite, al punto che rischiamo continuamente di pietrificare in.
un'immagine e in una dimensione rigide il nostroesseresociale così ricco di arti-
colazioni e sfaccettature.
Già oggi ci accorgiamo di aver codificato unmodello di comportamento e di
linguaggioche ci fa vivere come il diverso tutte le esperienze non immediatamente
assimilabili, e che le esorcizza classificandole nella categoria del maschile, cioè del
diverso per definizione, dove il maschile è tutto ciò che noi non siamo, che non
ci piace, che ci fa paura: troppe volte abbiamo interpretato i conflitti al nostro
interno come riflesso del «maschile che, ci divide»! Questo schematismoschiaccia
di fatto tutte le altre contraddizioni esistenti tra donne, e finisce per appiattire
anche quella col maschile, che, mentre• funziona da passepartout interpretativo,
sprofonda nell'indefinibile, e perde quella determinazione rappresentata dall'in-
treccio con le altre espressioni delle tensioni sociali.
Così il maschile diventa senza né tempo né spazio né storia, confuso di volta
con in volta con il borghese, il feudale, il patriarcale, categorie che ovviamente il
maschileattraversa e con cui sta in rapporto, ma senza identificarcisi meccanica-
mente. Paradossalmente per questa strada finisce per perdere forza una delle
nostre acquisizioni centrali, quella che ribadisce come il maschile non sta tutto
dentro il capitalismo né ci s'identifica, e che rappresenta la nostra risposta alla
concezione revisionistasecondo cui il mutamento dei rapporti di produzione risol-
verebbe tutte le altre contraddizioni senzabisogno di lotte e strumenti specifici.
Ma, soprattutto, per questa strada il maschile si definisce come il diverso,
l'altro da noi, il non-donna, e la donna torna a essere il non-uomo. Per venire
accettate e amate dobbiamoessere «non-maschili», «non uomini»; tutto ciò che
non si ama è vissuto e definito comemaschile, tutto ciò che è vissuto e definito
come femminile deve essere amato. La ricerca di autonomia si trasforma, da
costruzione della nostra identità al di fuori di vecchi e núovi schemi, in un'espe-
rienza a percorso fisso, dove quello che conta è essere il contrario del maschile:
in ultima analisi, ancora una volta, il suonegativo.
Questa paura del diverso — che è paura del vecchio e al tempostesso di un
nuovo ancora largamente da sperimentare e verificare — vive dentro ciascuna di
noi caricandoci di tensioni ambivalenti: da un lato ci spinge alla fuga da qualsiasi
confronto o conflitto come da un veicolo di contaminazione; dall'altro, alla scel-
ta d'investire la somma delle nostre energie nella lotta contro il maschile, sia nei
rapporti personali sia in quelli politici. In ambedue i casi, il maschile, cui sotto-
mettersi ieri, cui negare valore oggi, resta determinante per le nostre scelte.
Non a casooggi nel movimentocoesistonoquestedue tendenze, rappresenta-
te, nella loro espressione esterna, da alcuni collettivi autonomi e da gruppi di
compagne legate alle organizzazioni della sinistra rivoluzionaria, in particolare a
LC: i primi tutti rivolti, in totale separatezza, all'approfondimento dell'autoco-
scienza, fino a riproporre, capovolta, la teoria dei due tempi; le secondeprotago-
niste di una lotta nell'interno delle organizzazioni che ha assorbito il massimo
delle forze e limitato la loro presenza e il loro contributo all'interno del movi-
mento. La stessa storia dell'autocoscienza è profondamente segnata da questa
contraddizione, che vede noi, il diverso per eccellenza, vivere e subire la paura
del diverso.
La carica di egualitarismo e la disponibilità affettiva trovavano nel piccolo
gruppo il terreno migliore per l'analisi e il superamento delle disuguaglianze reali
eper la costruzione, inevitabilmente faticosa e dolorosa, di un amore tra donne•
chegfuggisse ai meccanismi di possesso, competitività, dominanti nel rapporto
con gli uomini. Al contrario, le contraddizioni sono statespesso ignorate o ricuci-
75
















