
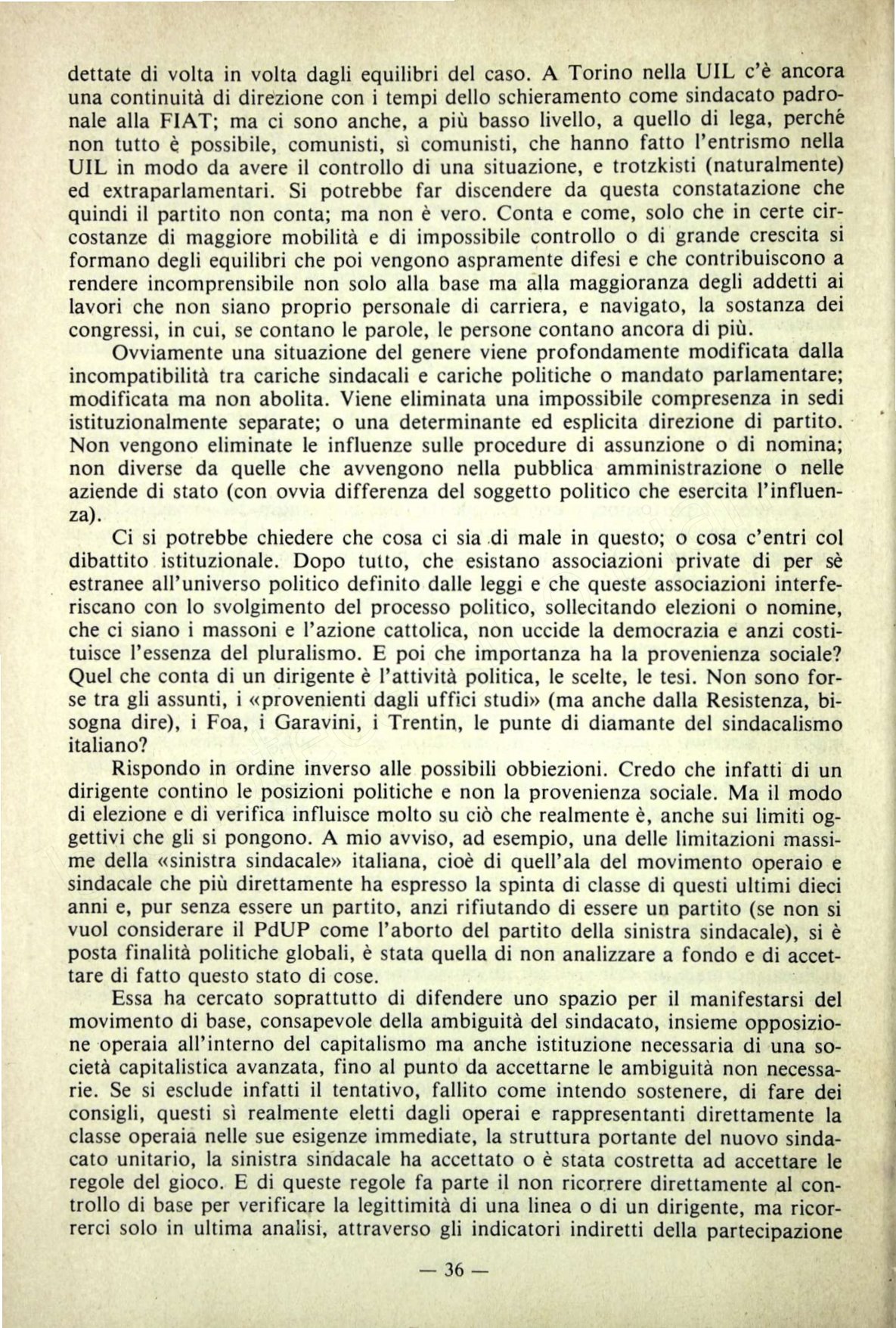
dettate di volta in volta dagli equilibri del caso. A Torino nella UIL c'è ancora
una continuità di direzione con i tempi dello schieramento come sindacato padro-
nale alla FIAT; ma ci sono anche, a più basso livello, a quello di lega, perché
non tutto e possibile, comunisti, sì comunisti, che hanno fatto l'entrismo nella
UIL in modo da avere il controllo di una situazione, e trotzkisti (naturalmente)
ed extraparlamentari. Si potrebbe far discendere da questa constatazione che
quindi il partito non conta; ma non è vero. Conta e come, solo che in certe cir-
costanze di maggiore mobilità e di impossibile controllo o di grande crescita si
formano degli equilibri che poi vengono aspramente difesi e che contribuiscono a
rendere incomprensibile non solo alla base ma alla maggioranza degli addetti ai
lavori che non siano proprio personale di carriera, e navigato, la sostanza dei
congressi, in cui, se contano le parole, le persone contano ancora di più.
Ovviamente una situazione del genere viene profondamente modificata dalla
incompatibilità tra cariche sindacali e cariche politiche o mandato parlamentare;
modificata ma non abolita. Viene eliminata una impossibile compresenza in sedi
istituzionalmente separate; o una determinante ed esplicita direzione di partito.
Non vengono eliminate le influenze sulle procedure di assunzione o di nomina;
non diverse da quelle che avvengono nella pubblica amministrazione o nelle
aziende di stato (con ovvia differenza del soggetto politico che esercita l'influen-
za).
Ci si potrebbe chiedere che cosa ci sia .di male in questo; o cosa c'entri col
dibattito istituzionale. Dopo tutto, che esistano associazioni private di per sè
estranee all'universo politico definito dalle leggi e che queste associazioni interfe-
riscano con lo svolgimento del processo politico, sollecitando elezioni o nomine,
che ci siano i massoni e l'azione cattolica, non uccide la democrazia e anzi costi-
tuisce l'essenza del pluralismo. E poi che importanza ha la provenienza sociale?
Quel che conta di un dirigente è l'attività politica, le scelte, le tesi. Non sono for-
setra gli assunti, i «provenienti dagli uffici studi» (ma anche dalla Resistenza, bi-
sogna dire), i Foa, i Garavini, i Trentiri, le punte di diamante del sindacalismo
italiano?
Rispondo in ordine inverso alle possibili obbiezioni. Credo che infatti di un
dirigente contino le posizioni politiche e non la provenienza sociale. Ma il modo
di elezione e di verifica influisce molto su ciò che realmente è, anche sui limiti og-
gettivi che gli si pongono. A mio avviso, ad esempio, una delle limitazioni massi-
medella «sinistra sindacale» italiana, cioè di quell'ala del movimento operaio e
sindacale che più direttamente ha espresso la spinta di classe di questi ultimi dieci
anni e, pur senzaessere un partito, anzi rifiutando di essere un partito (se non si
vuol considerare il PdUP come l'aborto del partito della sinistra sindacale), si è
posta finalità politiche globali, è stata quella di non analizzare a fondo e di accet-
tare di fatto questo stato di cose.
Essa ha cercato soprattutto di difendere uno spazio per il manifestarsi del
movimento di base, consapevole della ambiguità del sindacato, insieme opposizio-
neoperaia all'interno del capitalismo ma anche istituzione necessaria di una so-
cietà capitalistica avanzata, fino al punto da accettarne le ambiguità non necessa-
rie. Se si esclude infatti il tentativo, fallito come intendo sostenere, di fare dei
consigli, questi sì realmente eletti dagli operai e rappresentanti direttamente la
classeoperaia nelle sueesigenze immediate, la struttura portante del nuovo sinda-
cato unitario, la sinistra sindacale ha accettato o è stata costretta ad accettare le
regole del gioco. E di queste regole fa parte il non ricorrere direttamente al con-
trollo di base per verificare la legittimità di una linea o di un dirigente, ma ricor-
rerci solo in ultima analisi, attraverso gli indicatori indiretti della partecipazione
36
















