
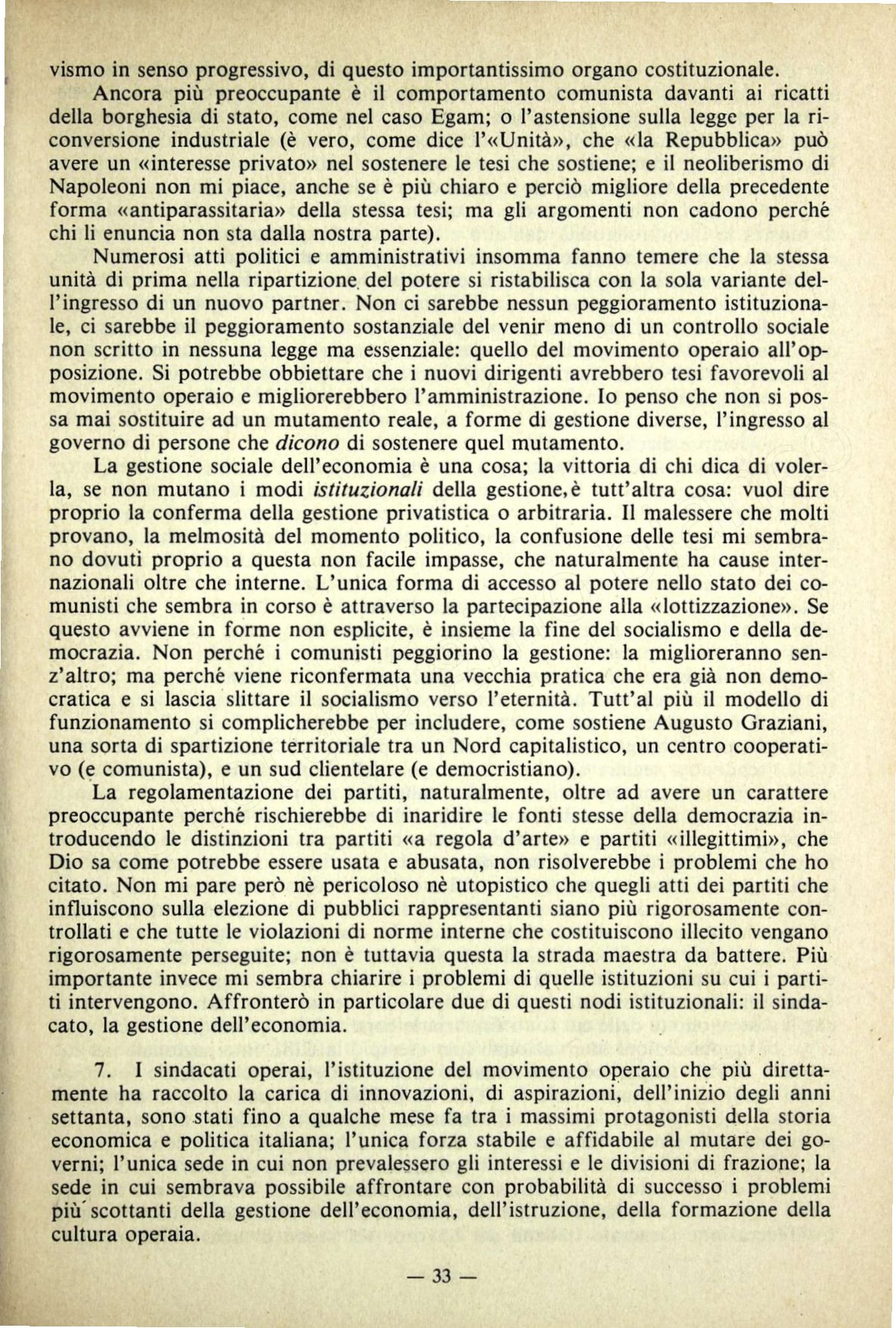
vismo in sensoprogressivo, di questo importantissimo organo costituzionale.
Ancora più preoccupante è i l comportamento comunista davanti ai ricatti
della borghesia di stato, come nel caso Egam; o l'astensione sulla legge per la ri-
conversione industriale (è vero, come dice l'«Unità», che «la Repubblica» può
avere un «interesse privato» nel sostenere le tesi che sostiene; e il neoliberismo di
Napoleoni non mi piace, anche se è più chiaro e perciò migliore della precedente
forma «antiparassitaria» della stessa tesi; ma gli argomenti non cadono perché
chi li enuncia non sta dalla nostra parte).
Numerosi atti politici e amministrativi insomma fanno temere che la stessa
unità di prima nella ripartizione, del potere si ristabilisca con la sola variante del-
l'ingresso di un nuovo partner. Non ci sarebbe nessun peggioramento istituziona-
le, ci sarebbe il peggioramento sostanziale del venir meno di un controllo sociale
non scritto in nessuna legge ma essenziale: quello del movimento operaio all'op-
posizione. Si potrebbe obbiettare che i nuovi dirigenti avrebbero tesi favorevoli al
movimento operaio e migliorerebbero l'amministrazione. Io penso che non si pos-
samai sostituire ad un mutamento reale, a forme di gestione diverse, l'ingresso al
governo di persone che
dicono
di sostenere quel mutamento.
La gestione sociale dell'economia è una cosa; la vittoria di chi dica di voler-
la, se non mutano i modi
istituzionali
della gestione, è tutt'altra cosa: vuol dire
proprio la conferma della gestione privatistica o arbitraria. I l malessere che molti
provano, la melmosità del momento politico, la confusione delle tesi mi sembra-
no dovuti proprio a questa non facile impasse, che naturalmente ha cause inter-
nazionali oltre che interne. L'unica forma di accesso al potere nello stato dei co-
munisti che sembra in corso è attraverso la partecipazione alla «lottizzazione». Se
questo avviene in forme non esplicite, è insieme la fine del socialismo e della de-
mocrazia. Non perché i comunisti peggiorino la gestione: la miglioreranno sen-
z'altro; ma perché viene riconfermata una vecchia pratica che era già non demo-
cratica e si lascia slittare il socialismo verso l'eternità. Tutt'al più il modello di
funzionamento si complicherebbe per includere, come sostieneAugusto Graziani,
una sorta di spartizione territoriale tra un Nord capitalistico, un centro cooperati-
vo (e comunista), e un sud clientelare (e democristiano).
La regolamentazione dei partiti, naturalmente, oltre ad avere un carattere
preoccupante perché rischierebbe di inaridire le fonti stesse della democrazia in-
troducendo le distinzioni tra partiti «a regola d'arte» e partiti «illegittimi», che
Dio sa come potrebbe essere usata e abusata, non risolverebbe i problemi che ho
citato. Non mi pare però nè pericoloso nè utopistico che quegli atti dei partiti che
influiscono sulla elezione di pubblici rappresentanti siano più rigorosamente con-
trollati e che tutte le violazioni di norme interne che costituiscono illecito vengano
rigorosamente perseguite; non è tuttavia questa la strada maestra da battere. Più
importante invece mi sembra chiarire i problemi di quelle istituzioni su cui i parti-
ti intervengono. Affronterò in particolare due di questi nodi istituzionali: il sinda-
cato, la gestione dell'economia.
7. I sindacati operai, l'istituzione del movimento operaio che più diretta-
mente ha raccolto la carica di innovazioni, di aspirazioni, dell'inizio degli anni
settanta, sono stati fino a qualchemese fa tra i massimi protagonisti della storia
economica e politica italiana; l'unica forza stabile e affidabile al mutare dei go-
verni; l'unica sede in cui non prevalessero gli interessi e le divisioni di frazione; la
sede in cui sembrava possibile affrontare con probabilità di successo i problemi
più- scottanti della gestione dell'economia, dell'istruzione, della formazione della
cultura operaia.
















