
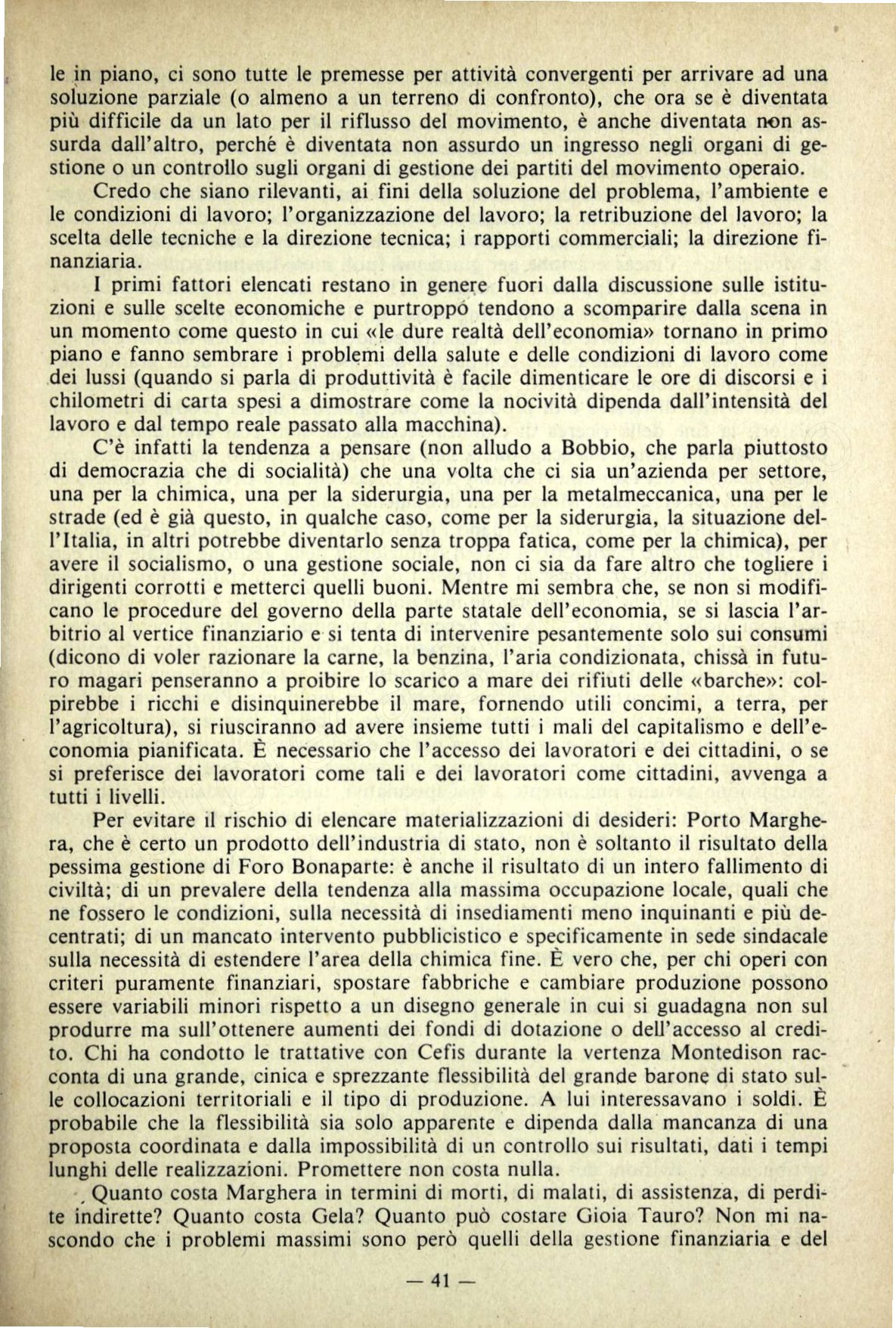
le in piano, ci sono tutte le premesse per attività convergenti per arrivare ad una
soluzione parziale (o almeno a un terreno di confronto), che ora se è diventata
più difficile da un lato per il riflusso del movimento, è anche diventata non as-
surda dall'altro, perché è diventata non assurdo un ingresso negli organi di ge-
stione o un controllo sugli organi di gestione dei partiti del movimento operaio.
Credo che siano rilevanti, ai fini della soluzione del problema, l'ambiente e
le condizioni di lavoro; l'organizzazione del lavoro; la retribuzione del lavoro; la
scelta delle tecniche e la direzione tecnica; i rapporti commerciali; la direzione fi-
nanziaria.
I primi fattori elencati restano in genere fuori dalla discussione sulle istitu-
zioni e sulle scelte economiche e purtroppó tendono a scomparire dalla scena in
unmomento come questo in cui «le dure realtà dell'economia» tornano in primo
piano e fanno sembrare i problemi della salute e delle condizioni di lavoro come
dei lussi (quando si parla di produttività è facile dimenticare le ore di discorsi e i
chilometri di carta spesi a dimostrare come la nocività dipenda dall'intensità del
lavoro e dal tempo reale passato alla macchina).
C'è infatti la tendenza a pensare (non alludo a Bobbio, che parla piuttosto
di democrazia che di socialità) che una volta che ci sia un'azienda per settore,
una per la chimica, una per la siderurgia, una per la metalmeccanica, una per le
strade (ed è già questo, in qualche caso, come per la siderurgia, la situazione del-
l'Italia, in altri potrebbe diventarlo senza troppa fatica, come per la chimica), per
avere il socialismo, o una gestione sociale, non ci sia da fare altro che togliere i
dirigenti corrotti e metterci quelli buoni. Mentre mi sembra che, se non si modifi-
cano le procedure del governo della parte statale dell'economia, se si lascia l'ar-
bitrio al vertice finanziario e si tenta di intervenire pesantemente solo sui consumi
(dicono di voler razionare la carne, la benzina, l'aria condizionata, chissà in futu-
romagari penseranno a proibire lo scarico a mare dei rifiuti delle «barche»: col-
pirebbe i ricchi e disinquinerebbe il mare, fornendo utili concimi, a terra, per
l'agricoltura), si riusciranno ad avere insieme tutti i mali del capitalismo e dell'e-
conomia pianificata. È necessario che l'accesso dei lavoratori e dei cittadini, o se
si preferisce dei lavoratori come tali e dei lavoratori come cittadini, avvenga a
tutti i livelli.
Per evitare il rischio di elencare materializzazioni di desideri: Porto Marghe-
ra, che è certo un prodotto dell'industria di stato, non è soltanto il risultato della
pessimagestione di Foro Bonaparte: è anche il risultato di un intero fallimento di
civiltà; di un prevalere della tendenza alla massima occupazione locale, quali che
nefossero le condizioni, sulla necessità di insediamenti meno inquinanti e più de-
centrati; di un mancato intervento pubblicistico e specificamente in sede sindacale
sullanecessità di estendere l'area della chimica fine. È vero che, per chi operi con
criteri puramente finanziari, spostare fabbriche e cambiare produzione possono
essere variabili minori rispetto a un disegno generale in cui si guadagna non sul
produrre ma sull'ottenere aumenti dei fondi di dotazione o dell'accesso al credi-
to. Chi ha condotto le trattative con Cefis durante la vertenza Montedison rac-
conta di una grande, cinica e sprezzante flessibilità del grande barone di stato sul-
le collocazioni territoriali e il tipo di produzione. A lui interessavano i soldi. È
probabile che la flessibilità sia solo apparente e dipenda dalla mancanza di una
proposta coordinata e dalla impossibilità di un controllo sui risultati, dati i tempi
lunghi delle realizzazioni. Promettere non costa nulla.
,Quanto costa Marghera in termini di morti, di malati, di assistenza, di perdi-
te indirette? Quanto costa Gela? Quanto può costare Gioia Tauro? Non mi na-
scondo che i problemi massimi sono però quelli della gestione finanziaria e del
—41 —
















